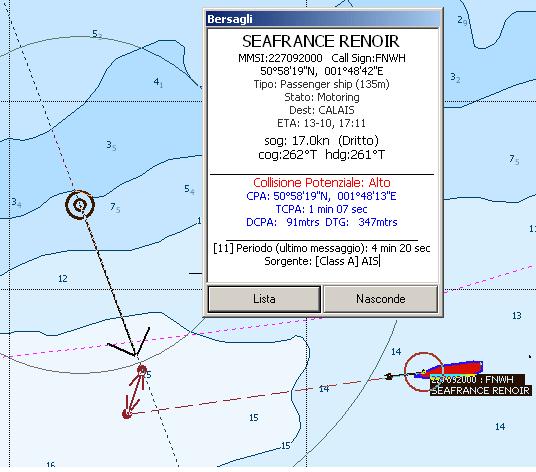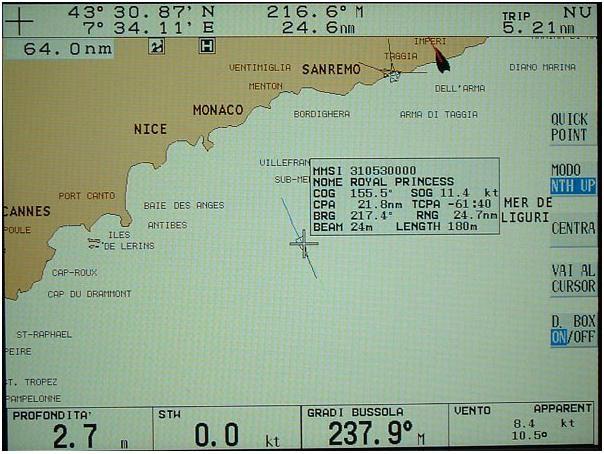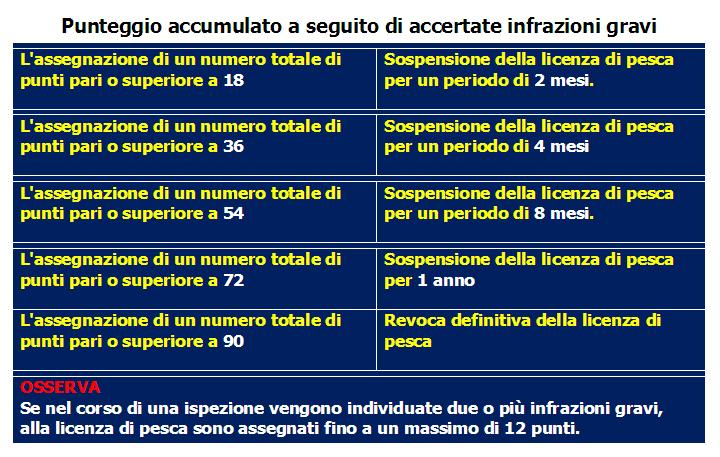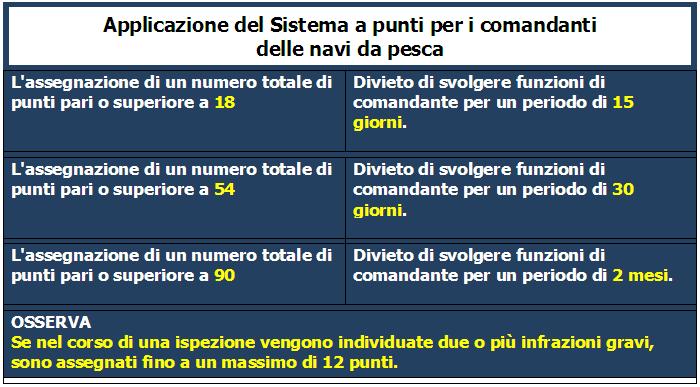Vigilanza pesca e tutela del consumatore
Il nostro Paese vanta una vocazione naturale per le attività legate al mare come la pesca, con la sua storia e le sue tradizioni. Ma le risorse marine viventi devono essere gestite con attenzione, nell’ottica di assicurarne la disponibilità per le future generazioni, cose da garantire uno sviluppo sostenibile per il settore. Il mare va protetto da un eccessivo sforzo di pesca, così come dagli impatti negativi che scaturiscono da altre attività umane, in modo che la sua ricchezza possa costituire un patrimonio accessibile a tutti.
Il controllo sull'ordinato svolgimento della pesca marittima richiede, oltre alla perfetta conoscenza delle norme comunitarie e nazionali, anche quella della normativa ad esse connesse (Codice della navigazione, sicurezza della navigazione, norme a tutela degli equipaggi, norme igienico sanitari, disciplina sul commercio dei prodotti ittici, ecc.). Di qui l'esigenza avvertita dal legislatore di affidare il coordinamento di detta attività al “Corpo delle Capitanerie di Porto”[1], struttura radicata e capillarmente diffusa lungo gli oltre 8.000 Km di costa.
A seguito dell’abrogazione della Legge n. 963/1965 e l’entrata in vigore del Decreto legislativo 19 gennaio 2012, n. 4 (come modificato dall’art. 39 – Capo VIII della Legge 28 luglio 2016, n. 154 sulle disposizioni in materia di pesca e acquacoltura) che ha introdotto nuove disposizioni applicative della normativa europea inserita nei regolamenti 1224/2009 e 404/2011 oltre ad un riassetto generale della materia con l’armonizzazione del sistema sanzionatorio, l’attività di controllo sulla pesca, sul commercio e sulla somministrazione dei prodotti di essa, nonché l’accertamento delle infrazioni che li riguardano (art. 22, comma 3) sono affidati, al personale delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, che, in quanto incaricati del controllo sulla pesca marittima, possono accedere in ogni momento presso le navi, i galleggianti, gli stabilimenti di pesca, i luoghi di deposito e di vendita, commercializzazione e somministrazione e presso i mezzi di trasporto dei prodotti della pesca, al fine di accertare l'osservanza delle norme sulla disciplina della pesca (art. 22 comma 7).
Va aggiunto che, a seguito del varo della politica comune della pesca, gli Stati dell'Unione Europea hanno avvertito l'esigenza di individuare in ogni Stato aderente un soggetto qualificato a cui tutti gli organi preposti al controllo della filiera della pesca devono fare riferimento, dando vita, in tal modo, alla istituzione di “Centri di Controllo Pesca Nazionali”. Il Centro Controllo Nazionale Pesca (CCNP) è stato costituito in attuazione del Regolamento CE 1489/97 della Commissione del 29/07/1997, recante le modalità di applicazione del Regolamento CEE 2847/93 (Abrogato) del Consiglio sui sistemi di controllo dei pescherecci via satellite. Compito del CCNP, secondo quanto previsto dal DPR 9 ottobre 1998 n. 424, è la sorveglianza sullo sforzo di pesca e sulle attività economiche connesse. Detta attività è rivolta nei confronti dei pescherecci battenti bandiera italiana (a prescindere dalle acque nelle quali essi operano o dal porto in cui fanno scalo) e nei confronti delle unità da pesca appartenenti a Stati membri, nonché di quelle appartenenti a Paesi non facenti parte dell'Unione Europea, quando operano in acque comunitarie.
In definitiva, l'Italia, con il suindicato DPR 424/98 ha designato quale Autorità di controllo il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ed ha predisposto a tal fine strutture, impianti e programmi informatici che consentono, a partire dal nuovo anno, la radiolocalizzazione in tempo reale dei pescherecci di lunghezza superiore a 18 metri a mezzo blue boxes (ferma la possibilità per le unità di minore lunghezza di dotarsi volontariamente di tale apparecchiatura).
.png)
Attività di vigilanza e controllo svolta dal personale del Corpo
[1] [1] Sotto la direzione del Comandante della Capitaneria di Porto, sono preposti alla vigilanza pesca altresì:
- il personale civile e militare della Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ex Mimerc);
- le Guardie di Finanza;
- i Carabinieri;
- gli Agenti di pubblica sicurezza:
- gli Agenti giurati
Sistema di controllo satellitare per la localizzazione dei pescherecci: SCP
Il Reg CE n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 ed il Reg. di esecuzione (UE) n. 404/2011 dell’8 aprile 2011, stabiliscono disposizioni dettagliate per quanto concerne le modalità di gestione e controllo della flotta comunitaria e delle navi di paesi terzi che operano in acque comunitarie attraverso gli impianti di localizzazione satellitare (Blue Box), al fine di sorvegliare efficacemente le attività di pesca esercitate dai pescherecci ovunque si trovino, nonché le attività di pesca esercitate nelle loro acque.
In sintesi il Regolamento sul controllo, apartire dal 1° gennaio 2012, obbliga i pescherecci di "lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri e inferiore ai 15" ad installare a bordo un dispositivo pienamente funzionante che consenta la localizzazione satellitare e identificazione automatiche del peschereccio da parte del «sistema di controllo dei pescherecci via satellite» (SCP) che fornisce, a intervalli regolari, alle Autorità di pesca i dati relativi alla posizione, alla rotta e alla velocità dei pescherecci.
Gli Stati membri possono «esentare» (art. 9, paragrafo 5 ) i pescherecci comunitari di "lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri" battenti la loro bandiera dall’obbligo di dotarsi del sistema di controllo dei pescherecci se:
- operano esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato membro di bandiera;
- non trascorrono mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto (=bordata).
Tale dispositivo consente il rilevamento del peschereccio da parte del Centro di Controllo della pesca dello Stato membro di bandiera (CCPN), la cui funzione è di sorvegliare le attività di pesca e lo sforzo di pesca. Il centro di controllo della pesca di un determinato Stato membro sorveglia i pescherecci battenti la bandiera di tale Stato membro, indipendentemente dalle acque nelle quali essi operano o dal porto nel quale si trovano, nonché i pescherecci comunitari battenti la bandiera di altri Stati membri e quelli dei paesi terzi cui si applica un sistema di controllo dei pescherecci operanti nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizionedello Stato membro in questione.
I pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri e le navi appartenenti a paesi terzi, che operano nelle acque comunitarie, impegnate in «attività accessorie» alla pesca hanno l’obbligo di installare a bordo un dispositivo pienamente funzionante che ne consenta la localizzazione e l’identificazione automatica da parte del “Sistema di controllo dei pescherecci” grazie alla trasmissione a intervalli regolari di dati relativi alla loro posizione, effettuata secondo le stesse modalità seguite dai pescherecci comunitari. Tali dati dovranno essere trasmessi e rilevati ogni ora. Responsabile del corretto funzionamento della Blue Box è il comandante del peschereccio.
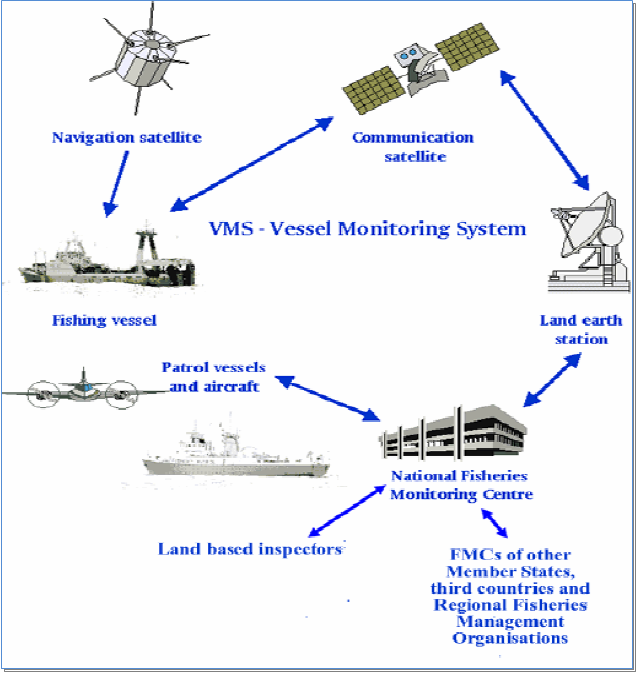
Sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS)
(DM 10 /11/2004)
Approfomdimenti
Il Sistema di Controllo Satellitare Pesca (SCP) è un sistema di localizzazione e controllo delle navi da pesca nazionali basato sull'utilizzazione di tecnologie satellitari.
Il sistema SCP consente il monitoraggio dei pescherecci aventi lunghezza fuori tutta pari o superiore a 12 metri e inferiore a 15 metri in termini di posizione, rotta e velocità, nonché di archiviare e gestire le relative informazioni, di rappresentare lo scenario su idoneo sistema cartografico di presentazione.
Le unità da pesca sono state dotate di un apposito apparato di bordo (c.d. "Blue Box"), attivato all'interno della rete di trasmissione satellitare «Inmarsat», che consente di trasmettere al Centro di Controllo le informazioni relative alla posizione, velocità e rotta dell'imbarcazione, alle emergenze ed agli allarmi nonché di ricevere dal Centro i parametri necessari alle impostazioni di funzionamento e di controllo. Il sistema SCP consente la ricezione e trasmissione dei dati tramite «Inmarsat-C», con l'archiviazione automatica dei messaggi in arrivo ed in partenza e la possibilità di interrogazione degli archivi storici:
- gestisce le informazioni anagrafiche della flotta peschereccia;
- gestisce le segnalazioni di allarme ricevute tramite i rapporti di emergenza, di anomalia dei sistemi di bordo e di infrazioni;
- rappresenta su video grafico le posizioni delle imbarcazioni;
- effettua statistiche sugli allarmi ricevuti e sullo sforzo di pesca.
La struttura tecnico/informatica e di localizzazione pescherecci che costituisce il sistema SCP (Sistema di Controllo Pesca) comprende:
- Sistema di bordo;
- Un Centro di Coordinamento Nazionale Pescherecci (CCNP);
- 14 Centri di Controllo di Area dei Pescherecci (CCAP);
- La rete terrestre di comunicazioni;
- Il collegamento satellitare bidirezionale tra il sistema di bordo ed il CCNP.
Il sistema di bordo (Blue Box)
La Blue-Box costituisce il sottosistema del «sistema VMS» (Vessel Monitoring System) e garantisce sia la localizzazione continua del peschereccio, che il suo uso da parte del comandante per l'invio degli "Effort Report" (messaggi di servizio da inviare all'uscita e rientro dai porti e dalle zone di pesca). Il sistema radio è di tipo omologato per installazioni su naqvi da pescxa (secondo la normativa vigente) e utilizza frequenze adibite alle telecomunicazioni marittime.
Il Centro di Coordinamento Nazionale dei Pescherecci (CCNP)
E' l'unità centrale in cui sono presenti tutti i database rientranti nella normativa ed è il mezzo di raccolta e supervisione su cui vengono inviate e visualizzate tutte le informazioni di posizione e di entrata/uscita dai porti e dalle zone di pesca protette. Qualora un peschereccio battente bandiera italiana si avvicini o entri in acque territoriali di altro Stato costiero della comunità europea, il CCNP invierà, in formato elettronico, tutte le informazioni relative a quel peschereccio al CCP dello stato membro in questione. Anche ogni Sistema di Controllo Pescherecci (SCP) di altri paesi membri, invierà al CCNP Italiano le informazioni, in formato elettronico, relative ai pescherecci registrati presso la loro nazione e che temporaneamente si trovano in acque territoriali italiane.
I Centri di Controllo di Area dei Pescherecci (CCAP)
Sono unità elaborative dislocate su quattordici centri territoriali italiani (Direzioni Marittime) che, collegate con l'unità centrale del CCNP, permettono di gestire le informazioni riguardanti i pescherecci che navigano nelle loro zone di competenza o su cui stanno effettuando i controlli.I CCAP sono: Genova, Livorno, Napoli, Reggio, Calabria, Bari, Ancona, Ravenna, Venezia, Trieste, Catania, Palermo, Cagliari, Pescara, Olbia.
La rete terrestre di comunicazioni
E' l'insieme delle linee che collegano tra di loro:
- CCNP - Centro Coordinamento Nazionale dei Pescherecci
- CCAP - Centri di Controllo di Area Pescherecci
- SCP - Sistemi di Controllo Pesca - di altri Paesi
- la gateway satellitare.
Il collegamento satellitare
Il collegamento satellitare bidirezionale tra il sistema di bordo e il CCNP, è la gateway satellitare che permette di scambiare i messaggi tra il sistema di bordo e il CCNP.
Sistema di controllo dei pescherecci: obbligatorietà del dispositivo di localizzazione via satellite
Le tecnologie moderne, quali il sistema di controllo dei pescherecci (VMS) e il sistema di identificazione automatica (AIS), consentono agli Stati dell’Unione di effettuare un monitoraggio efficace e controlli incrociati sistematici e automatizzati in modo rapido, facilitando le procedure amministrative sia per le Autorità nazionali che per gli operatori, consentendo in tal modo di realizzare in tempo utile analisi dei rischi e valutazioni globali di tutte le informazioni pertinenti relative al controllo. Il regime di controllo dovrebbe dunque permettere agli Stati membri di combinare l’utilizzo dei diversi strumenti di controllo al fine di garantire la massima efficacia del metodo di controllo.
A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento sul controllo (=Reg.CE n. 1224/2009), gli Stati membri obbligano i comandanti delle navi da pesca a utilizzare un sistema di controllo dei pescherecci via satellite al fine di sorvegliare efficacemente le attività di pesca esercitate dai loro pescherecci ovunque si trovino, nonché le attività di pesca esercitate nelle acque nazionali
È opportuno redigere per tale sistema delle «specifiche» comuni a livello dell'Unione europea. Tali specifiche devono, in particolare, precisare:
- l’obbligatorietà del dispositivo di localizzazione via satellite;
- le caratteristiche degli impianti di localizzazione;
- le responsabilità dei comandanti relative al funzionamento dei dispositivi di localizzazione;
- le modalità di trasmissione dei dati relativi alla posizione e le norme in caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento degli impianti di localizzazione via satellite.
Ciò premesso, l’art. 18, CAPO IV del Reg. di esecuzione (UE) n. 4040/2011 del Consiglio, obbliga i pescherecci dell'Unione soggetti al VMS, ad eccezione di quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'acquacoltura, di non lasciare il porto se non sono provvisti del dispositivo di localizzazione via satellite (VMS) pienamente funzionante installato a bordo.
Peraltro, quando un peschereccio dell'Unione è ormeggiato in porto, il dispositivo di localizzazione via satellite deve essere disinserito soltanto nei seguenti casi:
- previa notifica inviata al Centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato membro di bandiera e al CCP dello Stato membro costiero;
- a condizione che la comunicazione successiva indichi che il peschereccio dell'Unione non ha cambiato posizione rispetto alla comunicazione precedente.
Le Autorità competenti dello Stato membro di bandiera possono consentire che la «notifica preventiva»sia sostituita da un messaggio automatico VMS o da un allarme generato dal sistema, che indichi la presenza del peschereccio in una zona geografica predefinita del porto.
- Caratteristiche dei dispositivi di localizzazione via satellite
I dispositivi di localizzazione via satellite (Blue Box) installati a bordo dei pescherecci dell'Unione devono garantire, a intervalli regolari, la trasmissione automatica dei seguenti dati al Centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato membro di bandiera:
- identificazione del peschereccio;
- ultima posizione geografica, con un margine di errore inferiore ai 500 metri ed un margine di affidabilità del 99 %;
- data e ora (espressa in «tempo universale» o «UTC») in cui è stata rilevata detta posizione del peschereccio;
- velocità istantanea e rotta del peschereccio.
Gli Stati membri devono vigilare affinché i dispositivi di localizzazione via satellite non consentano la registrazione o la trasmissione di posizioni false e non possano essere alterati manualmente.
Responsabilità dei comandanti relative ai dispositivi di localizzazione via satellite
I comandanti dei pescherecci dell'Unione provvedono affinché i dispositivi di localizzazione via satellite siano perfettamente funzionanti in qualsiasi momento al fine di garantire la trasmissione automatica, a intervalli regolari, le informazioni al Centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato membro di bandiera:
In particolare provvedono affinché:
- i dati non siano alterati in alcun modo;
- l'antenna o le antenne collegate all'impianto di localizzazione via satellite non siano ostruite, scollegate o bloccate in alcun modo;
- l'alimentazione elettrica dell'impianto di localizzazione via satellite non sia mai interrotta;
- il dispositivo di localizzazione via satellite non sia asportato dal peschereccio.
È vietato distruggere, danneggiare, disattivare o comunque manomettere l'impianto di localizzazione via satellite a meno che le autorità competenti dello Stato membro di bandiera non ne abbiano autorizzato la riparazione o la sostituzione (art. 10 comma 1 lettera m) e art. 11 comma 1 D.lgs. n. 4/2012).
- Misure di controllo incombenti agli Stati membri di bandiera
Gli Stati membri di bandiera provvedonpo al controllo e alla sorveglianza continui e sistematici dell'esattezza dei dati trasmessi dai dispositivi di localizzazione satellitare a bordo dei pescherecci e intervengono tempestivamente non appena constati dati inesatti o incompleti.
Frequenza di trasmissione dei dati
Ciascuno Stato membro provvede affinché il proprio CCP riceva attraverso il VMS, almeno una volta ogni due ore, le informazioni riguardanti i propri pescherecci e può richiedere alle proprie unità che la trasmissione avvenga ad intervalli più ravvicinati al fine di individuarne l'effettiva posizione. Cio permette, peraltro, al CCP dello Stato membro costiero di controllare, attraverso i dati VMS, la data e l'ora dell'entrata e dell'uscita dei suoi pescherecci:
- da tutte le zone marittime soggette a norme specifiche di accesso alle acque e alle risorse;
- dalle zone di restrizione della pesca di cui all'articolo 50 del regolamento sul controllo[1];
- dalle zone di regolamentazione delle organizzazioni regionali per la pesca cui aderiscono l'Unione europea o taluni Stati membri;
- dalle acque soggette alla sovranità e alla giurisdizione di paesi terzi.
- Trasmissione dei dati allo Stato membro costiero
Il VMS adottato da ciascuno Stato membro garantisce la trasmissione automatica al CCP dello Stato membro costiero delle informazioni di cui all’art. 19 comma 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 4/2011 con riguardo ai pescherecci di bandiera mentre essi si trovano nelle acque di uno Stato membro costiero. Tali dati sono trasmessi simultaneamente al CCP dello Stato membro di bandiera secondo il modello riportato nell'Allegato V.
Gli Stati membri costieri che esercitano il controllo congiunto in una determinata zona possono precisare una destinazione comune per la trasmissione delle sopra citate informazioni e ne informano la Commissione e gli altri Stati membri. Ciascuno Stato membro trasmette agli altri Stati membri e alla Commissione un elenco esaustivo delle coordinate latitudinali e longitudinali che delimitano la propria zona economica esclusiva (ZEE) o la propria zona di pesca esclusiva, in un formato, ove possibile elettronico, compatibile con il World Geodetic System 1984 (WGS-84). E’ cura inoltre dello Stato membro, comunicare agli altri Stati membri e alla Commissione ogni eventuale modifica di queste coordinate. In alternativa, gli Stati membri possono pubblicare il suddetto elenco sul sito web di cui all'articolo 115 (Zona del sito web accessibile al pubblico), Capo III del regolamento sul controllo.
Gli Stati membri costieri garantiscono il coordinamento tra le loro autorità competenti ai fini della trasmissione dei dati VMS in conformità all'articolo 9, paragrafo 3[2], del regolamento sul controllo, anche mediante l'istituzione di apposite procedure chiare e documentate.
[1] Articolo 50 (Controllo delle zone di restrizione della pesca). Le attività di pesca esercitate dai pescherecci comunitari edai pescherecci di paesi terzi in zone di pesca in cui è stata stabilita dal Consiglio una zona di restrizione della pesca sono controllate dal centro di controllo della pesca dello Stato membrocostiero, che dispone di un sistema che gli consente di individuaree registrare l’entrata e il passaggio dei pescherecci nella zona direstrizione della pesca, nonché la loro uscita dalla medesima. La frequenza di trasmissione dei dati è pari ad almeno unavolta ogni 30 minuti quando un peschereccio entra in una zonadi restrizione della pesca. Il transito in una zona di restrizione della pesca è autorizzato per tutti i pescherecci che non sono autorizzati a pescare intali zone purché soddisfino le seguenti condizioni:
- tutti gli attrezzi a bordo sono fissati e stivati durante il transito;
- la velocità durante il transito non è inferiore a sei nodi, salvoin caso di forza maggiore o di condizioni sfavorevoli. In talicasi il comandante informa senza indugio il centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera, cheinforma successivamente le autorità competenti dello Statomembro costiero.
Il presente articolo si applica ai pescherecci comunitari e ai pescherecci di paesi terzi aventi una lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri.
[2] Quando un peschereccio si trova nelle acque di un altro Stato membro, lo Stato membro di bandiera mette a disposizione i dati del sistema di controllo dei pescherecci relativi al peschereccio in questione mediante una trasmissione automatica al centro di controllo della pesca degli Stati membri costieri. Su richiesta, i dati del sistema di controllo dei pescherecci sono inoltre messi a disposizione dello Stato membro nei porti del quale un peschereccio potrebbe sbarcare le proprie catture o nelle acque del quale è probabile che il peschereccio prosegua le proprie attività di pesca.
Guasto tecnico o non funzionamento del dispositivo di localizzazione via satellite
Qualora il dispositivo di localizzazione via satellite installato a bordo di un peschereccio dell'Unione risulta difettoso o non perfettamente funzionante, il comandante o il suo rappresentante, a partire dal momento in cui è stato rilevato il guasto o dal momento in cui sia stato informato del guasto tecnico o non funzionamento della Blue Box dalle Autorità competenti dello Stato membro di bandiera o, eventualmente, dello Stato membro costiero, comunica ogni quattro ore al CCP dello Stato membro di bandiera le coordinate geografiche aggiornate del peschereccio tramite un sistema di telecomunicazione adeguato. Gli Stati membri decidono in merito al sistema di telecomunicazione da utilizzare e lo indicano sul sito web di cui all'articolo 115, (Zona del sito web accessibile al pubblico)Capo III del regolamento sul controllo.
Il CCP dello Stato membro di bandiera inserisce senza indugio nella banca dati del VMS le posizioni geografiche aggiornate, non appena ricevute. I dati manuali del VMS devono essere chiaramente distinguibili dai messaggi automatici all'interno di una banca dati. Ove del caso, tali dati del VMS manuali devono essere trasmessi senza indugio agli Stati membri costieri.
Un peschereccio dell'Unione non può salpare dal porto, quando si è verificata una situazione di guasto tecnico o di non funzionamento del dispositivo di localizzazione via satellite, finché le Autorità competenti dello Stato di bandiera non abbiano constatato che il dispositivo di localizzazione via satellite installato a bordo funziona perfettamente. In deroga a questo principio, il CCP dello Stato membro di bandiera può autorizzare i propri pescherecci a lasciare il porto con un dispositivo di localizzazione via satellite non funzionante ai fini della sua riparazione o sostituzione. L'asportazione dell'impianto a tal fine è soggetta all'approvazione delle Autorità competenti dello Stato membro di bandiera
- Mancata ricezione dei dati
Se durante dodici ore consecutive, il CCp dello Stato membro di bandiera non riceve dati VMS (almeno una volta ogni due ore) o non gli vengono comunicate, in caso di guasto tecnico o non funzionamento del dispositivo di localizzzaione satellitare, le coordinate geografiche aggiornate del peschereccio, tramite un sistema di telecomunicazione adeguato, almeno ogni quattro ore, ne informa quanto prima il comandante o l'operatore del peschereccio dell'Unione o il suo rappresentante.
Se, per uno stesso peschereccio dell'Unione, il fatto si ripete più di tre volte nell'arco di un anno, lo Stato membro di bandiera procede all'accurato controllo dell'impianto di localizzazione via satellite del peschereccio. Esso dispone inoltre un'indagine per accertare se l'apparecchiatura sia stata manomessa.
In deroga all'articolo 20, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, l'apparecchiatura può essere asportata dal peschereccio per essere esaminata.
Se durante dodici ore non riceve dati VMS per una delle ragioni suindicate, e l'ultima posizione ricevuta era all'interno delle acque territoriali di uno Stato membro, il CCP dello Stato membro di bandiera ne informa quanto prima il CCP dello Stato membro costiero di cui trattasi.
Le Autorità competenti dello Stato membro costiero, qualora rilevino la presenza di un peschereccio dell'Unione nelle proprie acque territoriali e non abbiano ricevuto dati VMS, ne informano il comandante del peschereccio e il CCP dello Stato di bandiera.
- Controllo e registrazione delle attività di pesca
Gli Stati membri utilizzano i dati VMS ai fini del controllo efficace delle attività di pesca dei pescherecci dell’Unione. Gli Stati membri di bandiera, in particolare:
- garantiscono che i dati VMS pervenuti siano registrati su supporto informatico e conservati in modo sicuro in banche dati informatizzate per almeno tre anni;
- adottano tutte le misure idonee a garantire l'utilizzo di tali dati esclusivamente per scopi ufficiali;
- adottano tutte le misure tecniche necessarie per proteggere i dati suddetti contro ogni distruzione accidentale o illecita e ogni perdita accidentale, deterioramento, diffusione o consultazione non autorizzata.
Sistema di Identificazione Automatica: A.I.S.
A norma dell’Allegato II, Parte I, punto 3, della direttiva 2002/59/CE, i pescherecci di "lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri" hanno l’obbligo di dotarsi di un «Sistema di Identificazione Automatica» (AIS) di cui assicurano il corretto funzionamento e che rispetta le norme direndimento stabilite dall’Organizzazione marittima internazionale conformemente al Capitolo V, regola 19, sezione 2.4.5, della convenzione SOLAS del 1974.2.
- Tale disposizione si applica:
- a decorrere dal 31 maggio 2014 per i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15 metri e inferiore a 18 metri;
- a decorrere dal 31 maggio 2013 per i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 18 metri e inferiore a 24 metri;
- a decorrere dal 31 maggio 2012 per i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri e inferiore a 45 metri.
Gli Stati membri possono utilizzare e consentire l’accesso ai dati del sistema di identificazione automatica (AIS), ove disponibili, ai fini della verifica incrociata con altri dati disponibili conformemente agli articoli 109 e 110 (giornale di bordo sulle attività di pesca; documenti di trasporto e note di vendita; dati provenienti dalle Licenze di pesca e dalle autorizzazione di pesca; dati provenienti dai rapporti di ispezione; dati sulla potenza del motore, ecc.)
A tal fine gli Stati membri provvedono affinché idati del sistema di identificazione automatica per i pescherecci battenti la loro bandiera siano messi a disposizione delle loro Autorità nazionali responsabili del controllo della pesca. I dati provenienti dal sistema di controllo dei pescherecci, dal sistema di identificazione automatica e dal sistema di rilevamento delle navi possono essere trasmessi alle agenzie comunitarie e alle autorità competenti degli Stati membri impegnate in operazioni di sorveglianza ai fini della sicurezza e della protezione marittima, del controllo delle frontiere, della tutela dell’ambiente marino e dell’applicazione generale della legge.
Approfondimenti:
L’ AIS è un sistema automatico di tracciamento adottato obbligatoriamente, a partire da un certo tonnellaggio, dalle navi commerciali, e facoltativamente dalle unità da diporto[1]. Attraverso una apparecchiatura elettronica montata sull’unità, vengono trasmessi i propri dati identificativi attraverso un sistema VHF predefinito, analogamente a quanto accade sugli aerei con il transponder, allo scopo di permettere ad ogni unità in navigazione di visualizzare in tempo reale i dati identificativi del traffico navale attorno a sè, onde evitare rischi di collisione con altre navi in base alle reciproche rotte e velocità e di consentire alle Autorità marittime di monitorare i movimenti delle navi medesime. Le informazioni fornite dal trasponder AIS delle unità in transito, (quali: nome della unità, codice MMSI, latitudine e longitudine, velocità, rotta, condizioni/attività e altre informazioni), possono essere visualizzate su uno schermo o un ECDIS.
L'AIS integra un ricetrasmettitore VHF standardizzato con un sistema di posizionamento come un LORAN o un ricevitore GPS, con altri sensori elettronici di navigazione, quali ad esempio una girobussola. Le navi al di fuori della copertura radio dell' AIS possono essere monitorati con il sistema di identificazione e tracciamento a lungo raggio (LRIT).
L' IMO (Organizzazione marittima Internazionale) e la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Cap. V, regola 19, sezione 2.4.5 SOLAS edl 1974) richiede che l'AIS siano montati a bordo di tutte le navi commerciali con stazza lorda superiore a 300 tonnellate, e su tutte le navi passeggeri, indipendentemente dalle dimensioni, nonché dalle piattaforme.
Secondo le norme internazionali ITU che hanno stabilito il protocollo, dal trasponder AIS dell'unità in transito, vengono trasmessi continuamente queste informazioni:
- nome dell'unità
- codice MMSI
- latitudine e longitudine
- velocità
- rotta
- condizioni/attività
-
altre informazioni
[1] [2] [2] [2] Mentre il naviglio commerciale ha l'obbligo di installare esclusivamente un rice-trasmettitore ("Trasponder" ), le unità da diporto entro 24m possono scegliere di installare un trasponder o il solo ricevitore.Nel 2007 è stato introdotto sul mercato l'AIS Classe B che ha permesso una nuova generazione di ricetrasmettitori a basso costo AIS rendendo appetibile per qualunque unità l'uso di questo strumento.
Schema: attivazione di un bersaglio AIS
Attivazione di un bersaglio AIS
Analizzando la schermata nel dettaglio osserviamo che:
- la nostra nave (identificata dalla sagoma scura di uno scafo) è all’ormeggio nel Marina di Aregai.
- sono presenti tre bersagli AIS (sagome chiare di scafo) nel porto di Sanremo
- è presente un bersaglio AIS attivo a sud/est di Montecarlo
L’attivazione di un bersaglio AIS avviene andandoci semplicemente sopra con il cursore, in questo modo si apre una finestra con i principali dati identificativi, vediamoli nel dettaglio:
- Dati identificativi della nave
- Codice MMSI
- Nome: Royal Princess
- Beam (larghezza): 24 metri
- Lenght (lunghezza): 180 metri
In realtà il sistema AIS fornisce anche altri dati (tipologia di nave, porto di partenza, porto di destinazione, ora presunta di arrivo alla destinazione, ecc.) che possono essere o meno visualizzati dall’unità ricevente in base alle configurazioni software.
Le coordinate geografiche (latitudine e longitudine) della nave non vengono indicate in maniera esplicita perché il bersaglio viene posizionato direttamente sulla carta elettronica nella posizione indicata.
- Dati di navigazione
- COG (course over ground) è la rotta vera, rispetto il fondo, fornita dal GPS a bordo della nave: 155,5°
- SOG (speed over ground) è la velocità effettiva, rispetto il fondo: 11,4 nodi
- Dati di rilevamento
- BRG (bearing) è il rilevamento vero della nave dalla nostra posizione: 217,4°
- RNG (range) è la distanza tra noi e la nave: 24,7 miglia
Dati di pericolo collisione, sono la funzionalità più interessante del sistema e necessitano di un piccolo approfondimento.
CPA (closest point of approach) è la distanza minima a cui ci troveremo dal bersaglio se lui manterrà l’attuale rotta e velocità (e se noi ovviamente manterremo le nostre)
Nel caso dell’esempio la distanza minima sarà di 21,8 miglia
TCPA (Time to CPA) è il tempo previsto per giungere al punto di minore distanza.
Nel caso dell’esempio è negativo in quanto abbiamo già superato il punto di massima vicinanza. Inoltre questo esempio è poco significativo in quanto la nostra barca era all’ormeggio e non in navigazione. E’ molto utile invece in navigazione perché ci permette di stabilire subito se una nave è potenzialmente pericolosa (CPA inferiori alle 2 miglia o meno) e quanto tempo abbiamo prima di rischiare una collisione.
Molti software permettono anche di impostare allarmi che si attivano solo se la CPA o la TCPA scende sotto un valore da noi impostato.
E’ importante però chiarire che questi strumenti sono solo di ausilio alla navigazione e risentono fortemente della precisione dei dati forniti. Un errore od una instabilità della nostra (o del bersaglio) rotta e/o velocità (dovuto magari ad una scarsa copertura del segnale GPS) può causare grandi variazioni del CPA e/o TCPA, rischiando di non indicarci situazioni potenzialmente pericolose. Come tutti gli ausili alla navigazione possono risultare molto comodi, ma non bisogna cadere nella tentazione di affidarsi completamente a loro, come se navigare fosse un videogioco.
Per ultimo, ma non ultima come utilità, il sistema AIS ci permette di conoscere sia l’MMSI che il nome della nave, in questo modo ci sarà molto più facile contattare la nave via VHF in caso di potenziale pericolo, sia con una chiamata individuale se il nostro apparato è fornito di DSC che con una chiamata in fonia sul canale 16.
Pesca illegale
Il fenomeno comunemente individuato come “pesca illegale” presenta aspetti variegati e molteplicità di tipologie relative agli attrezzi di cattura, al mancato rispetto delle norme, al prelievo eccessivo di esemplari sotto taglia, al prelievo di specie tutelate.
Le più comuni pratiche di pesca illegali denunciate dagli operatori stessi o rilevate dalle Autorità marittime, possono essere riassunte come segue:
- Utilizzo di reti con maglie vietate: questo consente di catturare esemplari di taglia inferiore al consentito che risultano però di scarso valore commerciale e producono quindi un doppio danno: quello di impoverire gli stock di potenziali riproduttori e, dal punto di vista economico, la sottrazione di risorsa che potrebbe acquisire valore commerciale se immessa sul mercato nelle taglie consentite.
- Strascico sotto costa: la pesca a strascico è consentita oltre le tre miglia dalla costa o su fondali profondi oltre i 50 metri. Se, inoltre, la pesca è esercitata nel rispetto delle norme, ovvero su fondali sabbiosi o fangosi, risulta una pratica non distruttiva e sostenibile. Al contrario risulta estremamente dannosa se praticata entro le tre miglia, su bassi fondali, su fondi rocciosi e sulla posidonia, in quanto oltre a danneggiare il fondo distrugge le aree di riproduzione e rischia di catturare le forme giovanili che si sviluppano sotto costa. In questo caso tale pratica risulta conflittuale con la piccola pesca non solo per le catture che le vengono sottratte, ma anche per i danni che procura alle attrezzature da posta.
- Pesca pseudo-sportiva: esistono migliaia di pescatori che operano al di fuori di qualsiasi norma. Si definiscono sportivi, ma in realtà non hanno nulla a che fare con chi pratica la pesca per sport nel tempo libero, né con i pescatori professionisti che lavorano con licenze specifiche: operano con attrezzi professionali, vendono il pescato, ma non hanno licenze professionali, non rispettano normative sanitarie e non pagano tasse.
-
Pesca dei datteri: i datteri di mare (Litophaga litophaga) sono molluschi che vivono nelle rocce calcaree. La pesca del dattero è vietata in Italia sin dal 1988, ma vengono ugualmente catturati distruggendo le scogliere con picconi, scalpelli e addirittura martelli pneumatici.
Un dattero raggiunge i 5 cm dopo 20 anni e un datteraio professionista riesce a prelevare fino a 25 Kg di datteri in un giorno, provocando la desertificazione di 4-6 Km di costa ogni anno.
Esistono inoltre altre pratiche di pesca illegali come la pesca con gli esplosivi e le sostanze venefiche, ma qui si entra in un altro ambito, ovvero quello della delinquenza e le pratiche criminali che attentano al patrimonio ambientale alla stregua dei piromani che ogni anno distruggono migliaia di ettari boschi o sversano reflui inquinanti nei corsi d’acqua senza alcun processo di depurazione. In questo caso non è nemmeno corretto parlare di “pesca”.
.png)
Sequestro di datteri di mare (Litophaga litophaga)
Tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca: sistema sanzionatorio
Un aspetto fondamentale da tenere in considerazione per garantire una gestione efficace delle risorse è appunto la tutela delle specie ittiche e di conseguenza dell’attività di pesca. A tale scopo sono state introdotte delle limitazioni sia per le taglie minime degli esemplari sia per le caratteristiche degli strumenti da pesca. In ambito nazionale questi vincoli erano stati individuati, principalmente dalla abrogata Legge 963 del 1965 (legge quadro sulla pesca marittima) e dal relativo Regolamento di attuazione D.P.R. 1639/68 (ancora jn vigore). Essendo piuttosto datata la predetta normativa, per rendere più competitivo il settore della pesca, è stato emanato il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96”. (GU n. 26 del 1-2-2012) che ha abrogato con l’articolo 27 la legge quadro, nonché l’articolo 7 del D.P.R. n.1639/1968 (classi di pesca), del tutto riformando l’impianto originario della disciplina del settore.
Il decreto in parola, in conformità ai principi e criteri direttivi di cui al comma 1 dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, ha provveduto al riordino, al coordinamento ed all'integrazione della normativa nazionale in materia di pesca ed acquacoltura, fatte salve le competenze regionali, al fine di dare corretta attuazione ai criteri ed agli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, nonché dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. L’art. 22, comma 3 del Decreto legislativo n. 4/2012[1] può essere definito il “biglietto da visita” durante l’attività di vigilanza pesca, in quanto affida in primis alle Capitanerie di Porto-Guardia Costuiera e quindi alle Forze di polizia, l’opera di sorveglianza sulla pesca ed il commercio dei prodotti ittici, mentre l’art. 22, comma 7 costituisce il “lasciapassare” in quanto permette al personale incaricato della vigilanza ampio margine di azione, non ponendo limiti né temporali né territoriali alle operazioni di controllo sull’osservanza delle norme sulla disciplina della pesca. I successivi articoli 8 e 9 riguardano, rispettivamente, le pene principali ed accessorie previste per i reati-contravvenzionali sulla pesca di cui all’articolo 7, alle quali si aggiungono con gli articoli 11 e 12 le sanzioni amministrative e accessorie previste, rispettivamente, per le violazioni amministrative di cui all’articolo 10 del predetto decreto.
Tra le modifiche sostanziali apportate dal D.lgs. n. 4/2012 c’è l’individuazione nel Comando Generale delle Capitanerie di Porto, nella veste di “Centro di Controllo Nazionale Pesca” (CCNP), quale Organo di coordinamento dell’attività di vigilanza pesca (art. 22, comma 2).
Importante ed innovativa in ambito sanzionatorio è stata apportata con l’art. 8 comma 3 del predetto decreto, che se da un lato con l’art. 7, secondo comma favorisce l’attività dei pescatori stabilendo la “non punibilità in caso di cattura accidentale o accessoria di specie ittiche al di sotto della taglia minima“, a condizione che sia stato pescato con attrezzi conformi alle norme comunitarie e nazionali autorizzati dalla Licenza di pesca e che non venga comunque detenuto a bordo, sbarcato, trasportato, trasbordato e commercializzato, dall’altro introduce [art. 9 comma 1 lettera d)] quale ulteriore “sanzione accessoria” in caso di commercializzazione o somministrazione di esemplari sottomisura la o di cui è vietata la cattura, la “sospensione dell’esercizio commerciale da 5 a 10 giorni”. Sarà quindi opportuno segnalare questa gravosa sanzione nella N.d.R. inviata al Pubblico Ministero per l’anzidetta violazione, in quanto spetterà poi al Giudice competente stabilire il quantum di pena, che seppur definita accessoria rischia di rappresentare il vero castigo per il contravventore.
Per quanto concerne il D.P.R. n. 1639/68, in attesa dell’emanazione di un Regolamento sull’esercizio della pesca e dell’acquacoltura che lo sostituirà a breve, sono tuttora valide ed applicabili le norme che stabiliscono dimensioni minime dei vari esemplari di pesci, crostacei e molluschi e quelle che descrivono le tipologie e le caratteristiche tecniche degli attrezzi da pesca. A proposito delle taglie minime di cattura, bisogna tenere presente che le dimensioni stabilite per le varie specie ittiche spesso non rappresentano la tipologia di esemplare adulto e pronto alla riproduzione, ma sono invece un compromesso tra la reale dimensione del prodotto al suo ultimo stadio di sviluppo e le esigenze commerciali che interessano la stessa specie.
Analogo discorso è valido per le dimensioni degli attrezzi da pesca ed in particolare per le dimensioni delle maglie delle reti: la difficoltà in questo caso sta nel fatto di dover individuare un’unica misura minima per la singola tipologia di rete anche se questa è destinata alla cattura di esemplari differenti, che tuttavia vivono nello stesso ambito di azione dell’attrezzo. Per questo motivo sono stati stabiliti dei coefficientiche se da una parte salvaguardano un certo esemplare, dall’altra permettono una buona probabilità di cattura di prodotti che per caratteristiche non hanno ancora raggiunto il livello di piena maturazione. Esperienza insegna che spesso sulle unità da pesca operanti in mare possono essere trovati attrezzi e strumenti non conformi alla normativa vigente ed in particolare non utilizzabili da questa stessa unità in quello specifico tratto di mare.
Tuttavia, anche se al momento del controllo non sia già materializzata una effettiva cattura di prodotto derivante dall’utilizzo di quel determinato strumento ugualmente può essere contestabile in violazione degli artt. 10 lett. b), 11comma 1 e 12 comma 1 D.lgs. n. 4/2012 per aver “esercitato la pesca in zone e tempi vietati” dalla normativa comunitaria e nazionale[2].
.png)
[1] [1] L'attività di controllo sulla pesca, sul commercio e sulla somministrazione dei prodotti di essa, nonchè l'accertamento delle infrazioni sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di Porto, al personale civile e militare dell'Autorità marittima centrale e periferica, alle Guardie di finanza, ai Carabinieri, agli Agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati di cui al comma 4. Ai soggetti di cui al comma 3, è riconosciuta, qualora già ad esse non competa, la «qualifica» di Ufficiali o Agenti di polizia giudiziaria, secondo le rispettive attribuzioni, ai fini della vigilanza sulla pesca ai sensi dell'articolo 55, ultimo comma, del codice di procedura penale (art. 22 comma.6)
[2] [3] Vedi Sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 12310/95 e successiva Sentenza n. 3445/01. E’ stato infatti sancito che “l’ambito della condotta vietata comprende non soltanto l’azione materiale“ attraverso la quale si compie la cattura degli esemplari marini, ma “anche quella preordinata a questo risultato, purché connotata dai requisiti della idoneità e della univocità, secondo quanto dispone l’art. 56 c.p. in tema di delitto tentato”. Ritenendo il Giudice quindi che l’attività preparatoria potesse essere ricondotta ad un atteggiamento univocamente preordinato alla cattura dei pesci, “ha equiparato l’attività prodromica alla vera e propria condotta vietata”. Non è stato quindi sanzionato il tentativo di pesca vietata, in quanto il “pescare” esprime un’attività diretta allo scopo non necessariamente conseguito da chi la realizza e tale attività, come era descritta dall’art. 1 delle Legge 963/65, ora abrogato, “comprende anche le operazioni tecniche finalizzate alla possibile ma non necessaria cattura di esemplari”.
Violazioni in materia di pesca (Capo II, art. 11 del D.lgs. N. 4/2012)
Dal 25 agosto 2016 sono ufficialmente entrate in vigore su tutto il territorio nazionale, le nuove regole che disciplinano il "sistema sanzionatorio" in materia di pesca.
Le novità più importanti introdotte dall'art. 39 della Legge n° 154/2016, che va a modificare il decreto legislativo n° 4/2012 (testo di riferimento sulla materia), riguardano la depenalizzazione del reato consistente nella detenzione, sbarco, trasbordo, trasporto e commercializzazione delle specie ittiche sottomisura (cosiddetto "novellame").
Occorre subito evidenziare come l’articolo 39 oltre a “depenalizzare” le citate fattispecie, ha operato una degradazione ad illecito amministrativo di una serie di condotte precedentemente qualificate come “reati contravvenzionali”.
Peraltro, continuano a mantenere, ad esempio, rilevanza penale le seguenti “condotte”:
- pesca delle specie di cui è sempre vietata la cattura (cetacei, tartarughe marine, datteri, ecc.);
- idanneggiamento delle acque marine con uso di materie esplodenti, di energia elettrica o di sostanze tossiche e la relativa raccolta e messa in commercio di pesci così intorpiditi, storditi o uccisi;
- esercizio della pesca in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati;
- sottrazione dell’oggetto della pesca di terzi.
Condotte (reati contravvenzionali) che sono punite con l’arresto da 2 (due) mesi a 2 (due) anni o con l’ammenda da 2.000 € a 12.000 € nonché con la sospensione dell'esercizio commerciale da 5 (cinque) a 10 (dieci) giorni, fermo restando la possibilità dell’Amministrazione di costituirsi parte civile nel giudizio penale ex art. 23 decreto legislativo n.4/2012.
Entrando nel merito delle nuove regole introdotte dalla normativa in questione, occorre evidenziare in particolare l’introduzione di:
- reato di pesca abusiva esercitata da pescherecci non battenti bandiera italiana in acque sottoposte alla nostra sovranità;
- possibilità di sospendere il certificato di iscrizione nel Registro dei pescatori ai soggetti che utilizzano nell’esercizio della pesca unità non iscritte (il che consente di contrastare il fenomeno della pesca abusiva di pescatori professionali che adoperano unità da diporto);
- raddoppio di tutte le sanzioni nel caso in cui determinate violazioni riguardino specie altamente migratorie (pesce spada e tonno rosso);
- inasprimento delle sanzioni pecuniarie per i pescatori non professionali che catturano quantitativi superiori a quelli consentiti;
Sicché il nuovo articolo 10, comma 2 del Decreto legislativo n. 4/2012, introduce tra gli “illeciti amministrativi” le seguenti condotte: detenere, sbarcare, trasbordare, trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione (per taglia minima si intendono le dimensioni di una specie acquatica marina viva, che tengano conto della crescita, al di sotto delle quali si applicano restrizioni o incentivi volti ad evitare la cattura dovuta all'attività di pesca). Illeciti che sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione dell'esercizio commerciale, la confisca del prodotto e degli attrezzi da pesca.
In particolare, la sanzione amministrativa risulta “graduata” in ragione del peso del prodotto detenuto:
- da 5 kg a 10 kg da 500 a 3.000 euro;
- da 10 kg a 50 kg da 2.000 a 12.000 euro e con la sospensione esercizio commerciale per 5 gg lavorativi;
- maggiore di 50 kg da 12.000 a 50.000 euro e con la sospensione esercizio commerciale per 10 giorni lavorativi.
Il tutto tenendo presente che i predetti importi sono “raddoppiati” nel caso in cui il prodotto sia il tonno rosso (Thunnus thynnus) e il pesce spada (Xiphias gladius) e che restano fermi i principi generali previsti dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 (in primis, la facoltà concessa al trasgressore del pagamento in misura ridotta, pari alla somma più favorevole tra il doppio del minimo e il terzo del massimo della sanzione edittale).
La norma neo introdotta prevede anche una riduzione a favore del trasgressore pari al 10% del peso rilevato ai soli fini della gradualità della sanzione.
- Ad esempio, in caso di accertamento a terra di detenzione di 5,5 kg di prodotto sotto misura sarà elevato un Verbale con sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro, consentendo al contravventore di effettuare un pagamento (p.m.r.) pari a 1.000 euro.
Ulteriore elemento da evidenziare è la previsione secondo la quale non è applicabile alcuna sanzione in caso di catture accidentali di esemplari sottomisura, qualora le stesse siano effettuate con attrezzi regolari (previsione già contemplata dall’art. 11, comma 7, del Decreto legislativo n.4/2012), fatte salve le specie soggette al cosiddetto “obbligo di sbarco” individuate nell’Allegato III del Regolamento Mediterraneo 1967/2006. Specie per le quali rimane il divieto di commercializzazione ai fini del consumo umano diretto e che devono essere obbligatoriamente sbarcate. Mentre l’obbligo di sbarco non trova applicazione per le specie di cui è sempre vietata la cattura e per quelle che è scientificamente dimostrato un alto tasso di sopravvivenza in caso di rigetto in mare (esempio: Venus spp-vongola).
Una disciplina particolare, anch’essa rimasta inalterata, regola la pesca del “rossetto” e del “cicerello” (specie ittiche di dimensioni molto ridotte che mantengono una piccola taglia anche in età adulta) il cui esercizio deve essere autorizzato dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.
Rimane parimenti vigente il divieto di pesca del novellame di “sarda” e “alice”, cd. bianchetto o sardella, inconsiderazione che sono, rispettivamente, novellame di alice e sarda
Quanto alle sanzioni riguardanti la “tracciabilità”, il nuovo sistema sanzionatorio è rimasto anch’esso invariato. Per tali condotte illecite sono previste delle sanzioni amministrative pecuniarie, in luogo di quelle penali, comprese tra 1.000 e 75.000 euro, che raddoppiano nel caso in cui le violazioni abbiano ad oggetto il tonno rosso ed il pesce spada, oltre alla sanzione accessoria della chiusura da cinque a dieci giorni dell'esercizio commerciale che ponga in vendita tali prodotti.
Dette sanzioni pecuniarie, saranno applicate in relazione alla gravità della violazione effettivamente commessa (quantità di prodotto ittico oggetto della condotta illecita).
- Ad esempio, un esercente che detiene 6 kg di triglie sotto misura, per un valore commerciale di circa 50 euro, rischia, una sanzione amministrativa pari a 5.000 euro, oltre alla sospensione dell’esercizio commerciale da cinque a dieci giorni. Parimenti, per quel che concerne la pesca sportiva/ricreativa, rischia la sospensione dell’esercizio commerciale da 5 a 10 giorni il ristoratore che acquista prodotto ittico proveniente da tale pesca. Senza considerare che la cattura di prodotto ittico di quantità superiore a quella consentita da parte di pescatori sportivi è soggetta al pagamento (in regione del peso) di una sanzione da 500 euro a 50.000 euro, oltre alla confisca del pescato e degli attrezzi. Tali importi raddoppiati nel caso di tonno rosso e pesce spada.
Sanzioni penali in materia di pesca
Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, l'art. 7 del Capo II, commi 1 del Decreto Legislativo 19 gennaio 2012, n. 4 fa divieto di:
► Norme dispositive (illeciti penali):
lettera a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;
lettera b) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti[1], dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici;
lettera c) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi con le modalità di cui alla lettera b);
lettera d) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati. Allo stesso divieto sono sottoposte le unità non battenti bandiera italiana che pescano nelle acque sottoposte alla sovranità della Repubblica italiana;
lettera e) esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione;
lettera f) sottrarre od asportare gli organismi acquatici oggetto dell'altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dalla normativa vigente;
lettera g) sottrarre od asportare gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e di acquacoltura e comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi.
2. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non riguarda la pesca scientifica, nonchè le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle normative internazionale, europea e nazionale vigenti. Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.
► Norme sanzionatorie
L’art. 8 D.lgs. n. 4/2012 , commi 1 e 2 (Pene principali per le contravvenzioni) prevede:
- Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da 2 (due) mesi a 2 (due) anni o con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro;
- Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere f) e g), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa:.con l'arresto da 1 (uno) mese a 1 (uno) anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro.
[1] Legge 895/67, art. 2, sostituito con L. 497/74 art. 10: chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell’articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire quattrocentomila (206 €) a lire tremilioni (1549 €); sequestro degli attrezzi, del mezzo e del pescato.
Corte di cassazione Penale, Sez. III, 15/11/2007 (ud. 12/10/2007), Sentenza n. 42109.
Pesca marittima - Pesca con materie esplodenti - Leggi penali speciali - Concorso formale con altri reati - Configurabilità - Danneggiamento aggravato del “mare territoriale” - Delitto di ricettazione - Concorso formale tra la ricettazione ed il reato di messa in commercio del pescato illegittimamente acquistato.
In materia di pesca marittima con uso di materie esplodenti colui il quale pesca con gli esplosivi risponde non solo della loro detenzione illegale ovvero della contravvenzione di cui all’art. 678 cod. pen. (Cass. Sez. Un. 15/10/1986 n 10901, Granata), ma anche - in concorso formale - del delitto di danneggiamento aggravato del “mare territoriale” (art. 635, comma secondo, n.3 cod. pen.), in quanto bene pubblico esposto alla pubblica fede e destinato a pubblica utilità (Cass sez I, 20/02/1987, n 287; Cass 20/11/2003). Inoltre, l’acquirente del pescato proveniente dalla cattura mediante esplosivi o da danneggiamento delle risorse marine, risponde del delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) se acquista consapevolmente pesce proveniente dai predetti delitti. Infine, vi è concorso formale tra la ricettazione ed il reato di messa in commercio del pescato illegittimamente acquistato, trattandosi di norme che offendono beni giuridici diversi. Presidente C. Vitalone, Relatore C. Petti. Corte di cassazione Penale, Sez. III, 15/11/2007 (ud. 12/10/2007), Sentenza n. 42109.
Giurisprudenza: Cass. Sez. III n. 42109 del 15 novembre 2007 (Ud. 12 ott. 2007) Pres. Vitalone Est. Petti Ric. Morelli ed altro - Acque. Mare territoriale - Configurabilità - Pesca marittima con uso di materie esplodenti - Delitto di detenzione illegale di esplosivi o contravvenzione prevista dall'art. 678 cod. pen. - Concorso formale - Ammissibilità.
È configurabile il concorso formale tra il delitto di detenzione illegale di esplosivi (o la contravvenzione prevista dall'art. 678 cod. pen.) e il delitto di danneggiamento aggravato del "mare territoriale" (art. 635, comma secondo, n. 3 cod. pen. in relazione all'art. 625, n. 7 cod. pen.) nell'esercizio dell'attività di pesca marittima con uso di materie esplodenti, in quanto si tratta di danneggiamento di bene pubblico esposto alla pubblica fede e destinato a pubblica utilità.
Pene accessorie per le contravvenzioni
Alla condanna per le contravvenzioni previste all'art. 8 del D.lgs. n. 4/2012, l'articolo 9, comma 1 del D.lgs. n. 4/2012 comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:
a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nelle ipotesi previste dall'articolo 7, comma 1, lettere f) e g);
b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi con i quali è stato commesso il reato;
c) l'obbligo di rimettere in pristino lo stato dei luoghi nei casi contemplati dall'articolo 7, comma 1, lettere b), f) e g), qualora siano stati arrecati danni ad opere o impianti ivi presenti;
d) la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, in caso di commercializzazione o somministrazione di esemplari di specie ittiche di cui è vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente.
L' articolo 9, comma 2
Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere d) ed e), abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca la "sospensione della licenza di pesca" per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza.
L' articolo 9, comma 3
Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), d) ed e), siano commesse mediante l'impiego di una unità non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la "sospensione del certificato di iscrizione" nel Registro dei pescatori professionali da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi.
Sanzioni amminitrative in materia di pesca
Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, l'art. 10 del Decreto Legislativo 19 gennaio 2012, n. 4 (come modificato dall'art. 39 della Legge del 28 luglio 2016 n° 154) fa divieto di:
► Norme dispositive (IIleciti amministrativi):
- Art. 10, comma 1..
lettera a) effettuare la pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità o di un'autorizzazione in corso di validità;
lettera b) pescare in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti;
lettera c) detenere, trasportare e commerciare il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti;
lettera d) pescare direttamente stock ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi;
lettera e) pescare quantità superiori a quelle autorizzate[1], per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti;
lettera f) effettuare catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti;
lettera g) pescare direttamente uno stock ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito;
lettera h) pescare con attrezzi o strumenti vietati dalle normative europea e nazionale o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza la necessaria autorizzazione o in difformità da questa;
lettera i) detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;
lettera l) manomettere, sostituire, alterare o modificare l'apparato motore dell'unità da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica;
lettera m) navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare manomesso, alterato o modificato, nonchè interrompere volontariamente il segnale, ovvero navigare, in aree marine soggette a misure di restrizione dell'attività di pesca, con rotte o velocità difformi da quelle espressamente disposte dalle normative europea e nazionale, accertate con i previsti dispositivi di localizzazione satellitare;
lettera n) falsificare, occultare od omettere la marcatura, l'identità oi contrassegni di individuazione dell'unità da pesca, ovvero, dove previsto, degli attrezzi da pesca;
lettera o) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite;
lettera p) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee;
lettera q) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi ad esercitare pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008,in particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale perla pesca, o effettuare prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi;
lettera r) utilizzare un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente;
lettera s) occultare, manomettere o eliminare elementi di prova relativi a un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti;
lettera t) intralciare l'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti;
lettera u) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale relative a specie appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali, fatto salvo quanto previsto alla lettera p);
lettera v) commercializzare il prodotto della pesca proveniente da attività di pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, fatta salva l'applicazione delle norme in materia di alienazione dei beni confiscati da parte delle Autorità competenti;
lettera z) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di etichettatura e tracciabilità nonchè gli obblighi relativi alle corrette informazioni al consumatore finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio;
lettera aa) violare le prescrizioni delle normative europea e nazionale vigenti in materia di obbligo di sbarco.
- Art. 10, comma 2, fatte salve le specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco ai sensi delle normative europee e nazionali vigenti, è fatto divieto di:
a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente;
b) trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente.
- Art. 10, comma 3. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie non soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di conservarne gli esemplari a bordo. Le catture di cui al presente comma devono essere rigettate in mare.
- Art. 10, comma 4. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto.
- Art. 10, comma 5. In caso di cattura accidentale o accessoria di esemplari di cui al comma 4, restano salvi gli obblighi relativi alla comunicazione preventiva alla competente Autorità marittima secondo modalità, termini e procedure stabiliti con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
- Art. 10, comma 6. I divieti di cui ai commi 1, lettere b), c), d), g) e h), 2, 3 e4 non riguardano la pesca scientifica, nonchè le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle vigenti normative europea e nazionale. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, resta vietata qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.
- Art. 10, comma 7. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera z), e fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n.1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura ea quelli ad essa destinati.
► Norme sanzionatorie
L’art. 11 del D.lgs. n. 4/2012 (Sanzioni amministrative principali) prevede:
- comma 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u) e v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), p), q), u) e v), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius).
- comma 2. A decorrere dal 1º gennaio 2017, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera aa), e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.
- comma 3. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera o), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
- comma 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera z), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 750 euro a 4.500 euro.
- comma 5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 75.000 euro, ovvero compresa tra 2.000 euro e 150.000 euro se le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius), e alla sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:
a) fino a 5 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 3.000 euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius);
b) oltre 5 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.500 euro e 15.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per cinque giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius);
c) oltre 50 kg e fino a 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 6.000 euro e 36.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per otto giorni lavorativi. Ipredetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada(Xiphias gladius);
d) oltre 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per dieci giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius).
- comma 6. Ai fini della determinazione delle sanzioni di cui al comma 5,al peso del prodotto ittico deve essere applicata una riduzione a favore del trasgressore pari al 10 per cento del peso rilevato. Eventuali decimali risultanti da questa operazione non possono essere oggetto di ulteriore arrotondamento, né è possibile tener conto di ulteriori percentuali di riduzione collegate all'incertezza della misura dello strumento, che sono già comprese nella percentuale sopra indicata.
- comma 7. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 10, commi 2, 3 e 4,non e' applicata sanzione se la cattura accessoria o accidentale di esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione e' stata realizzata con attrezzi conformi alle normative europea e nazionale, autorizzati dalla licenza di pesca.
- comma 8. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro chiunque esercita la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.
- comma 9. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 12.000 euro chiunque viola il divieto di cui all'articolo 6, comma 3.
- comma 10. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque:
a) viola le norme vigenti relative all'esercizio della pescasportiva, ricreativa e subacquea. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius);
b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, ovvero affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia uso.
- comma 11. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura e fatto salvo il caso in cui tra le catture vi sia un singolo pesce di peso superiore a 5 kg, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 50.000 euro, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:
a) oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 3.000 euro;
b) oltre 10 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;
c) oltre 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.000 euro e 50.000 euro.
- comma 12. Gli importi di cui al comma 11 sono raddoppiati nel caso in cuile violazioni ivi richiamate abbiano come oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni del comma 6.
- comma 13. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, agli esercizi commerciali che acquistano pescato in violazione delle disposizioni dei commi 10 e 11 si applica la sanzione della sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni lavorativi.
- comma 14. L'armatore e' solidalmente e civilmente responsabile con il comandante della nave da pesca per le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai propri ausiliari e dipendenti per illeciti commessi nell'esercizio della pesca marittima.
[1] Nella determinazione della quantità delle prede catturate, al fine di accertare il rispetto del limite di peso consentito, non è prescritta la pesatura del pescato, potendo essere sufficiente anche la valutazione personale dell’Organo accertatore competente che compie l’accertamento, qualora le circostanze del caso concreto siano da ritenere certe la sussisternza dell’eccedenza di peso (come ad esempio, l’entità macroscopica dell’eccedenza, l’impiego di contenitori standard, l’assenza di contestazioni su un’evidente eccedenza da parte dell’interessato presente all’accertamento) (Cassazione Civile, Sez. I, 20 aprile 1995, n. 4770).
Sanzioni amministrative accessorie
Alle violazioni di cui all'articolo 11, commi 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, lettera a), e 11 del Dlgs. n. 4/2012 l'art. 12, comma 1 prevede l'applicazione delle seguenti «sanzioni amministrative accessorie»:
a) la confisca del pescato. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e' sempre disposta la confisca degli esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, stabilita dalle normative europea e nazionale;
b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;
c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati collocati apparecchi fissi o mobili di cui all'articolo 10, comma 1, lettera h).
2. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere h) ed i), siano commesse con reti da posta derivante, è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.
3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.
4. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere a), b), c), d), g), h), s) e t), 2, 3, 4 e 5, siano commesse mediante l'impiego di una unità non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione della sospensione di cui al comma 4»;
Istituzione del "Sistema di punti" per infrazioni gravi
Per garantire un'applicazione uniforme delle norme della politica comune della pesca in tutti i paesi membri ed armonizzare il “sistema di sanzioni” in caso di violazione, l'UE ha redatto un elenco delle “violazioni gravi” con l’obbligo da parte dei paesi dell’UE di includere nella loro legislazione sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e assicurare nel contempo il rispetto delle norme medesime.
Nell'ambito di tale sistema, le Autorità nazionali devono:
a) valutare, in base alle definizioni standard dell'UE, le presunte violazioni che riguardano le unità da pesca battenti bandiera nazionale;
b) applicare un numero prestabilito di punti di penalità alle unità implicate in una violazione grave (i punti vengono iscritti nell'apposito Registro nazionale);
c) ritirare la Licenza delle unità da pesca per 2, 4, 8 o 12 mesi se, nell'arco di 3 anni, ha accumulato un numero prestabilito di punti.
L’Italia, nell’adeguarsi all’Europa nell’azione di contrasto della pesca illegale, ha adottato e reso operativo dal 1° gennaio 2012 il nuovo “sistema a punti per le infrazioni gravi” previsto dalle normative europee per contrastare la pesca illegale.
Con la emanazione del Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2017, dei Decreti attuativi 2 marzo e 20 luglio 2017, recanti rispettivamente ”Modalità termini e procedure per l’applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca” e “Modalità, termini e procedure per l’applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi del comandante del peschereccio”, sono state introdotte nuove misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, tese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
- Il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, in particolare, è essenzialmente suddiviso in due parti:
- una contenente definizioni e caratteristiche delle attività disciplinate: vengono fornite le definizioni di pesca professionale, acquacoltura nonché quelle di imprenditore ittico e giovane imprenditore ittico;
- l’altra dedicata a illeciti e sanzioni, fra cui spicca l’istituzione di un «Sistema di infrazioni a punti» per le infrazioni gravi di cui all' articolo 92 del Regolamento (CE) n. 1224/2009 ed agli articoli 125 e seguenti del Regolamento (CE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011.
Il nuovo sistema interessa pescherecci e comandanti di navi da pesca. I pvengono attribuiti alla Licenza di pesca abbinata all'unità. In tal modo rimangono legati a quest'ultima anche in caso di passaggio di proprietà.
Nello specifico vengono elencati tutti quei comportamenti che possono essere sanzionati sia sotto il profilo amministrativo oppure penale, con l’arresto e la confisca del pescato o dell’attrezzatura di pesca non conforme agli standard comunitari.
Costituiscono infrazioni gravi i "reati-contravvenzione" di cui all' articolo 7, comma 1, Decreto legislativo n. 4/2012:
- lettera a): pescare, detenere, trasbordare, sbarcare , trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;
- lettera e): esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione.
► Costituiscono infrazioni gravi gli "illeciti amministrativi" di cui all' articolo 10, comma 1, del Decreto legislativo n. 4/2012:
- lettera a): effettuare la pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità o di un'autorizzazione in corso di validità;
- lettera b) pescare in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti;
- lettera d) pescare direttamente stock ittici per i quali la pesca e' sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi;
- lettera g) pescare direttamente uno stock ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito;
- lettera h) pescare con attrezzi o strumenti vietati dalle normative europea e nazionale o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza la necessaria autorizzazione o in difformità da questa;
- lettera o) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite;
- lettera p) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee;
- lettera q) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi ad esercitare pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, in particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o effettuare prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi;
- lettera r) utilizzare un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente;
- lettera s) occultare, manomettere o eliminare elementi di prova relativi a un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti;
- lettera t) intralciare l'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti;
- lettera aa) violare le prescrizioni delle normative europea e nazionale vigenti in materia di obbligo di sbarco.
► di cui all'articolo 10, comma 2 del Decreto legislativo n. 4/2012:
- lettera a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente;
- lettera b) trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente.
► di cui all'articolo 10, comma 4, del Decreto legislativo n. 4/2012:
In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto.
La commissione di un'infrazione grave dà sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti alla Licenza di pesca, come individuati nell'Allegato I, anche se non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione. Presso il Centro controllo nazionale pesca (CCNP) del Comando generale delle Capitanerie di porto, è istituito il «Registro nazionale delle infrazioni».
Allegato I
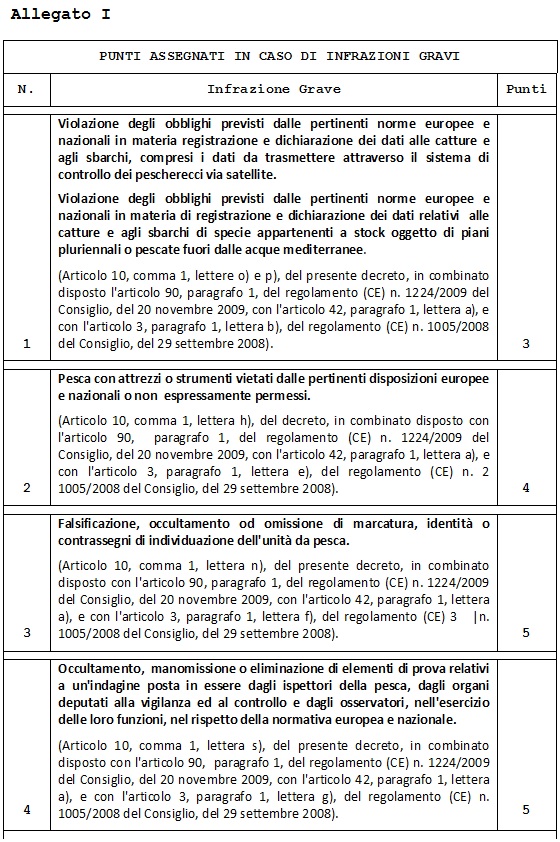
Allegato I: pag. 2
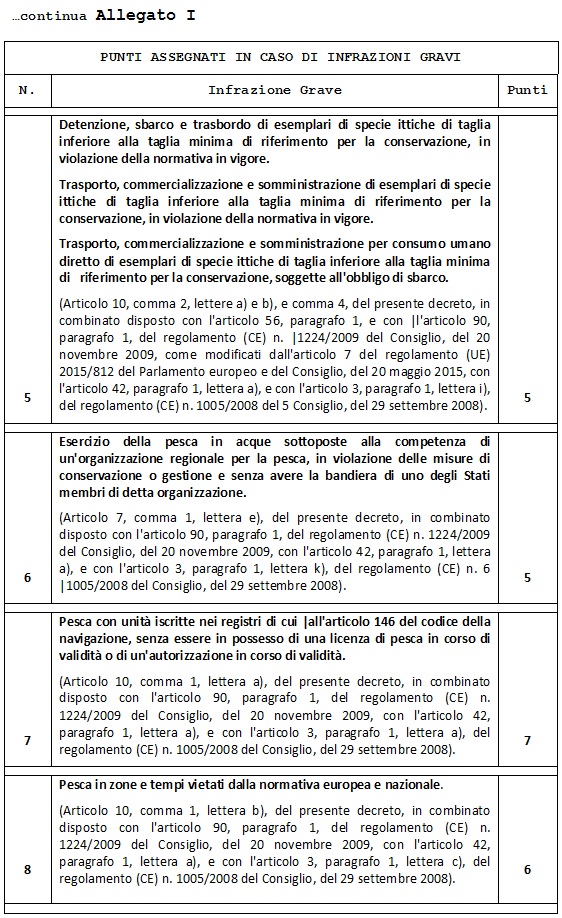
Allegato I: pag. 3
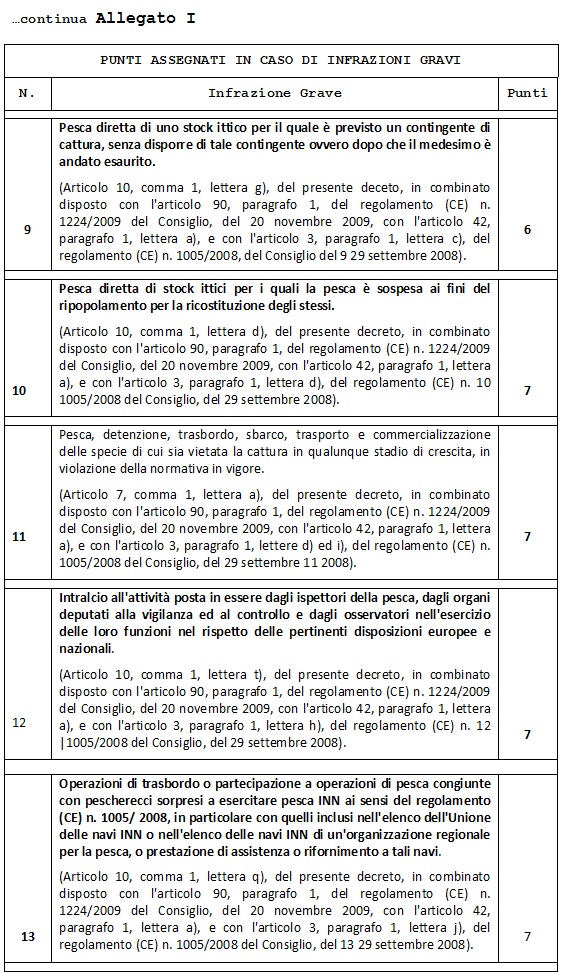
Allegato I pag. 4
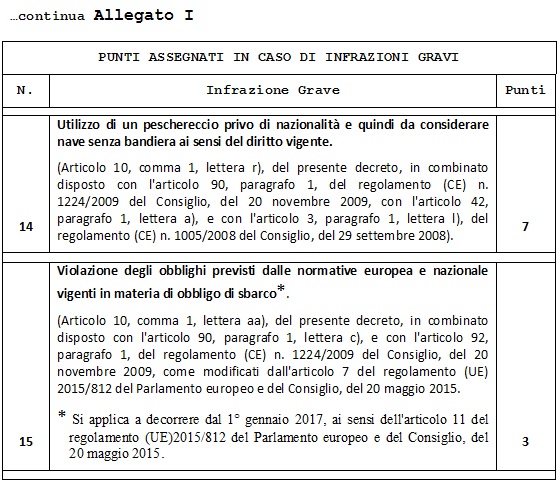
Sospensione e revoca definitiva della Licenza di pesca
Diventa pienamente operativo dopo oltre cinque anni il "sistema della licenza di pesca a punti". La commissione di gravi infrazioni, come ad esempio, pescare specie vietate, usare esplosivi per la pesca o sottrarre organismi acquatici da un allevamento senza il consenso dell’avente diritto o calare le reti in acque di altri Paesi, avrà l’effetto di far “caricare” di un certo numero di punti la Licenza di pesca
Alcuni reati-contravvenzione ed illeciti amministrativi danno luogo all’assegnazione di un numero di punti che, sommati, possono portare alla “sospensione” o alla “revoca” della Licenza di pesca (art. 16 D.lgs. n. 4/2012). In particolare:
- l'assegnazione di un numero totale di punti pari o superiore a 18, comporta la sospensione della licenza di pesca per un periodo di due mesi;
- se il numero totale di punti è pari o superiore a 36, la licenza di pesca è sospesa per un periodo di quattro mesi;
- se il numero totale di punti è pari o superiore a 54, la licenza di pesca è sospesa per un periodo di otto mesi;
- se il numero totale di punti è pari o superiore a 72, la licenza di pesca è sospesa per un periodo di un anno;
- se nel corso di una ispezione vengono individuate due o più infrazioni gravi, alla licenza di pesca sono assegnati fino a un massimo di 12 punti.
- L'accumulo di 90 punti sulla Licenza di pesca comporta la "revoca definitiva" della Licenza di pesca.
- Qualora una licenza di pesca sia stata sospesa, eventuali nuovi punti assegnati alla licenza di pesca vengono aggiunti ai punti esistenti.
- Il legislatore ha comunque previsto un Sistema per abbattere il numero di punti accumulati e ripristinare una situazione di correttezza finalizzata alla ripresa dell’attività imprenditoriale in regime di legalità.
- Pesca illegale durante la sospensione o successivamente alla revoca definitiva della licenza di pesca (art. 17)
Se una nave da pesca la cui Licenza di pesca è stata sospesa o revocata a titolo definitivo, conformemente all'articolo 16 del D.lgs. n. 4/2012, svolge attività di pesca durante il periodo di sospensione o successivamente alla revoca definitiva della Licenza di pesca, gli Organi preposti al controllo adottano le misure di esecuzione immediata ritenute più idonee tra quelle previste dall' articolo 43 del Regolamento (CE) n. 1005/2008, che comprendono in particolare:
a) la cessazione immediata delle attività di pesca;
b) il ritorno in porto del peschereccio;
c) l’invio del mezzo di trasporto verso un altro luogo a fini di ispezione;
d) la costituzione di una garanzia;
e) il sequestro di attrezzi da pesca, catture o prodotti della pesca;
f) l’immobilizzazione temporanea del peschereccio o del mezzo di trasporto considerati;
g) la sospensione dell’autorizzazione di pesca.
Le misure di esecuzione sono tali da impedire il proseguimento dell’infrazione grave di cui trattasi e da consentire alle Autorità competenti di completarne l’indagine.
Punteggio accumulato a seguito di infrazioni gravi: tabella
Cancellazione dei punti dalla Licenza di pesca
Qualora una Licenza di pesca sia stata sospesa ai sensi dell'articolo 16 del D.lgs. n. 4/20012, eventuali nuovi punti assegnati alla Licenza stessa vengono aggiunti ai punti esistenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 16.
- Se il numero totale di punti assegnati alla Licenza di pesca è superiore a due vengono cancellati "due punti" qualora:
- il peschereccio utilizzato per commettere l'infrazione per cui sono stati assegnati i punti utilizzi in seguito il sistema di controllo dei pescherecci «vessel monitoring system» - VMS o proceda alla registrazione e alla trasmissione elettronica dei dati del Giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco senza essere legalmente obbligato all'uso di tali tecnologie;
- il titolare della Licenza di pesca si offra volontariamente, dopo l'assegnazione dei punti, per partecipare a una campagna scientifica per il miglioramento della selettività degli attrezzi da pesca;
- il titolare della Licenza di pesca sia membro di un'organizzazione di produttori e accetti un piano di pesca adottato dall'organizzazione di produttori nell'anno successivo all'assegnazione dei punti che comporti una riduzione del 10 per cento delle possibilità di pesca per il titolare della licenza di pesca;
- il titolare della Licenza di pesca partecipi a una attività di pesca che rientri in un programma di etichettatura ecologica destinato a certificare e promuovere etichette per i prodotti provenienti da una corretta gestione della pesca marittima e focalizzato su temi correlati all'utilizzo sostenibile delle risorse della pesca.
- Per ciascun periodo triennale successivo alla data dell'ultima infrazione grave, il titolare di una Licenza di pesca può avvalersi una sola volta di una delle opzioni di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) per ridurre il numero di punti assegnatigli, a condizione che tale riduzione non comporti la cancellazione di tutti i punti della Licenza di pesca.
- Nel caso in cui non venga commessa una nuova infrazione grave nei tre anni successivi all'ultima infrazione grave, tutti i punti applicati sulla Licenza di pesca sono annullati.
- Se i punti sono stati cancellati nei casi su citati, il titolare della Licenza viene informato dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura di tale cancellazione e del numero di punti eventualmente rimanenti.
Procedimento per l'applicazione del "Sistema di punti" per infrazioni gravi alla Licenza di pesca
Il Decreto 29 febbraio 2012 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (GU n. 105 del 7 maggio 2012 ) ha definito modalità, termini e procedure per l'applicazione del «Sistema di punti per infrazioni gravi alla Licenza di pesca», ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.lgs.n. 4/2012.
Nel caso di accertamento di una infrazione grave costituente illecito amministrativo di cui di cui all'art. 10, comma 1, lettere a), b), d), g), h), n), o), p), q), r), s), e t) del citato D.lgs., gli Organi addetti al controllo, oltre a contestare l’infrazione elevando “Verbale” al Comandante della nave da pesca, notificano altresì al titolare della Licenza di pesca del peschereccio interessato anche il “Verbale” relativo all'applicazione dei punti secondo quanto previsto all'art. 14, comma 3, del D.lgs, n. 4/2012, e, senza ritardo, trasmettono copia di entrambi gli atti al Capo del compartimento marittimo competente in base al luogo della commessa violazione.
Nell’ipotesi che gli Organi addetti al controllo accertano condotte che costituiscono reato di cui all'art. 7, comma 1, a), c) e g) del D.lgs. n. 4/2012, notificano al titolare della licenza di pesca del peschereccio interessato, il “Verbale” relativo all'applicazione dei punti secondo quanto previsto all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 4/2012, e, senza ritardo, ne trasmettono copia al Capo del compartimento marittimo competente in base al luogo della commessa violazione. Entro il termine di 30 giorni dalla notifica del Verbale relativo all'applicazione dei punti, gli interessati possono far pervenire al competente Capo del compartimento «scritti difensivi» e documenti, nonché chiedere di essere sentiti dal medesimo (= richiesta di audizione). Il Capo del compartimento, sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli eventuali documenti e scritti difensivi inviati oppure comunque decorsi i termini dei trenta giorni, ritenuto fondato l'accertamento, dispone, con “provvedimento motivato l'assegnazione dei punti”, altrimenti emette “provvedimento motivato di archiviazione” degli atti. In entrambi i casi, il provvedimento motivato è notificato all'interessato nei termini di legge e ne è trasmessa copia all'Ente accertatore.
Il Capo del compartimento, nel caso emetta “provvedimento di assegnazione di punti”, ne trasmette copia alla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura e, se diverso, all'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio. L'Ufficio di iscrizione della nave da pesca annota senza ritardo sul “Registro di iscrizione” del peschereccio gli estremi del provvedimento di assegnazione dei punti ed il numero dei punti assegnati e ne dà comunicazione al Centro Controllo Nazionale Pesca (CCNP) ed alla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura. Ove rilevi che la violazione commessa comporta il raggiungimento dei punti di cui all'art. 16, comma 1 del D.lgs. n. 4/2012[1],notifica all'interessato il relativo atto di accertamento, precisando il “periodo di sospensione” previsto in relazione al numero di punti accumulati, ne dà comunicazione alla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura e, se diverso, al Capo del Compartimento marittimo dell'Ufficio di iscrizione del peschereccio. Di contro, ove detto Ufficio rilevi che la violazione commessa comporta il raggiungimento dei punti di cui all'art. 16, comma 3 del D.lgs. n. 4/2012[2],notifica all'interessato il relativo atto di accertamento e, se diverso, ne dà comunicazione al Capo del Compartimento marittimo dell'Ufficio di iscrizione del peschereccio ed alla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura.
Per le violazioni accertate fuori dal limite delle acque territoriali (12 miglia) la competenza a ricevere il rapporto è il Capo del Compartimento marittimo dell'Ufficio di iscrizione del peschereccio interessato.
- Trasferimento di proprietà del peschereccio
In caso di trasferimento di proprietà del peschereccio, il titolare della Licenza all'atto di trasferimento è tenuto a produrre l'attestazione relativa al numero di punti assegnati rilasciata dall'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio.
[1] Art. 16, comma 1 (Sospensione e revoca definitiva della licenza) - L'assegnazione di un numero totale di punti pari o superiore a 18, comporta la sospensione della licenza di pesca per un periodo di due mesi. Se il numero totale di punti è pari o superiore a 36, la licenza di pesca è sospesa per un periodo di quattro mesi. Se il numero totale di punti è pari o superiore a 54, la licenza di pesca è sospesa per un periodo di otto mesi. Se il numero totale di punti è pari o superiore a 72, la licenza di pesca è sospesa per un periodo di un anno.
[2] Art. 16, comma 3. L'accumulo di 90 punti sulla Licenza di pesca comporta la revoca definitiva della licenza di pesca.
Sospensione e revoca della Licenza di pesca
Entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'atto di accertamento di cui all’art. 2, comma 7 del decreto 29 febbraio 2012 (= per le violazioni che comportano il raggiungimento dei punti di cui all’art. 16, comma 1 del D.lgs, n. 4/2012), l'interessato può far pervenire al Capo del compartimento marittimo dell'Ufficio di iscrizione del peschereccio, scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentito dal medesimo. Il Capo del compartimento, sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli eventuali documenti e scritti difensivi inviati ovvero comunque decorsi i termini (trenta giorni), ritenuto fondato l'accertamento, dispone il “provvedimento motivato di sospensione della licenza di pesca”, altrimenti emette “provvedimento motivato di archiviazione” degli atti. Il provvedimento è notificato all'interessato nei termini di legge, per il tramite dell'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio.
Il periodo di sospensione della Licenza di pesca decorre dal momento del ritiro della stessa da parte dell'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio interessato, che deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione.
Al momento del ritiro della Licenza di pesca, l'Ufficio marittimo di iscrizione redige apposito Verbale, annota senza ritardo sul Registro di iscrizione del peschereccio gli estremi del provvedimento ed il periodo di sospensione, ne trasmette copia alla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura, e ne dà comunicazione al Centro di Controllo Nazionale della Pesca (CCNP). Durante il periodo di sospensione gli attrezzi da pesca sono fissati e stivati ai sensi dell'art. 47 del Reg. (CE) n. 1224/2009.
- Revoca della Licenza di pesca
Entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'atto di accertamento di cui all’art. 2, comma 8 del decreto 29 febbraio 2012 (= per le violazioni che comportano il raggiungimento dei punti di cui all’art. 16, comma 3 del D.lgs, n. 4/2012), l'interessato può far pervenire alla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentito. Il Direttore generale, sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli eventuali documenti e scritti difensivi inviati ovvero comunque decorsi i termini (trenta giorni), ritenuto fondato l'accertamento, dispone il “provvedimento motivato di revoca della licenza di pesca”, altrimenti emette “provvedimento motivato di archiviazione” degli atti. Il provvedimento è notificato all'interessato nei termini di legge, per il tramite dell'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio.
L'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio provvede al ritiro della licenza di pesca nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. Al momento del ritiro della licenza di pesca, l'Ufficio marittimo di iscrizione redige apposito Verbale, annota senza ritardo sul Registro di iscrizione del peschereccio gli estremi del provvedimento, ne trasmette copia alla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura, e ne dà comunicazione al Centro di Controllo Nazionale della Pesca (CCNP).
- Cancellazione della Licenza di pesca dai relativi elenchi
In conformità a quanto prescritto dall'art. 131 del Reg. (UE) n. 404/2011, qualora la licenza di pesca venga sospesa o revocata a titolo definitivo, il peschereccio a cui si riferisce la licenza medesima viene identificato come sprovvisto di licenza nell' Archivio nazionale licenze di pesca e nel Fleet Register della Commissione Europea. La Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura provvede ad aggiornare le informazioni contenute nell'Archivio nazionale licenze di pesca e ad inviare i dati per l'aggiornamento del Fleet Register della Commissione Europea.
Impugnazioni
I provvedimenti di assegnazione dei punti, sospensione e revoca possono essere impugnati (art. 5 Decreto 29 febbario 2012) ai sensi degli articoli 22 e seguenti (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione; Competenza per il giudizio di opposizione; Giudizio di opposizione) della Legge n. 689/1981.
Qualora, a seguito di impugnazione, sia annullato il provvedimento con cui sono stati assegnati i punti, il titolare della Licenza di pesca presenta, al Capo del compartimento dell'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio, copia del «provvedimento giudiziale» che dispone l'annullamento. Il Capo del compartimento dell'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio interessato, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento giudiziale citato, dispone con proprio provvedimento la decurtazione dei punti assegnati, e lo notifica al titolare della Licenza di pesca dandone comunicazione al Centro Controllo Nazionale Pesca (CCNP), alla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura e, se diverso, all'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio.
Nel caso in cui dall'assegnazione dei punti decurtati, sia derivata la “sospensione” o la “revoca” della Licenza di pesca, il Capo del compartimento dell'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio nel caso di sospensione o la Direzione generale della pesca Marittima e dell’Acquacoltura in caso di revoca, provvedono all'annullamento del provvedimento di sospensione e dispongono la riconsegna al titolare della licenza di pesca. L'Ufficio marittimo di iscrizione annota senza ritardo sul Registro di iscrizione del peschereccio gli estremi dei provvedimenti di cui al presente articolo.
Cancellazione dei punti dalla Licenza di pesca
Il titolare della Licenza di pesca, al fine di ottenere la cancellazione dei punti (art. 8 decreto 29 febbraio 2012), presenta la relativa istanza, corredata da idonea documentazione attestante l'esistenza delle condizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 18 del D.lgs. n. 4/2012, al Capo del Compartimento marittimo dell'Ufficio di iscrizione del peschereccio interessato.
- Per le istanze presentate ai sensi dell’art. 18, comma 2 del D.lgs. n. 4/2012[1], il Capo del Compartimento, procede alla verifica attraverso gli Uffici competenti, che, successivamente alla data di commissione dell'ultima infrazione grave, il titolare della licenza:
- nel caso di cui alla lettera a), utilizzi il sistema VMS o proceda alla registrazione e alla trasmissione elettronica dei dati del Giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco;
- nel caso di cui alla lettera b), abbia concluso la campagna di pesca scientifica per la quale si è offerto volontariamente;
- nel caso di cui alla lettera c), che in qualità di membro di un'organizzazione di produttori abbia accettato e si sia attenuto al piano di pesca dell'organizzazione;
- nel caso di cui alla lettera d), partecipi ad un'attività di pesca rientrante in un programma di etichettatura biologica.
- Per le istanze presentate ai sensi dell’art. 18, comma 4 del D.lgs. n. 4/2012[2], il Capo del Compartimento, procede alla verifica delle richieste condizioni e all'esito delle verifiche, emette, ove ne ricorrano i presupposti, un “provvedimento di cancellazione dei punti”, che provvede a notificare al titolare della licenza di pesca, trasmettendone copia alla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura ed all'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio interessato, ai fini dell'annotazione sul Registro di iscrizione, dandone comunicazione al Centro Controllo Nazionale Pesca (CCNP).
Nel caso in cui non ne ricorrano i presupposti emette un “provvedimento di diniego” e lo notifica all'interessato.
Il Centro Controllo Nazionale Pesca (CCNP), ricevuta la comunicazione del “provvedimento” citato, provvede ad aggiornare il “Registro nazionale delle infrazioni”.
Il Centro Controllo Nazionale Pesca provvede ad aggiornare i dati contenuti nel Registro nazionale delle infrazioni con l'indicazione di tutti i punti assegnati, dei punti decurtati ai sensi dell'art. 5 comma 3 e cancellati ai sensi dell'art. 8 del decreto 29 febbraio 2012, nonché delle sospensioni delle licenze di pesca con relativo periodo, e delle revoche definitive.
[1] Art. 18, comma 2 D.lgs. n. 4/2012 (Cancellazione Punti). […] Se il numero totale di punti assegnati alla licenza di pesca è superiore a due vengono cancellati due punti qualora:
a) il peschereccio utilizzato per commettere l'infrazione per cui sono stati assegnati i punti utilizzi in seguito il sistema di controllo dei pescherecci «vessel monitoring system» - VMS o proceda alla registrazione e alla trasmissione elettronica dei dati del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco senza essere legalmente obbligato all'uso di tali tecnologie;
b) il titolare della licenza di pesca si offra volontariamente, dopo l'assegnazione dei punti, per partecipare a una campagna scientifica per il miglioramento della selettività degli attrezzi da pesca;
c) il titolare della licenza di pesca sia membro di un'organizzazione di produttori e accetti un piano di pesca adottato dall'organizzazione di produttori nell'anno successivo all'assegnazione dei punti che comporti una riduzione del 10 per cento delle possibilità di pesca per il titolare della licenza di pesca;
d) il titolare della licenza di pesca partecipi a una attività di pesca che rientri in un programma di etichettatura ecologica destinato a certificare e promuovere etichette per i prodotti provenienti da una corretta gestione della pesca marittima e focalizzato su temi correlati all'utilizzo sostenibile delle risorse della pesca.
[2] Art. 18, comma 4 (Cancellazione punti). […] Nel caso in cui non venga commessa una nuova infrazione grave nei tre anni successivi all'ultima infrazione grave, tutti i punti applicati sulla licenza di pesca sono annullati.
"Sistema di punti" per il Comandante del peschereccio
Di particolare interesse è l’istituzione ai sensi dell'art. 19 del Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 di un «Sistema di punti per i comandanti dei pescherecci» a norma dell'articolo 92, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n. 1224/2009 e dell'articolo 134 del Regolamento (CE) n. 404/2011 per infrazioni gravi.
La commissione di un'infrazione grave, di cui all'articolo 14, comma 2, del D.lgs. n. 4/2012 dà sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti al marittimo imbarcato con la funzione di comandante della unità da pesca, come individuati nell 'Allegato I, anche se non viene emessa l'ordinanza di ingiunzione.
- Sanzioni applicate al comandante della nave
L'applicazione del sistema di punti per i comandanti delle navi da pesca, comporta:
- il divieto di svolgere le funzioni di comandante per un periodo di 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dei punti, al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 18,
- il divieto di svolgere le funzioni di comandante per un periodo di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dei punti, al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 54;
- il divieto di svolgere le funzioni di comandante per un periodo di 2 mesi dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dei punti, al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 90,
Se nel corso di un’ispezione vengono accertate due o più infrazioni gravi, sono assegnati fino a un massimo di 12 punti. Nel caso in cui non venga commessa una nuova infrazione grave nei tre anni successivi all'ultima infrazione grave, tutti i punti applicati alle funzioni di Comandante sono annullati.
- Sanzioni disciplinari
Se le infrazioni sono commesse da appartenenti al personale marittimo, laddove ricorrano i presupposti di cui agli articoli 1249 e seguenti del Codice della navigazione, sono applicate anche le sanzioni disciplinari ivi previste.
Applicazione del "Sistema a punti" per i Comandanti delle navi da pesca: tabella
Procedimento di "assegnazione dei punti" per infrazioni gravi e sospensione della funzione di Comandante del peschereccio
Il Decreto 29 febbraio 2012 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (GU n. 105 del 7 maggio 2012 ) modalità, termini e procedure per l’applicazione del «Sistema di punti per infrazioni gravi del comandante del peschereccio», ai sensi dell’art. 19, comma 3 del D. Lgs. n. 4/2012.
Con le stesse modalità previste per l'applicazione del «Sistema di punti per infrazioni gravi alla Licenza di pesca», in caso di accertamento da parte degli Organi addetti al controllo, di una infrazione grave costituente illecito amministrativo di cui di cui all' art. 10, comma 1, lettere a), b), d), g), h), n), o), p), q), r), s), e t) del citato D,lgs. legislativo, oltre a contestare l’infrazione elevando “Verbale” al Comandante della nave da pesca, gli stessi notificano al titolare della Licenza di pesca del peschereccio anche il “Verbale” relativo all'applicazione dei punti secondo quanto previsto all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 4/2012, e, senza ritardo, trasmettono copia di entrambi gli atti al Capo del compartimento marittimo competente in base al luogo della commessa violazione.
Nell’ipotesi che i predetti Organi accertano condotte che costituiscono reato di cui all'art. 7, comma 1, a), c) e g) del D.lgs. n. 4/2012, notificano al titolare della licenza di pesca del peschereccio interessato, il “Verbale” relativo all'applicazione dei punti secondo quanto previsto all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 4/2012, e, senza ritardo, ne trasmettono copia al Capo del compartimento marittimo competente in base al luogo della commessa violazione. Qualora l’Organo accertatore rilevi che l’applicazione dei punti per l’infrazione grave contestata comporta, ai sensi dell’art. 20 delD. Lgs. n. 4/2012, la sospensione della funzione di comandante, nel Verbale di applicazione dei punti, inserisce altresì l’indicazione del relativo periodo di sospensione. Entro il termine di trenta giorni dalla notifica del Verbale relativo all’applicazione dei punti, l’interessato può far pervenire al Capo del compartimento scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentito dal medesimo. Questi, sentito l’interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli eventuali documenti e scritti difensivi inviati ovvero comunque decorsi i termini di trenta giorni, ritenuto fondato l'accertamento, dispone, con “provvedimento motivato”, l’assegnazione dei punti e l’eventuale sospensione, altrimenti emette “provvedimento motivato di archiviazione” degli atti. In entrambi i casi, il provvedimento motivato è notificato all’interessato nei termini di legge, e ne è trasmessa copia all’Ente accertatore.
Il Capo del compartimento, nel caso emetta “provvedimento di assegnazione di punti” ed eventuale sospensione, dispone l’annotazione degli estremi del provvedimento - con indicazione del numero dei punti e dell’eventuale periodo di sospensione - sul titolo matricolare del marittimo (= libretto di navigazione) e ne dà comunicazione al Centro Controllo Nazionale Pesca (CCNP), alla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura ed all’Ufficio di iscrizione del marittimo per le dovute annotazioni sul pertinente «Registro». La sospensione delle funzioni di comandante è altresì annotata sul Ruolo di equipaggio ovvero sul Ruolino di equipaggio ed il periodo di sospensione inizia a decorrere dalla data della predetta annotazione.
Per le violazioni accertate fuori dal limite delle acque territoriali la competenza a ricevere il rapporto è il Capo del Compartimento marittimo dell’Ufficio di iscrizione del peschereccio interessato.
Impugnazioni
I provvedimenti di assegnazione dei punti e sospensione possono essere impugnati ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 689/1981. Qualora, a seguito di impugnazione, sia annullato il provvedimento con cui sono stati assegnati i punti, il marittimo interessato presenta al Capo del compartimento marittimo dell’Ufficio di iscrizione copia del “provvedimento giudiziale” che dispone l’annullamento.
Il Capo del compartimento, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, dispone con proprio provvedimento la decurtazione dei punti assegnati, lo notifica al marittimo interessato, dispone l’annotazione degli estremi del provvedimento sul titolo matricolare del marittimo - con indicazione del numero dei punti decurtati -, ne dà comunicazione al Centro Controllo Nazionale Pesca (CCNP) ed all’Ufficio di iscrizione del marittimo per le dovute annotazioni sul pertinente Registro.
Nel caso in cui dall’assegnazione dei punti, successivamente decurtati, sia derivata la “sospensione” delle funzioni di comandante, il Capo del compartimento dell’Ufficio marittimo di iscrizione del marittimo interessato provvede all’annullamento del provvedimento di divieto e ad annotarne gli estremi sul titolo matricolare del marittimo e, ove occorra, sul Ruolo ovvero Ruolino di equipaggio.
Cancellazione dei punti
Il marittimo interessato, al fine di ottenere la cancellazione dei punti nei casi di cui al comma 3 dell’articolo 20 del D. Lgs n. 4/2012[1], presenta la relativa istanza al Capo del Compartimento dell’Ufficio marittimo di iscrizione. All’esito della verifica, il Capo del Compartimento emette, ove ne ricorrano i presupposti, un provvedimento di cancellazione dei punti, lo notifica all’interessato, dispone l’annotazione degli estremi del provvedimento sul documento matricolare del marittimo – con indicazione del numero dei punti cancellati - e ne dà comunicazione al Centro Controllo Nazionale Pesca ed all’Ufficio di iscrizione del marittimo per le dovute annotazioni sul pertinente Registro. Nel caso in cui non ne ricorrano i presupposti emette un provvedimento di diniego e lo notifica al marittimo interessato.
Il Centro Controllo Nazionale Pesca provvede ad aggiornare i dati contenuti nel «Registro nazionale delle infrazioni» con l'indicazione di tutti i punti assegnati, dei punti decurtati ai sensi dell’art. 3 comma 3 e cancellati ai sensi dell’art. 4 del presente decreto, nonché delle sospensioni delle funzioni di comandante.
[1] Art. 20, comma 3 (Sanzioni applicate al comandante della nave) […] Nel caso in cui non venga commessa una nuova infrazione grave nei tre anni successivi all'ultima infrazione grave, tutti i punti applicati sulla licenza di pesca sono annullati.
Tutela del consumatore
Negli ultimi anni si è preso coscienza che oltre a tutelare le specie ittiche è necessario anche preservare i diritti e soprattutto la salute del consumatore finale del prodotto. Pertanto sono state emanate normative nazionali e comunitarie che pongono l’attenzione sugli aspetti sanitari e commerciali del mondo della pesca.
Di fondamentale importanza per quanto riguarda la questione sanitaria è il D.lgs. 6 novembre 2007, n. 193 in attuazione della direttiva 2004/431/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore.
Il Decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 9 novembre ed entrato in vigore il 21 novembre 2007, recependo la citata Direttiva 2004/41/CE, ha definitivamente abrogato numerosi atti normativi nazionali di derivazione comunitaria ed altre norme nazionali preesistenti che hanno a lungo costituito una parte fondamentale dell’intero quadro normativo del settore alimentare, confermando peraltro numerose “abrogazioni” già precedentemente operate da tali atti, e in particolare:
- Decreto Legislativo n. 530/1992 (molluschi bivalvi), ad eccezione dell’art. 20 che abrogava precedente normativa;
- Decreto Legislativo n. 531/1992 (prodotti della pesca).
Questo decreto dovrebbe essere propedeutico al nuovo Codice della sicurezza alimentare, da tempo in fase di elaborazione, che dovrebbe completare le necessarie abrogazioni e riunire tutte le norme in un quadro organico ed armonizzato rispetto alla legislazione comunitaria.
L’art. 6 del Dlgs. n. 193/2007 (nei limiti dell’applicabilità del Reg CE n. 853/2007) non indica puntualmente gli articoli della normativa comunitaria violati, ma elenca le fattispecie costituenti violazione e le rispettive sanzioni applicabili.
Ai commi (commi 11, 12, 13 e 14) prevede le sanzioni applicabili per il settore dei molluschi bivalvi vivi (MBV)
I commi 11-14 trattano delle sanzioni relative all’immissione del molluschi bivalvi vivi e sotto intendono alla preoccupazione del legislatore in merito alla possibile commercializzazione di MBV al di fuori del circuito di produzione, stabilendo sanzioni più elevate nel caso di immissione sul mercato di MBV provenienti da zone dichiarate “Precluse “ o “Non idonee”, salvo che il fatto costituisca reato.

La violazione delle norme contenute nel citato Decreto dà origine a sanzioni amministrative piuttosto pesanti nei confronti del possessore e inoltre, a seguito di successivi esami da parte del personale sanitario della A.S.L., può sfociare in una ancor più affittiva sanzione penale in caso di cattiva conservazione del prodotto, che può essere configurata nel reato di pericolo presunto, che di per sé non esige il verificarsi di un danno per la salute del consumatore (Sentenza Cass. n°. 35103/04).
Ad adiuvandum:
- Art. 6 comma 11: per il trasporto di lotti molluschi bivalvi vivi (MBV) senza il “documento di accompagnamento” (Regolamento n. 853/2004, all. III, sez. VII, cap. 1) da applicarsi anche nel caso di Echinodermi tunicati, Gasteropodi marini vivi per i quali non è prevista la depurazione, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000 (in misura ridotta: euro 2.000).
- Art. 6 comma 12: per l’immissione sul mercato di molluschi bivalvi vivi non transitati da un “centro di spedizione” (, nel quale viene apposto un “marchio di identificazione” secondo il cap. III (fatte salve le deroghe per i pettinidi di cui all’all. III, sez. VII, cap. IX, punto 3, del Regolamento 853/2004) è prevista la sanzione amministrativa pari a una somma da euro 1.000 a euro 6.000 (in misura ridotta: euro 2.000), applicabile anche nel caso di immissione sul mercato di molluschi provenienti da zone acquee classificate B o C senza sottoporli a depurazione.
- Art. 6 comma 13: la sanzione aumenta, corrispondendo a una somma da euro 2.000 a euro 12.000, per l’immissione sul mercato di molluschi, esclusi i pettinidi, provenienti da zone acquee non classificate dalle Autorità competenti ,
- Art. 6 comma 14: ancor più grave, da euro 5.000 a euro 30.000 (in misura ridotta: euro 10.000), è la sanzione prevista per l’immissione sul mercato di molluschi provenienti da zone giudicate non idonee o precluse dalle autorità competenti[1] .
- […]
[1] Il Decreto Legislativo n. 193/2007 all’art. 2, individua le autorità competenti ai fini dell’applicazione della normativa comunitaria rappresentata dai Regolamenti del pacchetto igiene (Regolamento 852, 853, 854 e 882 del 2004). Tali Autorità sono rappresentate, per le rispettive competenze, da: Ministero della salute, Regioni e Province autonome; Aziende Unità Sanitarie Locali.
Viene così superata una carenza che ha suscitato non pochi dubbi ed equivoci, dato che sono diversi gli enti titolari di qualche competenza nell’ambito del controllo ufficiale nel settore alimentare (per esempio, in materia amministrativa o di etichettatura) che, negli ultimi anni, avevano scoperto la vocazione dell’igiene e della sicurezza alimentare, certamente sensibili al problema della tutela della salute ma senza averne la competenza tecnico-scientifica. A livello periferico solamente le ASL, nelle articolazioni dei Dipartimenti di Prevenzione, possono compiere valutazioni del rischio per la sicurezza alimentare e adottare i provvedimenti del caso, fatte salve le prerogative ispettive dei Comandi Carabinieri per la Sanità (NAS).
Etichettatura comunitaria dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura: obblighi, sanzioni e competenze per la vigilanza
Oltre alla fondamentale garanzia igienico-sanitaria che si cerca di garantire al consumatore, in questi ultimi anni l’Unione Europea ha messo in evidenza la necessità di garantire, in un mercato globale sempre più vasto, la corretta informazione sulla effettiva tipologia, origine e metodo di cattura del prodotto ittico immesso sul mercato prevedendo una precisa «tracciabilità» di ogni singolo esemplare lungo la filiera, ossia dal momento del suo prelievo dal luogo di origine alla sua definitiva vendita ai consumatori finali.
Al fine di assicurare al consumatore un prodotto finale con le massime caratteristiche di igiene e sicurezza alimentare, assume un’importanza determinante la «etichettatura» dei prodotti ittici, che costituisce (diciamo così) il “biglietto da visita” del pesce di fronte al consumatore.
Questa nuova metodologia di controllo fonda le sue origini sui Regolamenti (CE) nn°. 2406/96, 104/2000 e 2065/2001 e, in ambito nazionale, sul D.lgs. n° 109/92 (sull’etichettatura degli alimenti), sul D.M. 27 marzo.2002 che segue la recente regolamentazione comunitaria (in applicazione dell’art. 9 del regolamento CE 2065/2001) e istituisce il sistema di controllo sui requisiti obbligatori di etichettatura per i prodotto della pesca e dell’acquacoltura.
A fronte di questa normativa, si può porre in evidenza l’aspetto più innovativo della questione che si basa sull’esposizione da parte del negoziante, a fianco di ciascuna specie esposta per la vendita, di una "ETICHETTA" dei prodotti ittici simile a quella delle carni bovine e delle carni di altre specie animali in genere, che precisi la denominazione commerciale della specie il metodo di produzione (cattura in mare o nelle acque interne o allevamento) e la zona di cattura, rimandando agli Stati membri la pubblicazione dell’elenco delle denominazioni commerciali autorizzate.
In altri termini, anche nel settore ittico il legislatore europeo impone l'obbligo di riportare in etichetta una serie di indicazioni specifiche che permettano al consumatore di vedere in trasparenza l'origine e il percorso compiuto da quel pesce lungo la filiera produttiva.
In questa sede si ha l’opportunità di chiarire che la “tracciabilità“ nelle sue modalità di applicazione consente di controllare se i prodotti sono organoletticamente sicuri, mentre la “etichettatura “ è prescritta solo allo scopo di dare le informazioni utili al consumatore.
Alla luce di quanto previsto dall’art. 2, punto 1 del Decreto 27 marzo 2002, sull’etichetta dei prodotti della pesca in ogni fase della loro commercializzazione, «esclusa la vendita al dettaglio», bisogna riportare
- la denominazione commerciale specifica del prodotto seguita dalla denominazione scientifica del prodotto, con la classica denominazione binomiale latina (es. Vongola, Venus gallina);
- il metodo di produzione (se di “allevamento” o “di pesca”);
- la zona di cattura: in questo caso, l’areale in cui il pesce è stato pescato o allevato è indicato con un numero che corrisponde ad una precisa zona geografica, come riportato nel Regolamento CE 2065 del 2001.
- Ad esempio, se pescato – Area marittima (può essere indicato il nome del mare, es. “Mar Mediterraneo”; o la zona FAO, es. “zona 37.1”); – Nazione di pesca (se pesci di fiume); se allevato –Nazione di allevamento
- la data di scadenza, modalità di conservazione, ecc.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 2 del Decreto 27.03.2002, sull’etichetta dei prodotto ittici «in fase di vendita al dettaglio», il venditore deve riportare:
- la denominazione commerciale italiana. In questo caso, è facoltativo per il venditore riportare la denominazione scientifica in latino;
- il metodo di produzione (se “di allevamento” o “di pesca”);
- la zona di cattura, secondo le medesime indicazioni riportate in precedenza.
L’assenza di tale sistema visivo di identificazione del prodotto comporta una sanzione amministrativa, mentre la non veridicità di una fra le predette indicazioni si può configurare nel più grave «reato di truffa», come la recente immissione nel mercato del nord Italia di ingenti quantitativi di prodotto originario delle acque dolci della Cina, spacciato per il ben rinomato “Rossetto del Mediterraneo”
Alcune considerazioni
Il prodotto che è formalmente etichettato e che risponde positivamente ai controlli di qualità, per assurdo, potrebbe provenire da una zona o paese che invece non è quello dichiarato in etichetta. In questo caso quale sanzione si applicherà ?
Si applicherà la sanzione prevista dall’art. 18 del D.Lgs. 109/92 che va da EURO 1.600 a EURO 9.500 perché l’indicazione dell’origine non è corretta … o la sanzione prevista l’art. 1 bis del D.L. 157/2004 (convertito in legge dalla legge 3 agosto 2004 n.204) che punisce le violazioni delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie nell’etichettatura dei prodotti alimentari di cui ai commi 1,2,3 che prevede anch’esso la sanzione da Euro 1.600 a 9.500 Euro e della sanzione accessoria della sospensione della commercializzazione, qualora siano commesse più violazioni (reiterazione), anche in tempi diversi.
► L’assenza della “etichetta” a fianco al prodotto ittico comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516 € a 3.098 € (pagamento in misura ridotta 1.032 €) ai sensi dell’art. 18, comma 3 del D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 per aver violato la norma di cui all’art. 1 del D.M. 27 marzo 2002 e artt. 3, 4 e 5 Regolamento (CE) n. 2065/2001 del 22 ottobre 2001
► La non veridicità di una delle predette indicazioni può configurare l’ipotesi di reato:
- di cui agli artt. 56 e 640 c.p. (Truffa)
- di cui all’art. 515 c.p., (Frode nell’esercizio del commercio)
► La vendita di prodotti non freschi come freschi può configurare l’ipotesi di reato:
- di cui all’art. 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)
- di cui all’art. 444 c.p., (Commercio di sostanze alimentari nocive)

Legge 30 aprile 1962, n. 283
Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 4 giugno 1962) […]
Articolo 5
E' vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari:
b) in cattivo stato di conservazione
[…]
Regolamento n° 2065/2001
L'art. 8 del Regolamento n° 2065/2001 stabilisce che le indicazioni obbligatorie di cui all’art. 2, punto 1 del decreto 27 marzo 2002, devono essere disponibili ad ogni stadio di commercializzazione; spiega poi che tali indicazioni e la denominazione scientifica della specie "sono fornite mediante l’etichettatura o l’imballaggio del prodotto, oppure mediante un qualsiasi documento commerciale di accompagnamento della merce, compresa la fattura", e ciò viene confermato dal Decreto Ministeriale citato in premessa.
È certamente quest’ultimo il caso più frequente quando si tratta di prodotti freschi contenuti in cassette aperte, destinati ad essere venduti sfusi: il venditore al dettaglio rileverà dal “documento accompagnatorio”, che deve peraltro sempre essere presente ai sensi del Dlgs. n. 193/2007, le indicazioni, per riportarle su apposito cartello da esporre al pubblico in corrispondenza della merce secondo l’art. 16 del D. Lgs. n° 109/1992.
► Facciamo una breve panoramica delle singole indicazioni.
-
Denominazione scientifica
Questa informazione non figura fra le indicazioni obbligatorie definite dal Reg. n° 104/2000 ma a queste viene accostata dal Reg. n° 2065/2001 per la tracciabilità nelle fasi commerciali precedenti la vendita al consumatore finale (art. 8) e, come indicazione facoltativa, anche in quest’ultima fase (art. 3); ciò è peraltro confermato rispettivamente dagli articoli 1 e 2 dello stesso D. M. 27 marzo 2002.
-
Denominazione commerciale
L’art. 3 del D. M. 27 marzo 2002 approva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Reg. n° 104/2000, l’elenco (Allegato A) delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale, suddivise fra pesci, molluschi bivalvi, molluschi cefalopodi, crostacei ed echinodermi, per un totale di 424 specie, ognuna delle quali classificata per ordine, famiglia, genere e specie (nome scientifico), con il nome italiano corrispondente.
È la denominazione stabilita in ciascuno Stato membro che deve essere riportata sull’etichetta, sull’imballaggio o sui documenti accompagnatori fino alla vendita al consumatore finale: ogni Stato membro, peraltro, riconosce le denominazioni approvate dagli altri Stati membri nella stessa lingua (art. 4, par. 3, del Reg. n° 104/2000).
In caso di commercializzazione di specie non incluse nell’elenco approvato, il Decreto 27 marzo 2002 assegna all’autorità sanitaria di controllo (identificabile nel veterinario dell’Azienda sanitaria locale che effettua il controllo sanitario) il compito di attribuire una denominazione provvisoria, che deve essere comunicata al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali il quale provvede, entro cinque mesi, a stabilire la denominazione definitiva inserendola nell’elenco ufficiale e notificandola alla Commissione Europea (art. 2 del Reg. 2065/2001).
-
Metodo di produzione
Quest’informazione deve essere fornita, secondo il Reg. 2065/2001, mediante le indicazioni elencate dall’art. 4 in tutte le lingue degli Stati membri:
-
prodotto della pesca;
-
prodotto della pesca in acque dolci;
- prodotto di acquacoltura.
È prevista la possibilità che gli Stati membri autorizzino, qualora dalla denominazione e dalla zona di cattura risulti con chiarezza e senza possibilità di errore che si tratti di specie pescate in mare, ad omettere l’indicazione del metodo di produzione.
-
Zona di cattura
Le zone di cattura da indicare sono così individuate dall’art. 5 del Reg. n° 2065/2001:
- per i prodotti pescati in mare, in riferimento all’Allegato al Reg. n° 2065/2001, Atlantico nord- occidentale, Atlantico nord-orientale, Mar Baltico, Atlantico centro-occidentale, Atlantico centro-orientale, Atlantico sud-occidentale, Atlantico sud-orientale, Mar Mediterraneo, Mar Nero, Oceano Indiano, Oceano Pacifico, Antartico;
-
per i prodotti pescati in acque dolci, il nome dello Stato membro o Paese terzo di origine;
- per i prodotti di acquacoltura, il nome dello Stato membro o Paese terzo in cui si è svolta la fase finale di allevamento del prodotto; lo Stato membro in cui il prodotto viene venduto al consumatore finale può autorizzare l’indicazione degli eventuali altri Stati membri o Paesi terzi in cui siano avvenute altre fasi dell’allevamento.
A cura degli operatori, l’indicazione della zona di cattura può essere più precisa, con individuazione di un ambito marittimo o territoriale più ristretto (per esempio, anziché "Mar Mediterraneo", "Mar Adriatico" o "Mar Tirreno").
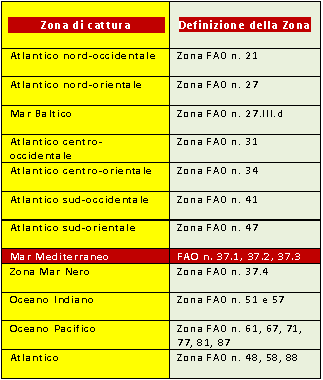
Etichettatura: zone di cattura
-
Miscugli
Secondo l’art. 6 del Reg. n° 2065/2001, in caso di vendita di miscugli di specie diverse, le indicazioni obbligatorie devono essere fornite per tutte le specie.
In caso di vendita di un miscuglio di prodotti della stessa specie ma provenienti da zone di cattura o di allevamento diverse, è necessario avvertire circa tale variabilità, indicando almeno la zona relativa alla partita più rappresentativa del miscuglio.
Se il miscuglio di prodotti della stessa specie è riferibile a metodi di produzione diversi, occorre indicare tale metodo per ogni partita.
-
Deroga
L’unica deroga prevista è relativa ai piccoli quantitativi di prodotti venduti direttamente ai consumatori dai pescatori o dai produttori di acquacoltura, a cui non si applicano le norme citate (art. 4 del Reg. n° 104/2000). L’entità di tali quantitativi deve essere stabilita dagli Stati membri, ma non devono superare il valore di 20 Euro per acquisto (art. 7 del Reg. 2065/2001).
È necessario non fare confusione fra tale deroga e quella prevista dal Decreto Legislativo n° 531/1992, che all’art. 2, comma 1, lettera p), esclude dal suo campo di applicazione, ai fini della normativa sanitaria, sia la fase di vendita al dettaglio che la vendita diretta da parte del pescatore di "piccole quantità" (poi stabilite nel quantitativo massimo di pescato di 100 Kg) al venditore al minuto o al consumatore: diverso è lo scopo della normativa in materia di etichettatura che qui esaminiamo, la quale esclude dall’obbligo delle indicazioni solamente il produttore che vende i piccoli quantitativi ai consumatori (ricordiamo che il D. Lgs. n° 109/1992, in attuazione di direttive comunitarie, comprende in questa categoria sia il consumatore finale che i ristoranti, le mense e le comunità in genere), mentre il pescatore o produttore di acquacoltura che cede quantitativi di prodotto di qualsiasi entità ai dettaglianti deve sempre procedere all’etichettatura.
-
Sanzioni
L’art. 4, 1° comma, del Decreto 27 marzo 2002 riconduce l’inosservanza delle disposizioni sopra elencate alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 18, comma 3, del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n° 109 (modificato dall’art. 8 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n° 68) per la violazione dell’art. 4 dello stesso D.Lgs. (relativo alla "Denominazione di vendita"); tale sanzione, secondo il tasso di conversione e le modalità di cui all’art. 51 del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, risulta compresa fra il minimo di Euro 516 e il massimo di Euro 3098.
Pertanto, la somma che può essere pagata in misura ridotta con effetto liberatorio, entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell’art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n° 689, è pari a Euro 1032 (doppio del minimo/terzo del massimo). L’autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi da parte dall’autore della violazione e ad emettere l’ordinanza ingiunzione in caso di mancato pagamento è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui è avvenuta la violazione.
Si precisa che per i prodotti preconfezionati la sanzione, prevista dall’art. 18, comma 2, riferibile alle altre indicazioni diverse da quelle di cui qui si è trattato (cioè: nome e sede del produttore, ingredienti, lotto, peso netto, data di scadenza, modalità di conservazione, ecc.), è più elevata, essendo compresa fra Euro 1549 ed Euro 9296; si ritiene che le due sanzioni siano applicabili anche contemporaneamente, essendo riferite a specifiche e diverse violazioni.
-
Autorità competente per il controllo
Secondo l’art. 4 comma 2, del D. M. 27 marzo 2002, l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni compete alle persone incaricate della sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti ittici di cui all’art. 21 della Legge 14 luglio 1965, n° 963 (Disciplina della pesca marittima) sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di Porto, vale a dire:
- personale civile e militare della Amministrazione centrale e periferica della marina mercantile;
-
guardie di finanza;
-
carabinieri;
-
agenti di pubblica sicurezza;
- agenti giurati nominati dalle Regioni e dalle Provincie per la vigilanza sulla pesca.
Come si vede, non è compreso il personale sanitario (veterinari e tecnici della prevenzione), che per ovvi motivi è, tuttavia, il più presente lungo la filiera del settore, esercitando, secondo le competenze rispettive di ogni figura professionale, il controllo prima della commercializzazione dei prodotti ittici e la vigilanza in tutte le fasi del commercio e della trasformazione; anche se, come abbiamo visto più sopra, proprio l’"autorità sanitaria di controllo" viene chiamata in causa ed è preposta ad assegnare le denominazioni provvisorie alle specie non comprese nell’elenco.
Ma lo stesso personale sanitario incaricato del controllo ufficiale degli alimenti non è escluso dalla possibilità di esercitare la vigilanza sull’etichettatura dei prodotti alimentari, con relativo accertamento delle violazioni, avendo anzi in materia una specifica competenza: concetto, questo, molto chiaro nella Circolare del Ministero della Sanità 6 luglio 1993, n° 27, e nello stesso Decreto Legislativo 3 marzo 1993, n° 123, che all’art. 2, comma 1, lettera h), prevede espressamente, fra le attività ispettive, la vigilanza sull’etichettatura: materia di certo preminentemente commerciale, che presenta però, innegabilmente, implicazioni di rilevanza sanitaria come più volte richiamato da circolari, note ministeriali e letteratura.
Conclusioni
Certamente siamo di fronte ad un nuovo, importante fatto storico nella tracciabilità degli alimenti.
I consumatori possono ora avere informazioni più complete circa la natura e la provenienza dei prodotti ittici, sempre che la normativa sia puntualmente e correttamente applicata da tutti gli operatori che devono garantire la trasparenza nelle transazioni commerciali ad ogni passaggio.
Nelle piccole imprese di pesca e nella piccola distribuzione possiamo aspettarci dei ritardi nell’applicazione, superabili con un piccolo impegno: infatti, non si vedono difficoltà nell’indicare il metodo di produzione e la zona di cattura, mentre per quanto riguarda le denominazioni bisogna fare uno sforzo per superare l’abitudine all’utilizzo di nomi locali e dialettali, non previsti nell’elenco ministeriale (nel quale, peraltro, non figurano — e ciò è curioso — i molluschi gasteropodi, anche se comprendono alcune specie largamente commercializzate).
Non pochi problemi crea poi la nuova regolamentazione per l’etichettatura dei miscugli di specie diverse, finora spesso indicati semplicemente — e impropriamente — come "misto" o con una terminologia relativa all’utilizzo gastronomico ("frittura", "zuppa", ecc.): può risultare infatti difficile e macchinoso elencare i nomi (nelle fasi precedenti la vendita al consumatore finale anche quelli scientifici) di tutte le specie presenti nel miscuglio, specialmente se composto da esemplari di piccola taglia.
È certo che le sanzioni previste sono degne di attenzione e rappresentano un deterrente importante nei confronti delle resistenze all’applicazione della normativa, ma è giusto escludere dal novero delle autorità competenti all’accertamento delle violazioni proprio quel personale sanitario che, come sopra già evidenziato, è indubbiamente il più presente lungo tutta la filiera ed è in grado di assicurare il controllo più capillare?
È difficile capire se possa trattarsi di una semplice dimenticanza o di un’esclusione voluta e comunque lecita (anche se, come abbiamo visto, in evidente contraddizione con altre norme vigenti), che rischia comunque di frammentare l’attività di controllo e, almeno in parte, di vanificarne l’obiettivo.
Tracciabilità: approfondimento
La normativa nazionale e comunitaria nell'ambito del regime di controllo, istituito ai sensi dei regolamenti (CE) 1224/2009 e (UE) 404/2011, disciplina la "tracciabilità" del prodotto ittico, in particolare dal momento della cattura alla prima vendita, attraverso la produzione ed il trasferimento di dati tra i diversi attori della filiera al fine di definire un valido sistema di rintracciabilità che consenta al flusso delle informazioni di seguire il prodotto fino alla vendita al dettaglio.
Ciascun operatore della filiera ittica ha l'obbligo di ottemperare, per la propria parte di competenza, alle disposizioni previste dalla normativa vigente.
Ai sensi del Titolo IV del Regolamento 1224/2009,:
- i comandati dei pescherecci di l.f.t. pari o superiore a 10 metri ed inferiore a 12 metri devono compilare il Giornale di Pesca, la Dichiarazione di Sbarco e - laddove autorizzata - la Dichiarazione di Trasbordo in formato cartaceo, utilizzando il modello previsto dall'allegato VI al Reg.(UE) 404/2011 (Circolare prot. n.19490 del 31/07/2012), che deve essere e presentato entro 48 ore dallo sbarco all'Autorità marittima competente del luogo di sbarco in doppia copia. L'Autorità marittima provvederà a trattenere una copia di quanto consegnato dal comandante o dal suo delegato per il successivo inserimento dei dati nel portale "SIAN" e a timbrare e firmare la restante copia quale ricevuta dell'avvenuta consegna.
- I comandanti dei pescherecci di l.f.t. pari o superiore a 12 metri devono compilare in formato elettronico il Giornale di Pesca, la Dichiarazione di Sbarco e - laddove autorizzata - la Dichiarazione di Ttrasbordo, utilizzando i dispositivi elettronici in dotazione ed il software appositamente realizzato.
In particolare, i dati del Giornale di Pesca in formato elettronico devono essere trasmessi almeno una volta al giorno (entro le ore 24.00), su richiesta dell'Autorità competente dello Stato membro di bandiera e in ogni caso dopo la conclusione dell'ultima operazione di pesca e prima dell'entrata in porto.
Il comandante di un peschereccio deve compilare la Dichiarazione di Trasbordo - laddove autorizzata - e trasmetterla entro 24 ore dal completamento delle operazioni di trasbordo.
Il comandante di un peschereccio (o un suo delegato) deve compilare la Dichiarazione di Sbarco e trasmetterla entro 24 ore dal completamento delle operazioni di sbarco.
Come disposto dal D.M. 1° marzo 2012 e ai sensi degli artt. 15, comma 4, 22, comma 3 e 24, comma 3 sono stati esonerati dagli obblighi di compilazione e trasmissione elettroniche rispettivamente dei dati del Giornale di Pesca, della Dichiarazione di Trasbordo e della Dichiarazione di Sbarco previsti le unità da pesca di lft inferiore a 15 metri e pari o superiore a 12 metri, previa presentazione dell'apposita dichiarazione prevista dal predetto decreto ministeriale.
Le unità da pesca che si avvalgono della facoltà di essere esonerati dagli obblighi di cui agli art. 15, comma 4, 22, comma 3 e 24, comma 3 hanno l'obbligo di compilare i modelli cartacei del Giornale di Pesca, della Dichiarazione di Trasbordo e della Dichiarazione di Sbarco secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento.
Le unità da pesca che si avvalgono della facoltà di essere esonerati dagli obblighi di cui agli art. 15, comma 4, 22, comma 3 e 24, comma 3, laddove dovessero decidere successivamente di ottemperare agli obblighi di trasmissione dei documenti di bordo elettronicamente, potranno ricevere un pc tablet in dotazione, di proprietà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, secondo disponibilità delle scorte (fino ad esaurimento scorte).
Adempimenti a carico degli operatori commerciali. Registrazione degli operatori
Ai sensi dell'art. 59 del Reg. (CE) 1224/2009 gli acquirenti in prima vendita dei prodotti della pesca e i soggetti che prendono in carico il prodotto per la messa in vendita successiva del prodotto stesso devono essere registrati.
Ai sensi dell'art. 114 del Reg.(CE) 1224/2009 è stato istituito il sito controlli www.controllopesca.politicheagricole.it [4], ove è possibile accedere alla procedura di registrazione utente e successivamente alle procedure di trasmissione dei dati di seguito specificate.
Al fine di agevolare l'accesso alle procedure informatizzate, il sito presenta una sessione FAQ ed i recapiti cui potersi rivolgere per informazioni circa gli adempimenti cui ottemperare.
Inoltre, al fine di facilitare le operazioni di inserimento dati, successive alla registrazione, sono stati pubblicati sul sito del Mipaaf manuali relativi alla gestione dati da parte degli operatori.
Ai fini della prima immissione sul mercato, i prodotti della pesca devono essere ceduti esclusivamente ad operatori registrati.
Sono esonerati dagli obblighi di registrazione gli acquirenti dei prodotti della pesca di peso non superiore a 30 kg che non vengono successivamente immessi sul mercato, ma che sono esclusivamente destinati al consumo privato.
Etichettatura: approfondimento
I prodotti ittici della pesca e dell'acquacoltura freschi, refrigerati e congelati posti in vendita al dettaglio per il consumo finale debbono obbligatoriamente essere etichettati con le seguenti informazioni:
- Denominazione commerciale della specie
- Denominazione scientifica della specie (dal primo gennaio 2012 l'indicazione della denominazione scientifica è obbligatoria. Non è obbligatoria l'indicazione della stessa in etichetta o sul cartello di vendita poiché l'art. 68 par. 2 del Reg. 404/2011 consente di indicarla anche attraverso informazioni commerciali come cartelloni pubblicitari o poster).
- Metodo di produzione (pescato, pescato in acque dolci o allevato)
- Zona di cattura/paese di allevamento
Per il prodotto pescato si può anche indicare la Zona Fao, ma deve essere esposta la tabella esplicativa:
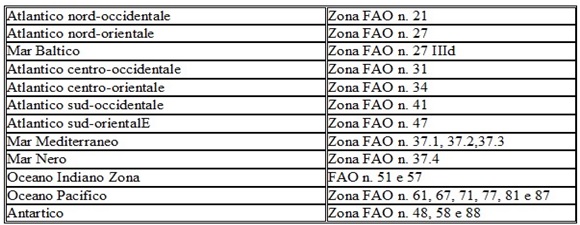
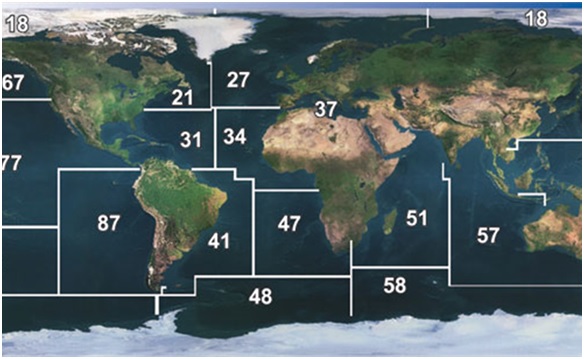
Se il prodotto è surgelato, deve contenere espressa indicazione, con richiamo al divieto di ricongelamento (la surgelazione è un procedimento che avviene a livello industriale, perché comporta un raggiungimento di temperature tali per cui sono necessari macchinari appositi; la congelazione invece è un procedimento "casalingo" , che può essere effettuato nel freezer di qualsiasi cucina).
- Esempio di corretta etichettatura: Nasello pescato in Mediterraneo – Orata allevata in Grecia.
I ristoranti sono assimilati al consumatore finale (l'acquirente), quindi non devono etichettare l'eventuale prodotto esposto ma conservare i documenti giustificativi d'acquisto, per assicurarne la tracciabilità e la sicurezza di provenienza da fonti che non siano – per esempio - la pesca sportiva.
Un prodotto della pesca preparato già sottoposto a cottura (trasformato) è da considerarsi escluso dal campo di applicazione del Regolamento n. 104/2000: non sono quindi necessarie le informazioni obbligatorie da questo previste e l'etichettatura può riportare come ingrediente la denominazione "pesce", come si è visto prevista dal D Lgs. n. 109/1992, seguita dalla percentuale se l'ingrediente "pesce" è un ingrediente caratterizzante evidenziato (es. denominazione "crocchette di pesce", "bastoncini di pesce"). La suddetta esclusione dal campo di applicazione riguarda anche i prodotti della pesca "altrimenti preparati o conservati con procedimenti diversi da quelli previsti nel Capitolo 3 della nomenclatura combinata". Nel caso, invece, di prodotti della pesca preparati, per esempio affettati, sfilettati o tritati, anche se uniti ad altri ingredienti, non sottoposti a un trattamento di trasformazione ma solamente conservati mediante il freddo (refrigerati o congelati), rientrando gli stessi nei codici di Nomenclatura Combinata citati dal Reg. n. 104/2000, si ritiene che trovi piena applicabilità il regolamento stesso, con il conseguente obbligo di riportare in etichettatura come ingrediente, anziché la generica indicazione di categoria "pesce", il nome della specie ittica, il metodo di produzione (pesca o allevamento) e la zona di cattura.
Sentenze di merito e di legittimità
.png)
Alimenti - Frode
- Lista vivande – omessa indicazione di prodotto surgelato – reato di frode – non integrazione
Non sussiste il reato di frode nell’esercizio del commercio in ipotesi di omessa indicazione nella lista vivande di “alimenti surgelati” (c.d. munù), qualora il consumatore possa verificare personalmente, in quanto visibili, la tipologia e le caratteristiche dei prodotti somministrati.
Pret. Orvieto, 29 giugno 1994 – Riviste Rass. Giur. Umbra
- Lista vivande – omessa indicazione di prodotto surgelato – reato di frode – non integrazione
La detenzione di alimenti surgelati in un ristorante, conservati in apposito surgelatore, senza la relativa dicitura sulla lista del giorno integra il tentativo del reato di frode nell’esercizio del commercio, a nulla rilevando la mancata identificazione di soggetti passivi o l’assenza di clienti nell’ora del sopralluogo.
Cass. Pen., 3 marzo 1984 – Riviste: cass. Penale
- Prodotti alimentari scaduti – Offerte al pubblico – Tentativo di frode in commercio
“Costituisce tentativo di frode in commercio esporre sui banchi di un negozio prodotti alimentari scaduti con etichetta alterata o sostituita”. Con sentenza del 21 dicembre 2000, n. 28 le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione riconoscono che costituisce tentativo di frode in commercio – ex. art. 515 c.p. – esporre sui banchi di un negozio prodotti alimentari scaduti con etichetta alterata o sostituita. L’art. 56 c.p. richiede per la punibilità del delitto tentato che gli atti posti in essere dall’agente siano idonei e diretti in modo non equivoco alla commissione del delitto; esisteva, però, un contrasto giurisprudenziale sulla necessità o meno di un rapporto diretto tra venditore ed acquirente per la configurabilità del tentativo di frode in commercio, perciò la questione è stata rimessa alla S.U. Una parte della giurisprudenza riteneva che il tentativo fosse configurabile solo in presenza di una contraffazione idonea ed inequivocabilmente predisposta alla consegna di merce diversa a chi intendeva in concreto acquistarla (Cass., sez. III, 13 ottobre 1994); un’altra parte riteneva invece sufficiente la semplice offerta al pubblico (Cass., sez. III, 3 novembre 1999). Le Sezioni Unite “hanno sposato” quest’ultima tesi affermando che se i prodotti alimentari scaduti con etichetta alterata o sostituita vengono esposti sui banchi d’esercizio o sono comunque offerti al pubblico la condotta posta in essere dall’esercente l’attività commerciale deve considerarsi idonea e diretta in modo non equivoco alla vendita della merce ai potenziali acquirenti. Il tentativo non è viceversa configurabile, per l’assenza del requisito dell’univoctà degli atti, ove i prodotti con etichetta alterata o sostituita siano semplicemente detenuti all’interno dell’esercizio o in un deposito senza essere esposti o in qualche modo offerti al pubblico.
Cass. Penale. S.U., sent. 21 dicembre 2000, n. 28
- Cassazione Penale Sez. III, sent., n. 9229 del 13 ottobre 1997. Fattispecie: - lettera b)
In materia di alimenti, perché ricorra il cattivo stato di conservazione – elemento costitutivo del reato contravvenzionale di cui all’art. 5 della Legge 30 Aprile 1962, n. 283 – non occorre che la sostanza alimentare risulti alterata. E’ sufficiente che nelle modalità di conservazione del prodotto (sistemi di confezionamento, luogo di conservazione, esposizione all’aria o al sole, stivaggio, trasporto, ecc.) non vengono osservate le precauzioni igienico-sanitarie dirette ad evitare che il prodotto stesso possa subire un’alterazione che ne comprometta la genuinità o commestibilità, precauzioni che possono essere prescritte da leggi o regolamenti o precauzioni dettate dall’art. 47 del D.M. 20 gennaio 1927 in ordine alla conservazione dell’acqua minerale – norma tuttora in vigore perché non abrogata, né espressamente né implicitamente, dal D.L. 25 gennaio 1992, n. 105 o dal D.M. 12 novembre 1992, n. 542 – determina la sussistenza del suddetto reato. (Nella fattispecie, è stato ritenuto configurabile il reato in questione in relazione alla detenzione, per la vendita, di bottiglie di acqua minerale depositate in luogo esposto al sole).
Cass, sez. III, sent. N. 9229 del 13.10.1997 (cc. del 19.09.1997), Nastasi (rv. 208679).
- Cassazione Penale Sez. III, sent., n. 9338 del 31 agosto 1994. Fattispecie: - lettera b)
In materia di alimenti, il reato di cui all’art. 5 della Legge 30 Aprile 1962, n. 283, lett, b), si perfeziona con la detenzione, da parte del gestore-venditore, della sostanza alimentare, essendo tale detenzione correlata alla vendita ed alla somministrazione. Ne deriva che è irrilevante l’assunto, secondo cui il prodotto venga sottoposto a controllo prima dell’emissione al consumo. (Nella specie, trattavasi di prodotto di validità scaduta, detenuto nel magazzino-dispensa di un ristorante).
Cass., sent. N. 9338 del 31.08.1994 (cc. del 21.06.1994), Sacchi (rv. 198799).
- Cassazione Penale Sez. VI, sent., n. 660 del 25 gennaio 1993. Conservazione di alimenti a temperatura non consentita
La conservazione prevista dall’art. 5 della Legge 30 Aprile 1962, n. 283, lett, b), costituisce una fattispecie di reato di pericolo, nel senso che essa si realizza mediante la condotta di conservazione del prodotto idonea ad evitare possibili condizioni di “alterazione” la cui effettiva realizzazione comporta la presenza di distinte ipotesi di reato. Cosicché l’inosservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie intese a garantire la buona conservazione del prodotto è già di per sé sufficiente per integrare gli estremi della detta contravvenzione. (Nella fattispecie, relativa a conservazione per la vendita di dolci alla crema a temperatura non consentita dall’art. 31 del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato di cui all’art. 5 della Legge 30 Aprile 1962, n. 283, lett, b), anche se il prodotto offerto in vendita non risultava alterato).
Sez. VI, sent. N. 6608 del 25.01.1992 (cc. del 07.12.1992), Tinca (rv. 193468).
- Cassazione Penale Sez. VI, sent., n. 3802 del 21 gennaio 1993. Fattispecie: - lettera b)
In materia di alimenti, l’art. 5 della Legge 30 Aprile 1962, n. 283, lett, b), delinea una contravvenzione integrata dall’inosservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie intese a garantire la buona conservazione del prodotto. Trattasi di reato di pericolo, per integrare il quale non è necessario che il “cattivo stato di conservzione” abbia danneggiato o alterato il prodotto.
Sez. VI, sent. N. 3802 del 21.01.1993 (ud. del 27.10.1992), Castigiole (rv. 192929).
Gestione comune delle risorse
Con la costituzione dell’Unione Europea sono stati introdotti regolamenti e direttive comunitarie che hanno modificato la disciplina dell’attività di pesca, considerando tra l’altro che in caso di Regolamenti, questi “prevalgono” sulla normativa nazionale dei singoli Stati, ad esclusione delle norme che per la loro formulazione risultano più restrittive di quelle comunitarie. In particolare il Regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio del 27 giugno 1994 ha stabilito nuove “taglie minime” per la maggior parte delle specie ittiche, in quanto ha introdotto delle misure superiori a quelle previste dalla normativa nazionale; oltretutto con successive modifiche sono stati banditi alcuni sistemi di pesca, spesso facenti parte della tradizione locale quale ad esempio la sciabica da spiaggia. Fattore di notevole rilevanza da notare è l’assenza di una qualsiasi tolleranza di prodotto sottomisura, mentre per la normativa nazionale era consentito il 10% del peso sul totale del pescato sbarcato dalla singola unità.
Anche per le specie che hanno taglia minima nazionale non esiste più la tolleranza sul sottomisura (D.L. 8 aprile 2008, n. 59, convertito in legge con Legge 6 giugno 2008, n. 101). Lo sbarco, il trasporto, il trasbordo e la commercializzazione di esemplari sottomisura rimane solo per le specie (e nelle percentuali) per cui ciò sia chiaramente specificato nella normativa comunitaria (ad esempio, Tonno Rosso, Reg. (CE) 302/2009). Questa particolarità agevola notevolmente l’attività di controllo e soprattutto di repressione delle violazioni in materia, in quanto in qualsiasi punto della filiera commerciale, sbarco, trasporto, detenzione e commercio non è più necessario dover risalire all’intera partita della specie incriminata per stabilire se la percentuale di sottomisura sia superiore al 10% - come in passato - ma è sufficiente anche un unico esemplare di quel singolo quantitativo di prodotto rinvenuto sia di dimensioni inferiori a quelle previste dalle norme comunitarie, per poter intraprendere l’azione repressiva nei confronti del possessore.
Sta quindi al “buon senso” e alla “esperienza” dell’operatore saper valutare la gravità dell’infrazione e soprattutto la volontarietà dell’azione legale, prima di decidere se procedere ai previsti atti di polizia: identificazione (ed elezione di domicilio), dichiarazioni spontanee dell’autore del fatto, sequestro penale del prodotto, rilievi fotografici, ecc e notizia di reato all’A.G.
Per contro la normativa nazionale prevede all’art. 87 del D.P.R. 1639/68 la tolleranza del 10% del peso totale del pescato sbarcato dalla singola unità. Di conseguenza applicando questa norma la contestazione può essere effettuata soltanto al momento dello sbarco del prodotto, infatti la Corte Suprema di Cassazione con la Sentenza n. 8690/1998 ha stabilito che “il commerciante che acquista il prodotto non può avere cognizione del rispetto del divieto imposto dalla legge non disponendo dei dati relativi alla quantità complessiva originaria e, di conseguenza, non risponde del reato di cui all’art. 15 comma 1 lettera c), mancando la prova sia dell’elemento materiale, che di quello intenzionale”.
La creazione dell’Unione Europea ha anche significato libero mercato delle merci e condivisione delle risorse comuni. Questi principi fondamentali sono alla base di una politica comune della pesca, con una gestione delle risorse che fosse condivisa nello spirito dai singoli Stati e che è stata materializzata con l’emanazione di numerosi provvedimenti volti alla tutela delle specie ittiche, tramite anche degli atteggiamenti repressivi uniformi nell’ambito della Comunità Europea; a tale scopo con il Regolamento (CE) 2847/93, di cui si è detto in precedenza, si sono volute individuare le violazioni ritenute più gravi ed invasive dell’ecosistema, prevedendo un resoconto finale da parte di ogni singolo Stato sulla propria attività di repressione svolta, al fine di individuare eventuali difformità di applicazione della normativa nelle singole realtà locali e volendo individuare metodi coercitivi sempre più efficaci ed idonei alla progressiva riduzione dei comportamenti illeciti riscontrati.
Sempre per verificare la corretta applicazione delle normative comunitarie sono stati istituti i “Centri di Controllo Pesca” (D.P.R. 424/98) ed il “Nucleo centrale Ispettori Pesca” (D.M. 12.09.2002) con lo scopo di coordinare l’attività di controllo in ambito nazionale, coadiuvare le ispezioni disposte dall’Unione Europea ed effettuate da personale specializzato di altri Stati comunitari ed inoltre, partecipare alle medesime ispezioni realizzate all’estero sia a bordo di unità italiane anche in acque non comunitarie, sia su unità straniere in acque comunitarie.
Anche la tecnologia è stata messa al servizio dell’attività di vigilanza tramite l’introduzione con il Regolamento (CE) 1489/97 dell’apparato radioelettrico “Blue Box”, che, come abbiamo avuto modo di dire in precedenza, rappresenta una vera spina nel fianco per le condotte illecite, in particolare per ciò che concerne gli sconfinamenti in acque territoriali straniere od il superamento dell’abilitazione consentita.
Questo apparecchio consente di individuare la reale posizione delle unità che lo hanno in dotazione, avendo quindi la possibilità di contestare direttamente eventuali violazioni accertate esclusivamente dal terminale, senza dover obbligatoriamente assistere di persona alla condotta illecita.
Tale tecnologia se da un alto consente un notevole risparmio di energie umane ed economiche, dall’altro garantisce l’inconfutabilità della violazione e quindi la quasi certezza della “condanna” per ogni attività illecita rilevata dallo strumento.