Protezione dell’ambiente marino dai rifiuti prodotti da navi
I rifiuti sono ormai da anni al centro di tematiche politico-ambientali a livello internazionale ed europeo. Non a caso i diversi programmi europei d'azione per l'ambiente hanno posto al centro dell'attenzione proprio il tema rifiuti e l'Europa ha promosso e integrato una serie di normative di settore allo scopo di raggiungere una maggiore tutela dell'ambiente e della salute umana. La consapevolezza del valore economico, sociale e culturale dell’ambiente marino ed il dovere di preservare un così grande patrimonio dell’umanità ha spinto gli Stati a creare uno strumento conforme al diritto internazionale in grado di dettare i principi generali verso cui i medesimi devono uniformare le proprie capacità di protezione e preservazione. Inoltre, la necessità di una stretta cooperazione fra gli Stati e le organizzazioni internazionali che li concentri a livello regionale e locale, rappresenta un nuovo “modus operandi” per il conseguimento di risultati soddisfacenti in termini di protezione, preservazione e conservazione.
L’esigenza di affrontare la questione della tutela dell’ambiente marino da varie forme e fonti di inquinamento è sorta contestualmente al processo di industrializzazione e il crescente uso del mare come via di comunicazione nonché di trasporto, soprattutto di prodotti ad alta potenzialità inquinante. Molto si è fatto a livello legislativo per proteggere, preservare e conservare l’ambiente in generale e per informare e stimolare il pubblico ad una nuova mentalità di precauzione e preservazione dell’ambiente marino e terrestre, soprattutto in materia di «gestione dei rifiuti», la quale necessitava la definizione di regole comuni per la corretta raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi che, se non opportunatamente gestiti, costituiscono un forte impatto nell’ecosistema marino.
Con l’evolversi della normativa comunitaria e conseguentemente quella nazionale, il quadro riguardante le modalità di gestione delle aree portuali sta assumendo contorni sempre più netti e precisi. In materia di gestione dei rifiuti delle navi in ambito portuale con la Direttiva n. 2000/59/CE il legislatore ha regolamentato a livello europeo una tematica, quella appunto dei "rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico", divenuta inattuale e arretrata rispetto alla situazione presente in quanto sono aumentati i traffici delle navi nei mari e di conseguenza sono aumentati i rischi di incidenti e sversamenti oltre al problema dei rifiuti in crescente aumento. Fino a questo momento l’unica regolamentazione di riferimento era la Convenzione di Londra del 2 Novembre 1973, MARPOL 73/78, obsoleta al riguardo in quanto realizzata basandosi su traffici allora molto più limitati rispetto agli attuali e quindi con la possibilità di pericoli per l’ambiente minori. La MARPOL è stata la prima, a livello internazionale, a fissare un insieme di regole e disposizioni volte a prevenire l’inquinamento marino provocato da idrocarburi, da sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa, da sostanze pericolose trasportate in appositi contenitori, da acque nere e rifiuti e ad evitare l’inquinamento atmosferico causato da navi. Nel corso degli anni questa Convenzione ha assunto un ruolo di primaria importanza per la tutela ecologica dei mari; essa cerca di regolamentare tutte quelle sostanze che, immesse nell’ambiente marino, possono mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse biologiche e all’ecosistema. In tal senso, la Convenzione in esame si segnala per avere introdotto una dettagliata normativa diretta ad eliminare, ridurre e prevenire l’inquinamento marino derivante dall’immissione volontaria o accidentale di tutte le sostanze che siano in grado di nuocere o comunque mettere in pericolo la salute umana, le risorse biologiche, le bellezze naturali e, in generale, le attività connesse con i legittimi usi del mare. Il Governo italiano ha dato attuazione alla Direttiva CE n. 59/2000 relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182, che abroga l’art. 19, comma 4 bis del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22. Tale Decreto Legislativo ha costituito uno strumento normativo attraverso il quale il legislatore, su proposta del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha introdotto una disciplina ad hoc sui rifiuti riferendosi al contesto marittimo e portuale. Il decreto in questione è composto di 16 articoli e 4 allegati. Obiettivo primario che il legislatore intende perseguire con l’emanazione del D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 182 è ridurre gli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che scalano i porti nazionali. Non ultimo, migliorare la disponibilità e l’utilizzo degli impianti portuali di raccolta dei citati rifiuti e residui.
Per questo motivo il Decreto 182/2003 impone alle Autorità portuali[1] [1] l’obbligo di elaborare un «piano di raccolta e gestione dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi» e di dotarsi di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti e dei residui del carico adeguati in relazione alla classificazione del porto o del traffico registrato nell’ultimo triennio.
- Tale piano deve contenere una serie di punti riconducibili a tre distinte fasi:
- la composizione del quadro conoscitivo relativo alle attuali modalità di gestione dei rifiuti;
- la pianificazione del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti
- la definizione del modello gestionale organizzativo e deve essere aggiornato ed approvato almeno ogni tre anni, in coerenza con la pianificazione regionale in materia di rifiuti e comunque in presenza di significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto.
L’entrata in vigore del D. Lgs. 182/03, ha provocato notevoli disagi e disguidi, infatti dal 2003 ad oggi sono state innumerevoli le interpretazioni e le deroghe illegittime non conformi alla legislazione vigente. Precedentemente all’entrata in vigore del D. Lgs. 182/03, la normativa nazionale in materia portuale si era pronunciata con la legge 28 gennaio 1994, n. 84, la quale si è resa necessaria in quanto il Codice della navigazione non appariva più idoneo, da solo, a definire adeguatamente il bene porto. Essa ha profondamente mutato il quadro normativo e culturale della pianificazione delle aree portuali, nella consapevolezza dell’importanza da questa assunta per uno sviluppo coerente delle dinamiche complessive dei porti, delle azioni imprenditoriali che in essi si sviluppano e del rinnovato rapporto con la città.
La legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale ha previsto l’istituzione per i porti maggiori delle Autorità Portuali, enti aventi personalità giuridica che svolgono attività sostitutiva e integrativa e, in ogni caso, ausiliaria dello Stato, perseguendo la finalità di attuare la gestione dei porti con la partecipazione delle strutture pubbliche e private interessate. Per i rimanenti porti vengono mantenute le Autorità Marittime, organi periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- Detta legge detta inoltre nuove norme nelle seguenti materie:
- la classificazione dei porti, con connessa nuova normativa in materia di piani regolatori portuali e di realizzazione di nuove opere;
- le prestazioni dei lavoratori portuali (operazioni portuali), superando il regime della riserva di cui all’art. 110 del codice della navigazione e lo svolgimento delle operazioni portuali e delle concessioni di aree portuali e banchine.
In seguito divenendo necessario adottare misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali, quali scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione, assicurando una adeguata protezione dal rischio di introduzione nel territorio nazionale di malattie degli animali, con particolare riguardo alle pesti suine, attraverso tali rifiuti, quando sbarcati dai citati mezzi di trasporto e considerata, altresì, l’esigenza di favorire l’impiego di vasellame e stoviglie riutilizzabili nonché l’effettivo utilizzo di tali beni, in attuazione dell’obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti, il Ministero della Sanità di concerto con il Ministro dell’Ambiente un decreto concernente le “Misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali”.
Quindi, concludendo, a partire dal 1994 in poi l’ambito portuale è diventato sempre più una realtà concreta e reale a cui si sta cercando di dare regole e procedure operative atte a difendere l’ambiente marino e terrestre all’interno del quale si sviluppa. L’inquinamento e i rifiuti superano la capacità del pianeta di assorbirli e trasformarli e produrre meno rifiuti è diventata una necessità improrogabile, con la quale tutti dobbiamo fare i conti in quanto dobbiamo avviarci verso uno sviluppo più sostenibile delle risorse, dove per sviluppo sostenibile si deve intendere una forma di sviluppo non solo economico ma anche sociale in cui la crescita economica avviene entro i limiti delle possibilità ecologiche degli ecosistemi e della loro capacità di soddisfare i bisogni delle generazioni future.
La gestione dei rifiuti delle navi è una tematica molto complessa in quanto poco si sa su quest’argomento anche perché ogni Porto è una realtà a sé e non esistono dati globali sia a livello nazionale che a livello comunitario. A livello legislativo solo da pochi anni si è affrontato il problema con un’ottica diversa, con l’obiettivo di promuovere il rispetto dell’ambiente e l’incentivo di sviluppare questo ambito per ricavare un guadagno e sfruttare anche i rifiuti delle navi come “risorsa” e non come semplici rifiuti da distruggere. I dubbi e i problemi affrontati con l’entrata in vigore della nuova normativa, a partire dalla Legge 28 gennaio 1994, n. 84 per arrivare al Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182, sono stati tanti e tanti ancora destano problemi proprio perché si è andato a legiferare e rinnovare un ambito rimasto arretrato nel tempo e che necessitava di un miglioramento e di una spinta verso una politica maggiormente volta al rispetto dell’ambiente.
[1] [1] Le Autorità Portuali istituite sono quelle per i porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste, Venezia.
Il Servizio di Gestione dei Rifiuti
Le problematiche connesse alla produzione dei rifiuti hanno assunto, negli ultimi decenni, proporzioni sempre maggiori anche in relazione al miglioramento delle condizioni economiche, al veloce progredire dello sviluppo industriale, all’incremento della popolazione e delle aree urbane.
Il «Servizio di Gestione dei Rifiuti» si è, negli ultimi decenni, particolarmente evoluto con l’inserimento di nuovi e più complessi interessi pubblici da tutelare. Si è, infatti, assistito al passaggio da un «sistema a filiera semplice», in cui l’igiene urbana era l’unico interesse tutelato ad un «sistema a filiera complessa», in cui all’igiene urbana si è aggiunta l’esigenza di ridurre l’impatto ambientale, attraverso l’attività di recupero e la limitazione dello smaltimento dei rifiuti in discarica.
La gestione dei rifiuti è regolata in Italia dal D.lgs. n. 152/2006 e successive modif. (noto come “Codice dell’ambiente”).che recepisce la principale normativa europea in materia di rifiuti. Il decreto, nella parte IV, "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" (articoli da 177 a 266), contiene una dettagliata disciplina in materia di rifiuti e prevede l'abrogazione di taluni provvedimenti, tra cui il D.lgs. n. 22/97 (cd. Decreto Ronchi) che, per lungo tempo, ha rappresentato l'unica legge di riferimento.
Il Codice dell’ambiente è stato integrato e modificato dal D.lgs. 4/2008, che ha apportato considerevoli modifiche alla disciplina sulla gestione dei rifiuti urbani tra le quali:
- potenziamento della raccolta differenziata e la previsione dei centri di raccolta;
- introduzione, per la prima volta, del principio di gestione integrata dei rifiuti;
- l’istituzione di un nuovo ente, l’Autorità d’ambito (c.d. Aato), per l’organizzazione, l’affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- rivisitazione della tariffa rifiuti.
La normativa, in continua evoluzione, ha portato ultimamante alla emanazione del D.lgs. 3 dicembre 2010 n. 205 intitolato: “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiutie che abroga alcune direttive”con cui lo stato Italiano nel recepire l’ultima “direttiva-quadro” sui rifiuti (2008/98/CE), riscrive alcune regole-cardine della materiamodificando le disposizioni, contenute nel “D. Lgs n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, sulla gestione dei rifiuti senza incidere però sulla bonifica dei siti inquinati. Il decreto rappresenta la seconda importante modifica della Parte IV relativa alla gestione dei rifiuti, dopo la prima modifica apportata dal D. Lgs. 4/2008. Si compone di 39 articoli e 6 allegati, modifica diversi passaggi della precedente normativa rifiuti. Alcuni di queste modifiche interessano gli aspetti di ordine generale sul tema dei rifiuti, altre invece coinvolgono direttamente le modalità di gestione dei rifiuti da parte delle imprese, introducedo, pertanto, una serie di novità che riguardano la gerarchia della gestione dei rifiuti. Una gerarchia che se pur riconfermata, nel'individuare nell'ordine la prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento viene innovata con l'inserimento del principio del "ciclo di vita" dei rifiuti che rende possibile in certi casi, discostarsi dall'ordine di priorità. Le novità riguardano anche l'introduzione della definizione di preparazione al riutilizzo e la previsione di nuove disposizioni che riguardano direttamente il principio di prevenzione (primo "step" della gerarchia).
Una corretta gestione dei rifiuti dovrebbe, infatti, passare in primo luogo attraverso la politica di prevenzione della produzione dei rifiuti[1] [1], in secondo luogo attraverso la preparazione per riutilizzo (ossia le "operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui i prodotti o i componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento"), in terzo attraverso il riciclaggio (ossia "qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini."), in quarto attraverso il recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia ed in ultima istanza attraverso lo smaltimento.
Per quanto riguarda la «prevenzione» della produzione dei rifiuti il legislatore oltre a introdurre il programma nazionale di prevenzione che deve essere varato e adottato dal Ministero dell'ambiente entro il dicembre 2013, punta il dito sulla prevenzione quantitativa e qualitativa affermando e chiamando in causa la responsabilità del produttore.
Inserisce quindi un nuovo articolo «Responsabilità estesa dei produttori» (articolo 178-bis) con l'intento di rafforzare la prevenzione e facilitare l'utilizzo efficiente delle risorse durante l'intero ciclo di vita comprese le fasi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, evitando di compromettere la libera circolazione delle merci sul mercato.
Prevede inoltre la possibilità da parte del Ministero dell'Ambiente di poter adottare - con uno o più decreti aventi natura regolamentare - le modalità e i criteri di introduzione della responsabilità estesa del produttore del prodotto. Il produttore è inteso come "qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti, nell'organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, e nell'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo il loro utilizzo".
Ai medesimi fini potranno anche essere adottate - con uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente con il Ministero dello Sviluppo Economico - le modalità e i criteri di gestione dei rifiuti e della relativa responsabilità finanziaria dei produttori del prodotto. Potranno essere indicate le modalità di pubblicizzazione delle informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile; i criteri della progettazione dei prodotti volta a ridurre i loro impatti ambientali e a diminuire o eliminare i rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti.
La disciplina prevede, inoltre, una serie di divieti e obblighi a carico dei produttori e detentori di rifiuti e dei soggetti che esercitano attività professionali attinenti ai rifiuti, che comprendono l'obbligo di autorizzazione per la gestione di impianti fissi e mobili di gestione dei rifiuti, il divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi (art. 187, D.Lgs. 152/2006), l'obbligo di tenuta di un formulario di identificazione per il trasporto e di un registro di carico e scarico, la compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (artt. 189, 190 e 193, D.Lgs. 152/2006), l'iscrizione all'Albo gestori rifiuti.
.png)
[1] [1] La prevenzione dei rifiuti consiste in un insieme di politiche volte a disincentivare, penalizzare economicamente o addirittura vietare la produzione di materiali e manufatti a ciclo di vita molto breve e destinati a diventare rifiuti senza possibilità di riuso. Soggetti interessati possono quindi essere tanto le imprese quanto i comuni cittadini, incentivati a ridurre a monte la produzione dei rifiuti, ad effettuare la raccolta differenziata. Oltre ad uno stimolo "etico", tali soggetti possono anche essere incentivati da una riduzione della TARSU, ad esempio quando ricorrano al compostaggio domestico (si consideri che la frazione organica è comunque una parte molto significativa dei rifiuti delle famiglie).
Principali modifiche apportate alla parte IV del Testo unico ambientale (Dlgs 152/06)
Il Dlgs 205/2010 che recepisce la Direttiva europea 2008/98 e modifica la parte IV del cosiddetto Testo unico ambientale (Dlgs 152/06) introduce una serie di novità che riguardano la «gerarchia» della gestione dei rifiuti. Una gerarchia che se pur riconfermata, nell'individuare nell'ordine la prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento viene innovata con l'inserimento del principio del "ciclo di vita" dei rifiuti che rende possibile in certi casi, discostarsi dall'ordine di priorità. Le novità riguardano anche l'introduzione della definizione di preparazione al riutilizzo e la previsione di nuove disposizioni che riguardano direttamente il principio di prevenzione (primo "step" della gerarchia). Uno degli aspetti innovativi di maggior interesse riguarda l'inserimento del «SISTRI» nel Codice ambientale e le relative sanzioni.
► Rimandando alla lettura del decreto correttivo, le principali modifiche sono le seguenti:
- articolo 10 del D.Lgs n. 205/2010: apporta modifiche all'articolo 183 del D.Lgs n. 152/2006 sostituendolo e definendo alla lettera n) il concetto di "gestione" come: “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario”; si considerano quindi gestori di rifiuti pure i commercianti e gli intermediari;
- articolo 12 del D.Lgs n. 205/2010: aggiunge nel D.Lgs n. 152/2006 l’articolo 184-bis che definisce il “Sottoprodotto” e l’articolo 184-ter che sancisce la “Cessazione della qualifica di rifiuto”;
- articolo 13 del D.Lgs n. 205/2010: sostituisce l’articolo 185 del D.Lgs n. 152/2006 stabilendo delle esclusioni, dall'ambito di applicazione della Parte quarta del codice ambientale, tra le quali si ricorda: “i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/Ce della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni”;
- articolo 15 del D.Lgs n. 205/2010: sostituisce l’articolo 187 del D.Lgs n. 152/2006 rubricato “Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi” in cui il divieto fa riferimento al concetto “differenti caratteristiche di pericolosità” anziché a quello precedente di categorie diverse di rifiuti pericolosi;
- articolo 16 del D.Lgs n. 205/2010, modifica i seguenti articoli del D.Lgs n. 152/2006:
- articolo 188 “Responsabilità della gestione dei rifiuti”
- articolo 189 “Catasto dei rifiuti”
- articolo 190 “Registri di carico e scarico”
- articolo 193 “Trasporto dei rifiuti”;
- articolo 28 del D.Lgs n. 205/2010: inserisce l’articolo 214 bis al D.Lgs n. 152/2006 rubricandolo “Sgombero neve” stabilendo come le: “1. Le attività di sgombero della neve effettuate dalle pubbliche amministrazioni o da loro delegati, dai concessionari di reti infrastrutturali o infrastrutture non costituisce detenzione ai fini della lettera a) comma 1 dell'articolo 183."; cioè non costituiscono “detenzione di rifiuti”;
- articolo 36 del D.Lgs n. 205/2010: inserisce l’articolo 260-bis al D.Lgs n. 152/2006 rubricandolo “Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti” prevedendo un inasprimento – dal 01.01.2011 - di sanzioni amministrative pecuniarie (sino ad € 93.000,00) per i soggetti che, obbligati, ometteranno di iscriversi al Sistri;altresì, introducendo l’obbligo di tenere il registro di carico e scarico per le imprese e gli enti che trasportano e raccolgono i propri rifiuti speciali non pericolosi.
In particolare, torna in vigore l’obbligo di tenere un «Registro di carico e scarico dei rifiuti non pericolosi», per ciascun cantiere in cui si opera; il Dlgs 205/2010 infatti modifica la Parte Quarta del Codice Ambiente (Dlgs 152/2006), coordinandola con il sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI che entrerà in vigore il 1° gennaio 2011; con una modifica all’articolo 212, comma 8, del Codice Ambiente, si dispone che chi intenda raccogliere e trasportare i propri rifiuti non pericolosi, non aderendo al sistema SISTRI, dovrà dotarsi di un registro di carico e scarico. Le imprese che producono meno di dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi all’anno, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri anche tramite associazioni imprenditoriali o società di servizi. Il registro dovrà essere vidimato dalle Camere di commercio e gestito con le stesse procedure dei registri IVA. Le informazioni contenute nei registri devono essere rese disponibili in qualunque momento all’autorità di controllo. I registri vanno conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione.
La nozione di rifiuto
La natura non conosce rifiuti, intesi come materiali che non possano venir costruttivamente assorbiti e riutilizzati in qualche altro posto nel sistema naturale, ora o in futuro. I rifiuti pertanto rappresentano una delle principali pressioni create sull’ambiente dall’uomo e soprattutto dalle sue organizzazioni più industrializzate. L’utilizzo poco efficiente delle risorse naturali ha portato come principale conseguenza la creazione di grandi quantitativi di materiali non più riutilizzabili né dai sistemi industriali, né da quelli naturali e si sono accumulati creando nel tempo notevoli problemi ed inquinamenti. Con il passare del tempo e con il diffondersi di una sempre maggiore consapevolezza dei problemi derivanti dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti è nata l’esigenza di regolamentare con strategie, norme e piani i flussi di materiali in uscita dai nostri sistemi produttivi e dalle nostre case, cercando di prevenirne la produzione e la pericolosità e cercando di gestirli, una volta prodotti, privilegiando il recupero allo smaltimento.
Prima di passare ad un'analisi dettagliata del sistema sanzionatorio in materia di rifiuti, è indispensabile affrontare le problematiche inerenti alla definizione stessa di rifiuto. E’ evidente come il corretto inquadramento della nozione di rifiuto sia di fondamentale importanza per l’individuazione delle sostanze che devono sottostare alle disposizioni in materia. Secondo la definizione che viene ricalcata nell'art. 183 comma 1 (definizioni) del Testo Unico sull'Ambiente, deve intendersi rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A della parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi". Dalla lettura della definizione si ricava che l’elemento centrale della definizione di rifiuto è contenuta nell’ultima parte, laddove viene fatto riferimento alla condotta del detentore ed al significato da attribuire al termine“disfarsi”. La definizione di rifiuti rimane quindi fondata, come con il precedente Decreto “Ronchi”, sul concetto di “disfarsi”, che costituisce una condizione necessaria e sufficiente perché un oggetto, un bene o un materiale sia classificato come rifiuto. L’individuazione del significato e della portata di tale azione ha determinato, nel tempo, un acceso di battito giurisprudenziale e dottrinario mai sopito e destinato a suscitare analogo interesse.
Le incertezze nell’individuazione dell’ambito di operatività della definizione di rifiuto, hanno determinato il formarsi di due diversi approcci interpretativi, il primo dei quali privilegia il dato soggettivo (dato dal fatto che il proprietario si sia disfatto dell'oggetto, o che abbia deciso di farlo o vi sia tenuto), mentre il secondo valorizza quello oggettivo (consistente nell'inserimento nell'elenco di cui all'allegato A). Secondo la «teoria soggettiva» della nozione di rifiuto viene, in un certo senso, attribuita preminenza alla volontà del detentore del rifiuto circa la sua destinazione, mentre la «nozione oggettiva» si fonda su una valutazione obiettiva della condotta del detentore o di un obbligo cui lo stesso comunque è tenuto.
In pratica secondo la prima teoria è rifiuto ciò che non è più di nessuna utilità per il detentore in base alla sua personale scelta mentre, per la seconda, l’individuazione di una sostanza come rifiuto prescinde dalla volontà del singolo, rcavandosi da dati obiettivi. La nozione oggettiva di rifiuto, in linea peraltro con la giurisprudenza comunitaria e nazionale, propende quindi per un concetto ampio di rifiuto, fondato su risultanze oggettive e non sull’intenzione del detentore (Cass. Sez. III n. 31011 del 18 giugno 2002, Zatti).
A differenza della legislazione previgente (Decreto Ronchi), il nuovo testo Unico Ambientale in sostanza esclude dal concetto di "rifiuto" le materie prime secondarie e i sottoprodotti valorizzabili come combustibili[1] [1].
Un'ultima precisazione assume rilevanza ai fini della nostra disamina, ed attiene all'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti rispetto a quella che abbiamo sopra analizzato sull'inquinamento idrico. Nella vigenza del Decreto Ronchi e della Legge Merli, la Suprema Corte aveva chiarito che "in tema di smaltimento di rifiuti la definizione di rifiuto come qualunque sostanza che rientri nelle categorie comprese nel catalogo dei rifiuti, e della quale il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi, comprende anche i rifiuti allo stato liquido. Pertanto l'abbandono incontrollato sul suolo o l'immissione nelle acque superficiali o sotterranee di rifiuti allo stato liquido compresi nel catalogo dei rifiuti e' punito ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, mentre lo scarico di acque reflue non comprese in questo catalogo continua ad essere soggetto alla disciplina della legge 10 maggio 1976 n. 319". Sulla base del medesimo criterio si dovranno ritenere ora applicabili, in casi analoghi, le norme del testo Unico dell'Ambiente rispettivamente in materia di inquinamento idrico (sopra analizzate), ovvero in tema di rifiuti.
(2).png)
[1] [1] Non sono rifiuti i sottoprodotti e le materie prime seconde (MPS), così definiti:
- Non rientrano tra i rifiuti ma tra i «sottoprodotti» le sostanza od oggetti che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
- la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
- Materia prima secondaria: materia, sostanza o prodotto secondario avente le caratteristiche stabilite da un apposito decreto del Ministero dell’Ambiente e che rispetti i seguenti criteri, requisiti e condizioni, previsti dall’art. 181 bis:
- siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti;
- siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre;
- siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse;
- siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l'immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l'utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all'ambiente e alla salute derivanti dall'utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario;
- abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato.
In attesa dell’emanazione del decreto del Ministero dell’Ambiente le caratteristiche dei materiali devono essere conformi alle autorizzazioni vigenti rilasciate ai sensi degli artt. 208, 209 e 210 del D.Lgs.152/06 in accordo con il D.M. 05/02/98 così come modificato dal D.M. 186/06, il D.M. 161/02 e il D.M. 269/05.
Classificazione dei rifiuti
Il Decreto legislativo 152/06 determina, nell’art. 184, come modificato dall’art. 11 del D.Lgs. 205/2010, una classificazione dei rifiuti che, sostanzialmente, ricalca quella già contemplata dal “decreto Ronchi”. Una prima fondamentale distinzione è effettuata, in in base alla «origine», tra "rifiuti urbani" e "rifiuti speciali" che possono, a loro volta distinguersi, in base alle «caratteristiche di pericolosità», in "rifiuti pericolosi" e "non pericolosi".
Da ciò consegue che tanto i rifiuti urbani (ad eccezione dei rifiuti domestici che pure ne fanno parte) quanto i rifiuti speciali possono essere qualificati pericolosi e non pericolosi.
- Sono dunque rifiuti urbani:
- i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera precedente, assimilati[1] [1] ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
- i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni,nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai numeri 2), 3) e 5).
La gestione integrata dei rifiuti urbani è di competenza dei Comuni che partecipano obbligatoriamente alle Autorità d’Ambito Territoriali Ottimali. Gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) sono suddivisioni del territorio regionale individuate al fine di superare l’originaria frammentazione in Autorità di Bacino per la gestione dei rifiuti, e di ottimizzare il servizio in termini di raccolta, trasporto e destinazione finale dei rifiuti.
- Per rifiuti speciali si intendono quei rifiuti provenienti dalla produzione primaria di beni e servizi, dalle attività dei comparti quali il commercio, nonché quelli derivanti dai processi di disinquinamento come fanghi, percolati, materiali di bonifica ecc.
Rientrano, invece, tra i rifiuti speciali, le seguenti categorie:
- i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 Codice civile;
- i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall’articolo 186 in materia di terre e rocce da scavo;
- i rifiuti da lavorazioni industriali;
- i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- i rifiuti da attività commerciali;
- i rifiuti da attività di servizio;
- i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- i rifiuti da attività sanitarie;
Negli ultimi anni, i rifiuti speciali hanno assunto una rilevanza sempre maggiore in relazione al miglioramento delle condizioni economiche, al progredire dello sviluppo industriale, della produzione di beni, merci, processi di consumo, e alle politiche di miglioramento degli standard ambientali. È ormai consolidata la consapevolezza che una corretta gestione dei rifiuti può consentire oltre alla tutela delle condizioni ambientali e della salute, anche il recupero di materie prime secondarie e di energia.
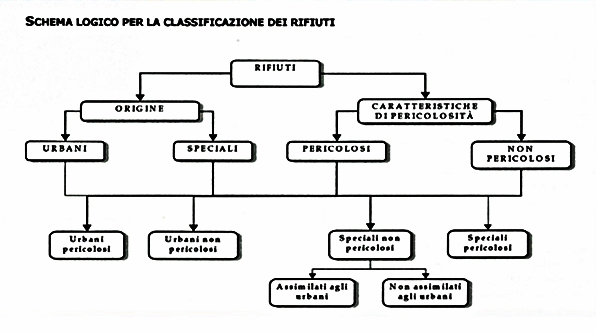
- I Rifiuti pericolosi e non pericolosi
I Rifiuti pericolosi sono, nfine, individuato come tali da penultimo comma dell’art. 184 D.lgs. 152/06 che specifica: “Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco nell’elenco di cui all’Allegato D alla parte quarta del citato decreto, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta” in applicazione del “nuovo CER” (catalogo europeo dei rifiuti). In tale elenco alcune tipologie di rifiuti sono classificate come pericolose o non pericolose fin dall’origine, mentre per altre la pericolosità dipende dalla concentrazione di sostanze pericolose e/o metalli pesanti presenti nel rifiuto. [2] [1]
Per "sostanza pericolosa" si intende qualsiasi sostanza classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche: questa classificazione è soggetta ad aggiornamenti, in quanto la ricerca e le conoscenze in questo campo sono in continua evoluzione.
I rifiuti si distinguono, in base alle caratteristiche di pericolosità, in «rifiuti non pericolosi» e «rifiuti pericolosi». Sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE, se presentano una o più delle seguenti caratteristiche di pericolosità:
- H1 "Esplosivo": sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;
- H2 "Comburente": sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;
- H3-A "Facilmente infiammabile": sostanze e preparati: liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21°C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o che a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;
- H3-B "Infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21°C e inferiore o pari a 55°C;
- H4 "Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;
- H5 "Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;
- H6 "Tossico": sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;
- H7 "Cancerogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;
- H8 "Corrosivo": sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;
- H9 "Infettivo": sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;
- H10 "Teratogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;
- H11 "Mutageno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;
- H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;
- H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate;
- H14 "Ecotossico": sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente.
Per definire le caratteristiche di pericolo da H3 a H8, H10 e H11 sono stati stabiliti i "limiti di riferimento" (art. 2 della Decisione 200/532/CE e successive modifiche), ossia dei valori di concentrazione delle sostanze contenute nel rifiuto, superati i quali il rifiuto è classificato come pericoloso, mentre per le caratteristiche H1, H2, H9; H12, H13 e H14 mancano i criteri di riferimento sia a livello comunitario che nazionale.
Alcuni rifiuti sono classificati come pericolosi già dall'origine e contrassegnati da un "asterisco"a fianco del codice CER, riguardo all’attività che li ha prodotti; per altre tipologie si fa riferimento alla concentrazione di sostanze pericolose da determinarsi mediante opportuna verifica analitica.
[1] [1]L’assimilazione viene disposta con regolamento comunale ai sensi dell’art. 198 comma 2, lettera g) secondo la determinazione (di competenza statale) dei criteri qualitativi e quali-quantitativi, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali assimilati. Non possono essere, di norma, asimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei ba e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.
[2] [1]I "metalli pesanti" sono antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno: possono essere presenti sia puri che, combinati con altri alementi, in composti chimici.
Abbandono dei rifiuti: sanzioni
I produttori e i detentori dei rifiuti, ai sensi dell’art. 188 del D.lgs. 152/06, sono obbligati a consegnare i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettui le operazioni di recupero o smaltimento. Inoltre, nel medesimo articolo è definita la responsabilità del detentore dei rifiuti sul corretto recupero o smaltimento. Questa termina nel momento in cui il detentore dei rifiuti li consegna al servizio pubblico di raccolta o, nel caso di conferimento a soggetti autorizzati, riceve la quarta copia del formulario di identificazione del rifiuto controfirmato e datato dal destinatario del rifiuto stesso entro il termine di tre mesi dal data di consegna al trasportatore.
- L'art. 255 del testo Unico, intitolato "Abbandono dei rifiuti", apre il capo relativo alle sanzioni previste dal Testo Unico in materia di rifiuti. Innanzitutto è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 105 euro a 620 euro per chiunque "abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee". Tuttavia se l'abbandono ha per oggetto rifiuti non pericolosi e non ingombranti la sanzione pecuniaria è minore e compresa da 25 euro a 145 euro. Se, invece, la violazione viene posta in essere dal titolare del centro di raccolta o dal concessionario o dal titolare della succursale della casa costruttrice, la sanzione va da 260 euro a 1.150 euro.
- Il terzo comma del predetto articolo stabilisce che chi non osserva l'ordinanza del Sindaco tesa a rimuovere, a recuperare o a smaltire i rifiuti e a ripristinare lo stato dei luoghi, oppure non adempie all'obbligo di separare i rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile, è punito con la sanzione penale dell'arresto fino ad un anno.
Il potere da parte del Sindaco di ricorrere ad ordinanze contingibili ed urgenti può essere legittimamente esercitato soltanto quando si versa in una situazione di eccezionale ed urgente necessità, e ciò giustifica il ricorso ad una sanzione penale, e non solo amministrativa, in caso di inottemperanza all'ordinanza sindacale.
Infine il predetto articolo stabilisce che in caso di sentenza di condanna, anche se emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nelle sopraccitata ordinanza sindacale o nell'obbligo non eseguiti. Questa disposizione è chiaramente finalizzata a garantire che la sentenza di condanna raggiunga l'obiettivo di assicurare l'effettivo recupero dell'ambiente inquinato e l'eliminazione del danno provocato dal reato.
- Gli articoli 262 (competenza e giurisdizione) e 263 (proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie) del Testo Unico costituiscono due norme di chiusura del capo relativo alle sanzioni in materia di rifiuti. L'art. 262 prevede che all'irrogazione delle predette sanzioni amministrative pecuniarie provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, e che avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'art. 12 della L. 689/1981. L'art. 263 prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti alle province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale.
Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata: sanzioni
L'art. 256 del Testo Unico sull'Ambiente, punisce l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata. In base al predetto articolo "chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione,iscrizione o comunicazione" è punito: con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
- Le definizioni di tutte le predette attività sono contenute nell'art. 183 del Testo Unico, in forza del quale:
- la raccolta è l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto (lett. e);
- la raccolta differenziata è la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, nonchè a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti siano effettivamente destinati al recupero (lett. f);
- lo smaltimento consiste nelle operazioni finalizzate a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta (lett.g);
- il recupero riguarda le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici (lett. h);
- lo stoccaggio consiste nelle attivita' di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla parte quarta (lett.l).
L'autorizzazione é necessaria sia per le operazioni di smaltimento sia per quelle di recupero, e non hanno alcun valore le autorizzazioni successive in sanatoria, le quali non hanno il potere di disciplinare i fatti ad esse antecedenti.
In particolare, l'art. 208 del testo Unico stabilisce che: "i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda é altresi allegata la comunicazione del progetto all'autorita' competente ai predetti fini".
Entro trenta giorni dal ricevimento della predetta domanda, la Regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle Autorità d'ambito e degli enti locali interessati. Alla conferenza è invitato a partecipare, con preavviso di almeno venti giorni, anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti.
Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi:
- procede alla valutazione dei progetti;
- acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;
- acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;
- trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione.
Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza di servizi e sulla base delle risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva, approva il progetto e autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità dei lavori.
L'autorizzazione detta le opportune condizioni e prescrizioni, chiarendo:
- i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
- i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformita' dell'impianto al progetto approvato;
- le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
- la localizzazione dell'impianto da autorizzare;
- il metodo di trattamento e di recupero;
- le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
- le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto;
- la data di scadenza dell'autorizzazione;
- i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.
La predetta autorizzazione è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.
Quando, a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all'autorizzazione, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione, quest'ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell'atto di diffida, l'autorizzazione è revocata.
Il predetto art. 208 del testo Unico stabilisce, inoltre, che l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge n. 84/1994 e di cui al D. lgs. 182/2003 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco è disciplinata dai regolamenti comunitari che regolano la materia, dagli accordi bilaterali di cui all'articolo 19 del regolamento CEE n. 259/93 (vedi la regolamentazione dei rifiuti nelle aree portuali).
Le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi non necessitano della predetta autorizzazione, ma, in base ad una procedura semplificata prevista dall'art. 215, possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla competente Sezione regionale dell'Albo nazionale dei gestori ambientali istituito dal precedente art. 212. Anche in tale caso, tuttavia, qualora la Sezione regionale del predetto Albo accerti il mancato rispetto delle norme tecniche da parte del gestore dell'impianto di smaltimento, essa propone alla Provincia di disporre, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare la propria attivita' alla normativa vigente.
Una particolare ipotesi di violazione del divieto di autorizzazione è contenuta nel terzo comma dell'art. 256, che sanziona la realizzazione e gestione di discarica abusiva: "Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se la discarica è destinata,anche in parte,allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi dell'art.444 del c.p.p. consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi".
Secondo la Corte di Cassazione, ci si trova di fronte alla realizzazione di discarica abusiva tutte le volte in cui, per effetto di una condotta ripetuta, i rifiuti vengono scaricati in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo di rifiuti (Cass. Sez. III, sent. n. 4260 del 15 aprile 1991).
- Gli articoli 262 (competenza e giurisdizione) e 263 (proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie) del Testo Unico costituiscono due norme di chiusura del capo relativo alle sanzioni in materia di rifiuti. L'art. 262 prevede che all'irrogazione delle predette sanzioni amministrative pecuniarie provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, e che avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'art. 12 della L. 689/1981. L'art. 263 prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti alle province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale.
Bonifica dei siti: sanzioni
L'art. 257 del Testo Unico, come modificato dal d.lgs. 8 novembre 1997 n. 389, stabilisce che: "Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente".
Difatti, a norma dell'art. 242 del Testo Unico, al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento deve mettere in opera immediatamente, e comunque non oltre ventiquattro ore, le misure necessarie di prevenzione e deve svolgere, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento. All'esito di tale indagine, ove il responsabile dell'inquinamento accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, deve provvedere al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione.
Qualora, invece, la predetta indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC, il responsabile dell'inquinamento deve darne immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate, e nei successivi trenta giorni deve presentare alle predette amministrazioni, nonchè alla regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione. Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative, e sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. Qualora invece gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito e' superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile deve sottoporre alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti con attività in esercizio, la regione, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione della attività.
Il secondo comma dell'art. 257 del Testo Unico prevede che "si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose".
Il terzo comma prevede che con la sentenza di condanna per le predette contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. "il beneficio della sospensione condizionale della pena puo' essere subordinato alla esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale". Tale previsione conferma che la ratio della norma non è tanto quella di garantire il puntuale adempimento della procedura di bonifica, ma soprattutto quella di difendere e salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento.
- Gli articoli 262 (competenza e giurisdizione) e 263 (proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie) del Testo Unico costituiscono due norme di chiusura del capo relativo alle sanzioni in materia di rifiuti. L'art. 262 prevede che all'irrogazione delle predette sanzioni amministrative pecuniarie provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, e che avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'art. 12 della L. 689/1981. L'art. 263 prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti alle province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale.
SISTRI: sistema di tracciabilità dei rifiuti
Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nato nel 2009 su iniziativa del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è un sistema informatico gestito dal Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente finalizzato a semplificare le procedure e gli adempimenti amministrativi per la gestione dei rifiuti e a combattere il traffico illecito e lo smaltimento illegale. Il Sistema permette l’informatizzazione dell’intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani e modifica completamente il modello di identificazione, registrazione e denuncia dei rifiuti, prevedendo l’iscrizione obbligatoria di specifiche categorie di soggetti individuati dal Decreto ministeriale del 17 dicembre 2009.
Il 14 gennaio 2010 è entrato in vigore il nuovo Sistema Informatico di Tracciabilità dei Rifiuti, previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17/12/2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13/01/2010. La gestione informatica della documentazione sostituisce la tenuta dei registri di carico e scarico (area Registro Cronologico della scheda Sistri), l'emissione dei formulari (area Movimentazione del Rifiuto della scheda Sistri) e prevede, a partire dal 2011, l'abolizione del MUD.
Il tracciamento informatico del percorso dei rifiuti permette un maggior controllo della movimentazione degli stessi. L'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale si realizza tramite l'uso di dispositivi USB personalizzati per ogni sede che produce o gestisce rifiuti e per ogni veicolo a motore che li trasporta. Il dispositivo USB è una chiavetta con firma elettronica che permette l'accesso in sicurezza al sistema informatico Sistri per la trasmissione dei dati e delle informazioni memorizzandole sul dispositivo stesso. Ciascun dispositivo USB può contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici che corrispondono alle firme elettroniche delle persone fisiche individuate come "delegati" durante la procedura di iscrizione al Sistri. Per ogni veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti oltre alla dotazione di un dispositivo USB è prevista l'installazione di una black box (scatola nera) con la funzione di seguire e verificare il percorso dei rifiuti speciali in tempo reale dal momento in cui sono caricati sul veicolo fino alla destinazione finale.
Il decreto che istituisce e disciplina il SISTRI individua i soggetti (detti operatori) e le attività di produzione, gestione e trasporto di rifiuti (categorie di iscrizione) coinvolte nel processo di informatizzazione e ne definisce le modalità di iscrizione, obbligatoria o facoltativa, secondo determinate tempistiche. In particolare, i seguenti soggetti sono obbligati ad effettuare la registrazione:
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152/2006, con più di dieci dipendenti. lettera c) i rifiuti da lavorazioni industriali; lettera d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; lettera g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti della acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento.
- i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania.
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.
- i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati.
- le imprese di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali.
- il terminalista concessionario dell’area portuale di cui all’articolo 18 della legge n. 84/1994 e l’impresa portuale di cui all’articolo 16 della medesima legge, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco per il successivo trasporto;
- i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.
La disciplina della Gestione dei Rifiuti
E’ la parte quarta del Decreto legislativo 152/2006 (artt. 177-266) a dettare norme in materia di gestione dei rifiuti che, ai sensi dell’art. 178, costituisce attività di pubblico interesse tesa ad assicurare una elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci.
La gestione di un rifiuto può essere considerata come l’insieme delle attività che accompagnano e seguono l’atto del disfarsi di una sostanza o oggetto, partendo dalla fase di produzione del rifiuto e, ancor prima dalla prevenzione di tale produzione, fino alla raccolta, il trasporto, il trattamento (riciclaggio o smaltimento) ed anche il riutilizzo dei materiali di scarto solitamente prodotti dall'attività umana, nel tentativo di ridurre i loro effetti sulla salute dell’uomo e sull’ambiente. Un interesse particolare negli ultimi decenni riguarda la riduzione degli effetti dei rifiuti sulla natura e sull'ambiente e la possibilità di recuperare risorse da essi, e la riduzione della produzione di rifiuti stessi.
La gestione dei rifiuti è effettuata in conformità ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, diresponsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi «inquina paga». A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.
- L’intero ciclo della gestione dei rifiuti nelle sue varie fasi deve osservare i seguenti principi generali (art. 179):
- evitare ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitare ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo nonché evitare ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- salvaguardare la fauna e la flora ed evitare il pur minimo degrado all’ambiente e al paesaggio;
- rispettare le esigenze di qualità della vita e di pianificazione economica e territoriale;
- promuovere ed attuare, con criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia;
- garantire un adeguato servizio di smaltimento dei rifiuti per l’intero territorio comunale.
Articolo 179
(Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti
.png)
I Comuni promuovono tutte quelle iniziative tendenti a diminuire la produzione dei rifiuti sia coinvolgendo la popolazione interessata che attraverso adeguati interventi di raccolta differenziata e di recupero dei materiali. I Gestori del servizio hanno l’obbligo di seguire razionalmente l’innovazione tecnologica in materia ambientale e conseguentemente di aggiornare, sotto il profilo tecnico-scientifico il proprio personale, i propri mezzi e le proprie dotazioni, promuovendo la sperimentazione di tutte le forme organizzative che consentano il continuo miglioramento del servizi.
Rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico
La tutela dell’ambiente marino si sostanza, principalmente, nella lotta al fenomeno dell'inquinamento del mare, dovuto ad una molteplicità di cause, tra cui gli scarichi di oli combustibili provenienti dalle raffinerie o dai lavaggi delle petroliere e le perdite accidentali di idrocarburi che complessivamente incidono, sull'ecosistema marino, in misura inferiore rispetto ai quotidiani sversamenti volontari dei predetti lavaggi di cisterne, o degli scarichi delle acque nere o di sentina. A tali fattori occorre aggiungere l'incidenza degli scarichi di rifiuti civili, agricoli ed industriali.
L'analisi della disciplina posta a tutela dell'ambiente marino non può non riguardare anche la normativa in materia di rifiuti, che chiaramente attiene anche alla tutela ed all'igiene dei litorali e dei porti. Le attività portuali, oltre a risultare dinamicamente collegate ad aspetti di natura economica, sociale, storica e culturale, comportano inevitabili relazioni con l’ambiente, sia costiero che marino. Una gestione incontrollata di tali attività, soprattutto se inserite in aree fortemente antropizzate, potrebbe provocare pericolose ripercussioni sull’ambiente naturale, un continuo aumento del consumo di risorse e dei costi per gestire l’ambiente, una maggiore produzione di rifiuti e una conseguente perdita del valore del porto. Ciò risulta tanto più vero per i porti inseriti in aree di particolare interesse naturalistico o in contesti di particolare vulnerabilità come quello del bacino del mediterraneo.
Il Corpo delle Capitanerie – Guardia Costiera colloca la materia ambientale al centro dell’ordinario spiegarsi dei compiti istituzionali. Tali delicate attribuzioni, risultano ulteriormente consolidatesi, alla luce del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”[1] [1], ed in particolare, dagli articoli 135 e 195, che individuano competenze di natura specialistica del Corpo, nella gestione, rispettivamente, dell’attività di prevenzione ed accertamento dei reati ed illeciti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e nella repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti. La vigilanza sulle aree di reperimento e monitoraggio della filiera dei rifiuti in ambito terrestre, marino e portuale era costituita, in passato dal D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (c.d. decreto Ronchi), il quale aveva recepito tre direttive della CEE (la 91/156 sui rifiuti; la 91/689 sui rifiuti pericolosi e la 94/62 sugli imballaggi), ed aveva abrogato quasi tutta la normativa precedente, rappresentando una svolta fondamentale nella regolamentazione dei rifiuti. Tale decreto, infatti, si ispirava all'idea che l'inquinamento da rifiuti doveva essere fronteggiato non con interventi da collocarsi a valle dei processi di consumo, attraverso il ricorso allo smaltimento in discarica, ma riducendo la quantità' complessiva dei rifiuti prodotti, e favorendo tecnologie di gestione degli stessi orientate al recupero, al riutilizzo e al riciclo. Il testo legislativo ha mostrato delle molteplici carenze normative, che avevano portato all'emanazione nel ’97 del D. Lgs. n. 389 (cd. Rochi - bis) e nel ’98 della Legge n. 426 (cd. Ronchi - ter), finché è intervenuto il sopra citato Testo Unico dell'Ambiente a riordinare integralmente anche tale materia (la Parte IV tratta la gestine dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati). La nuova legge, in conformità con quanto stabilito dalla normativa comunitaria, accorpa infatti tutte le disposizioni emanate successivamente al decreto Ronchi, e riorganizza la disciplina dei consorzi di raccolta attraverso l'introduzione di istituti finalizzati ad assicurare la massima concorrenzialità nella gestione del sistema e consentire di costituire nuovi consorzi.La finalità del decreto sono indicate nell’art. 2 comma 1 nella promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzarsi attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionaòe delle risorse naturali.
L’art. 232 comma 2 del Testo Unico ambientale (D.L.vo 152/2006) richiama, quale disciplina di carattere nazionale relativa ai rifiuti prodotti dalle navi ed ai residui del carico, il D.L.vo 24 giugno 2003 n. 182 (in Gazz. Uff., 22 luglio, n. 168) “Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico”. il quale ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva CE 59/2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico, finalizzata ad assicurare alle navi che approdano nei diversi porti dell'Unione Europea adeguati sistemi ove poter conferire non solo i rifiuti inevitabilmente prodotti a bordo della nave, ma anche i residui del carico che altrimenti verrebbero eliminati attraverso sversamenti volontari nelle acque marine. E’ composto di 16 articoli e 4 allegati, che definiscono in modo puntuale l’ambito di applicazione e le modalità operative di gestione dei rifiuti navali e dei porti:
- Allegato 1: Prescrizioni relative al piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;
- Allegato 2: Informazioni sul sistema di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico da fornire agli utenti del porto;
- Allegato 3: Modulo di dichiarazione contenente le informazioni da notificare prima dell'entrata nel porto;
- Allegato 4: Criteri per la determinazione della tariffa di cui agli articoli 8 e 10.
Scopo del decreto legislativo è dunque quello di “ridurre gli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonché di migliorare la disponibilità e l’utilizzo degli «impianti portuali di raccolta» per i suddetti rifiuti e residui” (art. 1).Una nave, infatti, durante il suo esercizio impatta in maniera significativa sull’ambiente: basti pensare alle operazioni di routine come quella di smaltimento dei rifiuti prodotti a bordo. Lo stesso dicasi per le attività condotte nei porti, che generano rifiuti anche di natura pericolosa. Tali impianti vengono definiti dall'art. 2, comma 1, lett. e) come strutture, che possono essere fisse, galleggianti o mobili all'interno del porto dove, prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico.
Esso si applica (art. 2) a tutte le navi, comprese le unità da diporto ed i pescherecci facenti scalo o operanti in un porto dello Stato, indipendentemente dalla bandiera. Si applica inoltre ai porti dello Stato ove fanno scalo dette navi. Sono invece escluse le navi militari da guerra ed ausiliarie o altre navi possedute o gestite dallo Stato, se impiegate solo per servizi statali ai fini non commerciali, ma è previsto che, con decreto ministeriale, siano stabilite le misure necessarie ad assicurare che le navi militari da guerra ed ausiliarie e le navi delle forze di polizia ad ordinamento civile conferiscano rifiuti ed i residui del carico in conformità alla normativa vigente in materia, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per dette navi e delle caratteristiche di ogni unità. Ed infatti, con D.M. 19 marzo 2008, recante “Misure necessarie per il conferimento da parte delle navi militari da guerra e ausiliarie dei rifiuti e dei residui del carico negli appositi impianti portuali, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 2 del decreto legislativo 24 giuno 2003, n. 182”, sono state stabilite le misure necessarie per il conferimento, da parte delle navi militari da guerra e ausiliarie dei rifiuti e dei residui del carico negli appositi impianti portuali.
Occorre sottolineare che già dalle predette previsioni relative agli obiettivi della norma, ed alla definizione degli impianti di raccolta, emerge chiaramente come il decreto legislativo 182/2003 si occupi della gestioni dei rifiuti del sistema "nave-porto", e non del servizio di pulizia, raccolta rifiuti e disinquinamento del porto. Per ciò che attiene a tale servizio, viene in evidenza, oltre alla disciplina generale sui rifiuti sopra esaminata, il decreto del Ministero dei Trasporti del 14/11/1994, il quale ha individuato vari servizi portuali di interesse generale (servizi di illuminazione, idrici, informatici, telematici), tra cui, per l'appunto, i servizi di pulizia, raccolta dei rifiuti e disinquinamento del porto. In base a tale provvedimento la pulizia di tutti gli spazi terrestri non coperti situati entro l'ambito portuale, compresi quelli utilizzati da soggetti terzi, imprese o utenti portuali viene affidata ad imprese competenti a seguito di gara pubblica indetta dall'Autorità Portuale o, dove non istituita, dall'Autorità Marittima. Il predetto decreto ministeriale in precedenza regolava anche l'attività di pulizia e raccolta di rifiuti provenienti dalle navi in sosta nel porto, che ora invece ha trovato una disciplina ad hoc con il D.Lgs 182/03.
Pertanto, per i rifiuti della nave ed i residui del carico, si applica il Decreto 182/03, e le relative norme concernenti il conferimento, l'obbligo di notifica ed il regime tariffario, mentre per i rifiuti derivanti dalla pulizia degli specchi acquei e terrestri la principale fonte giuridica di riferimento è il nuovo Testo Unico sull'Ambiente, per la parte relativa alla disciplina dei rifiuti (prima regolata dal D.Lgs 22/97), oltre alla L. 84/94 (riordino della legislazione in materia portuale) ed al predetto D.M. 14/11/94.
Particolare importanza riveste, inoltre, la Marpol 73/78, ossia la Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento dalle navi. Tale convenzione fu elaborata per rispondere alla necessità di controllare e limitare il rilascio accidentale e deliberato in mare di idrocarburi ed altre sostanze pericolose, fra cui i rifiuti (ad essi è dedicato l’Annesso V).
[1] [1] Tale Decreto, emanato in attuazione della Legge 308/2004 “delega ambientale” che a sua volta è stato oggetto di interventi correttivi, l’ultimo dei quali effettuato con il D. Lgs. 29/06/2010, n. 128. e recante “norme in materia ambientale”, dedica la parte IV alle “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” (articoli 177 – 266) ed ha abrogato una serie di provvedimenti precedenti tra cui il Decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, cosiddetto Decreto Ronchi, che fino alla data di entrata in vigore del D.lgs. 152/06 ha rappresentato la legge quadro di riferimento in materia di rifiuti. La gerarchia di gestione dei rifiuti è disciplinata dall’art. 179 del D.Lgs. 152/06 “Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti” che stabilisce quali misure prioritarie la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti seguite da misure dirette quali il recupero dei rifiuti mediante riciclo, il reimpiego, il riutilizzo o ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie, nonché all’uso di rifiuti come fonte di energia.
Il Decreto quindi persegue la linea già definita dal Decreto “Ronchi”, ovvero la priorità della prevenzione e della riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, a cui seguono solo successivamente il recupero (di materia e di energia) e quindi, come fase residuale dell’intera gestione, lo smaltimento (messa in discarica ed incenerimento).
Classificazione dei rifiuti portuali
I rifiuti portuali sono classificati in:
- Rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico che la Convenzione MARPOL 73/78 raggruppa nei seguenti cinque Allegati:
- petrolio in tutte le sue forme (Allegato I) ed in particolare il petrolio greggio, l’olio combustibile, le morchie, i residui d’idrocarburi e i prodotti raffinati (diversi dai prodotti petrolchimici che sono soggetti alle disposizioni dell’Allegato II della Marpol) e comprende le sostanze elencate nell’Appendice I della Marpol. Fanno parte dell’Allegato I: i rifiuti oleosi (scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati; scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati; scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione; olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile; altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione; oli di sentina della navigazione; altri oli di sentina della navigazione; oli prodotti dalla separazione olio acqua), i fanghi (fanghi di prodotti di separazione olio/acqua), le acque di lavaggio cisterne e residui di carico, i residui oleosi di macchina (acque di sentina, morchie, ecc.).
- sostanze liquide nocive trasportate da navi chimichiere comprendenti i residui provenienti dal lavaggio delle cisterne (Allegato II). Le sostanze liquide vengono suddivise nelle seguenti categorie: Categoria A, Categoria B, Categoria C e Categoria D (Allegato II, norma 3) e sono classificate secondo quanto indicato nell’Appendice I del medesimo Allegato.
- imballaggi, contenitori, contenitori-cisterna, vagoni-cisterna stradali e ferroviari che sono già stati usati per il trasporto di sostanze nocive trasportate non alla rinfusa che potrebbero originare residui di carico (Allegato III).
- acque nere (Allegato IV).
- rifiuti normalmente prodotti dall’esigenza di vita dell’equipaggio di bordo (Allegato V) quali:
- plastica;
- materiale di imballaggio, tessuti;
- prodotti cartacei, stracci, metalli, bottiglie, terracotta;
- rifiuti alimentari;
- cenere proveniente da inceneritore.
- Rifiuti genericamente prodotti nell’area portuale, quali:
- rifiuti indifferenziati;
- i rifiuti oggetto di raccolta differenziata.
- Rifiuti derivanti dalla pulizia delle aree comuni e degli specchi acquei portuali.
Nell’Allegato 1 è riportato un elenco esemplificativo e non esaustivo, dei principali codici CER relativi alle tre macro-categorie di rifiuti portuali sopra elencate.
(2).png)
Allegato 1
Elenco dei possibili rifiuti prodotti dalle navi
(Elenco non esaustivo)
.png)
Allegato 1bis
Elenco dei possibili rifiuti prodotti dalle navi
(Elenco non esaustivo)
(1).png)
Allegato 1 ter
Elenco dei possibili rifiuti genericamente prodotti nell’area portuale
(Elenco non esaustivo)
(4).png)
Allegato 1 quater
Elenco dei possibili rifiuti derivanti dalla pulizia delle aree comunie degli specchi acquei portuali
(Elenco non esaustivo)
.png)
I piani di raccolta e di gestione dei rifiuti
Per «gestione dei rifiuti» si intende l'insieme delle politiche volte a gestire l'intero processo dei rifiuti, dalla loro produzione fino alla loro sorte finale. Per ciascun porto è elaborato un «piano di raccolta e di gestione dei rifiuti». Il piano è valutato e approvato dallo Stato membro interessato. Si procede ad una nuova approvazione almeno ogni tre anni.
Il Piano di gestione sostenibile dei rifiuti portuali ha come obiettivo principale quello di fornire una dettagliata descrizione del servizio relativo dell’intero «ciclo di gestione» rifiuti, e coinvolge quindi la raccolta, la differenziazione, il trasporto, il trattamento (reiciclaggio o smaltimento) e anche il riutilizzo dei materiali di scarto, nel tentativo di evitare che vi siano dispersioni in mare di detti rifiuti, prevenendo così l’inquinamento dell’ambiente marino.Nel Piano è inoltre riportata una breve descrizione o un semplice elenco della normativa presa in riferimento per l’elaborazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le norme internazionali, europee ed italiane, sono:
• Direttiva 91/156/CEE;
• Direttiva 91/689/CEE;
• Direttiva 94/62/CE;
• Direttiva 2000/59/CE;
• D.Lgs. n. 152/2006;
• D.Lgs. n. 182/2003.
Numerosi Protocolli, Convenzioni e Accordi sono stati siglati fra Stati per tutelare i mari e, nello specifico della «gestione dei rifiuti» prodotti dalle navi, è stata adottata in particolare la Direttiva 2000/59/CE che regolamenta anche i residui di carico delle stesse e si propone di perseguire due obiettivi: la semplificazione e la migliore efficacia della Convenzione MARPOL 73/78, ponendosi anche come collegamento fra la stessa e la normativa di riferimento in materia di rifiuti rappresentata dalla Direttiva 95/21/CE[1] [1].
La Direttiva 2000/59/CE, in aggiunta alle prescrizioni previste a livello internazionale, prevede delle disposizioni più restrittive (anche se il suo ambito territoriale di applicazione è limitato alle navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri a prescindere dalla loro bandiera) ed inoltre definisce, in termini univoci, che, a prescindere dalla definizione data a livello internazionale, anche i residui del carico (e le acque reflue) sono da considerarsi rifiuti ed essi, pertanto, ricadono nell’ambito di competenza della normativa in materia (per esempio per ciò che riguarda le regole sulla loro circolazione, i procedimenti autorizzatori, ecc.). In realtà anche la Convenzione MARPOL 73/78 prevede la realizzazione, “al più presto”, di impianti di raccolta per residui di idrocarburi e per ricevere e trattare la zavorra inquinata e le acque di pulitura delle cisterne delle petroliere, acque di scarico e i rifiuti (definiti nell’Allegato V), ma solo nella Direttiva 2000/59/CE si prevedono misure specifiche da realizzare a scadenze predeterminate.
Un’altra peculiarità della Direttiva è che, rispetto ai tempi lunghi rimessi al potere discrezionale delle parti sottoscriventi la Convenzione, adotta disposizioni più stringenti che incidono non solo, come si è detto, sulla circolazione, trattamento e recupero dei rifiuti prodotti da navi, ma soprattutto su:
- l’organizzazione e sulla tipologia degli impianti portuali di raccolta, attraverso appositi piani;
- il procedimento di notifica preventiva, posta a carico del comandante della nave per il conferimento dei rifiuti agli impianti portuali;
- il regime dei controlli;
- le “misure di accompagnamento”, con elencazioni dettagliate degli obblighi strumentali, intestati alle autorità competenti;
- la previsione di un sistema sanzionatorio, da definire secondo i principi generali comunitari.
Con questa Direttiva si è creato un sistema di prescrizioni che mira a raggiungere un elevato grado di tutela attraverso regole di incentivazione (giuridiche, tecniche e finanziarie) sul conferimento agli impianti portuali, riducendo così gli scarichi in mare dei rifiuti e dei residui di carico, provenienti da tutti i tipi di navi, sia che si tratti di scarichi leciti, ma soprattutto illeciti.
E’ importante rilevare che, nonostante il carattere di “linea guida” della Direttiva in oggetto, la stessa prevede già un meccanismo coercitivo che si sostanzia in ispezioni da parte dell’autorità competente nel sito portuale, il cui esito negativo può dar luogo al divieto di lasciare il porto, al quale si possono aggiungere sanzioni economiche specifiche previste dal singolo Stato membro.
In conclusione l’Unione Europea ha adottato un approccio incisivo per la protezione del mare da scarichi di rifiuti e residui provenienti da navi, attraverso un meccanismo di regole, non solo repressive, ma anche incentivanti, che rendono più agevole e più conveniente, per i Comandanti delle navi, conferire rifiuti e residui ai porti piuttosto che scaricare in mare, sia quando rischiano una pena per fatto illecito, sia quando lo scarico sarebbe consentito dalle Convenzioni internazionali e le relative leggi nazionali di ratifica.
In Italia la «gestione dei rifiuti» è regolamentata dal D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, “Norme in materia ambientale” come modificato dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, dove, nella Parte IV, vengono descritti tutti gli obblighi e vincoli previsti per il settore rifiuti. Lo stesso decreto prevede l’abrogazione di numerose norme fra cui il D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997, che per anni ha rappresentato il principale testo di legge del settore.
I rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico sono regolamentati da un apposito decreto legislativo e precisamente dal D.Lgs. n. 182/2003 con il quale è stata recepita la citata Direttiva Comunitaria n° 2000/59/CE. Le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 182/2003 sono state confermate dal D.Lgs. n. 152/2006 nell’art 232.
Il D.Lgs. n. 182/2003 si applica a tutte le navi, compresi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto (a prescindere dalla loro bandiera) che fanno scalo o operano in un porto dello Stato ed ai porti dello Stato ove fanno scalo le suddette navi. Il Decreto Legislativo n. 182 non si applica alle navi militari da guerra ed ausiliarie o di altre navi possedute o gestite dallo Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali.
Rispetto alla Direttiva 2000/59/CE, il decreto legislativo 182/03, amplia il concetto di gestione dei rifiuti, introducendo, a fianco alla previsione di impianti portuali, la fornitura di servizi per la raccolta e gestione dei rifiuti, adeguati alla classificazione del porto e al traffico di navi che scalano il medesimo porto.
In attuazione delle citate disposizioni sopranazionali, con D.Lgs. del 24 giugno 2003 n. 182, sono state emanate norme di dettaglio la cui applicazione è demandata alle Autorità marittime e alle regioni.
La disciplina prevista nel D. Lgs. 182/2003 si applica a tutte le navi di qualsiasi tipo (inclusi aliscafi, aircraft (2 NOTA), sommergibili e galleggianti), compresi i pescherecci e le unità da diporto, a prescindere dalla loro bandiera, ai porti dello Stato ove fanno scalo o operano le predette unità, ad esclusione delle navi militari da guerra ed ausiliarie o di altre navi possedute o gestite dallo Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali" (art. 3). Obiettivo del decreto è quello di ridurre gli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti ndalle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonché di migliorare la disponibilità e l’utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui.
[1] [1] In ambito comunitario la norma di riferimento in materia di rifiuti è rappresentata dalla Direttiva 91/156/CEE , la quale, fra l’altro, prevede che:
- gli Stati membri adottino le misure appropriate per promuovere:
- in primo luogo, la prevenzione o la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti;
- in secondo luogo, il recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo o ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie, o l’uso di rifiuti come fonte di energia;
- gli Stati membri adottino le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente;
- le imprese o gli stabilimenti che provvedono al trattamento, allo stoccaggio o al deposito di rifiuti per conto di terzi debbano ottenere dall’autorità competente un’apposita autorizzazione;
- conformemente al principio “chi inquina paga”, il costo dello smaltimento dei rifiuti sia sostenuto dal detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore o ad un’impresa, dai precedenti detentori o dal produttore del prodotto generatore di rifiuti.
[2] [1] veicoli a cuscino d'aria
Campo di appicazione ed esclusioni
Il Piano di gestione sostenibile dei rifiuti portuali - adeguato ad ogni singola realtà portuale - contiene tutte le “informazioni” [1] [1] richieste dalla Direttiva 2000/59/CE e relative ad un Piano per la raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico, e, in aggiunta, prende in considerazione anche le altre tipologie di rifiuti normalmente raccolti in un porto. L’obiettivo che si intende perseguire con l’elaborazione di un Piano di gestione sostenibile dei rifiuti portuali è di predisporre una gestione unitaria ed integrata di tutti questi rifiuti, in grado di assicurare alti livelli di protezione per la salute e la sicurezza dell’uomo e dell’ambiente.
► Esso si applica ai rifiuti:
- prodotti dalle navi, siano esse soggette a notifica (navi destinate al trasporto di merci o di passeggeri, o unità da diporto omologate per oltre 12 passeggeri) o non soggette a notifica (pescherecci e unità da diporto omologate per un massimo di 12 passeggeri), a prescindere dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano presso il porto (ormeggiate in porto ovvero stazionanti in rada), fra cui:
- rifiuti derivanti dalle attività di bordo, compresi i rifiuti alimentari provenienti da Paesi extra-UE;
- oli esauriti e residui oleosi;
- rifiuti speciali pericolosi e non;
- acque nere.
- genericamente prodotti nell’area portuale
- derivanti dalla pulizia delle aree comuni e degli specchi acquei portuali
Sono esclusi dal campo di applicazione del Piano i rifiuti provenienti da:
- navi militari da guerra ed ausiliarie
- altre navi possedute o gestite dallo Stato, se impiegate solo per servizi statali e fini non commerciali
- attività svolte all’interno delle aree in concessione a soggetti privati
Peraltro, per quanto attiene alle "navi militari" da guerra ed ausiliarie e le navi «in servizio governativo» delle forze di polizia ad ordinamento civile, con decreto ministeriale, D.M. 19 marzo 2008, recante “Misure necessarie per il conferimento da parte delle navi militari da guerra e ausiliarie dei rifiuti e dei residui del carico negli appositi impianti portuali, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 2 del decreto legislativo 24 giuno 2003, n. 182”, sono state stabilite le misure necessarie per il conferimento dei rifiuti e dei residui del carico negli appositi impianti portuali, in conformità alla normativa vigente in materia, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per dette navi e delle caratteristiche di ogni unità.
Quanto alle modalità di gestione degli impianti portuali di raccolta previsti dal D. Lgs. 182/2003, è stabilito che l’Autorità portuale, previa consultazione delle parti interessate e, in particolare, degli enti locali, dell’Ufficio di sanità marittima e degli operatori dello scalo o dei loro rappresentanti, elabori un «piano di raccolta dei rifiuti» prodotti dalle navi e dei residui del carico, il quale va poi approvato dalla regione che provvede ad integrarlo con il piano regionale di gestione rifiuti. Il riferimento è effettuato, dall’articolo, al D.L.vo 22/1997 ma, come già osservato riguardo ad altri richiami alla previgente normativa, stante la sostanziale continuità tra le diverse disposizioni, deve intendersi ora riferito all’articolo 196 del D.L.vo 152/2006.
In attuazione del piano, è prevista, con onere a carico del gestore del servizio, la realizzazione di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico adeguati in relazione alla classificazione dello stesso porto (laddove adottata ovvero in relazione al traffico registrato nell'ultimo triennio), al fine di assicurare il rapido conferimento di detti rifiuti e residui, evitando ingiustificati ritardi e garantendo nel contempo standard di sicurezza per l'ambiente e per la salute dell'uomo raggiungibili con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili (articolo 4).
La capacità degli impianti portuali di raccolta realizzati, siano essi strutture fisse, mobili o galleggianti, è commisurata alla tipologia ed al quantitativo di rifiuti prodotti da navi e di residui del carico provenienti dalle navi che in via ordinaria approdano nel porto, tenuto conto delle esigenze operative degli utenti dello scalo, dell'ubicazione geografica e delle dimensioni del porto, della tipologia delle navi che vi fanno scalo e deve essere conforme a quanto previsto nel piano di raccolta e piano di gestione dei rifiuti disciplinati dall'art. 5 del D. Lgs. 182/03, nonché delle esenzioni di cui all'articolo 7, comma 1. Tali impianti devono inoltre conformarsi alle vigenti disposizioni di sicurezza e di prevenzione incendi (es. D.Lgs. n. 81/2008, “Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”).E’ opportuno rilevare che, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 81/1994, il soggetto pubblico o privato che intenda realizzare un impianto fisso di raccolta deve preventivamente ottenere il rilascio di una «concessione demaniale» da parte dell’Autorità portuale, limitatamente agli scali marittimi ove la stessa sia stata istituita. Tale autorizzazione tuttavia non è da sola sufficiente ai fini dell’espletamento delle attività di raccolta rifiuti: è altresì necessario, infatti, l’ottenimento dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione competente per territorio, la cui validità è di 5 anni (cfr. artt. 208 e ss. D.Lgs. n. 152/2006).
[1] [1] Per definire le tipologie e le quantità dei rifiuti portuali è necessario preliminarmente acquisire le seguenti informazioni:
- per i rifiuti prodotti dalle navi si deve stabilire quali sono le tipologie di navi e di traffici marittimi usuali nel porto.
Le tipologie di navi che normalmente scalano in un porto possono dividersi in:
- navi mercantili, navi passeggeri,
- pescherecci ed imbarcazioni da diporto.
Le prime hanno una produzione di rifiuti varia, comprendente i residui oleosi liquidi o fangosi, i rifiuti assimilabili agli urbani prodotti dall’equipaggio e dall’attività di bordo, e i residui del carico o associati al carico trasportato.
Le navi passeggeri invece hanno una produzione rilevante di rifiuti urbani/assimilabili, mentre pescherecci e imbarcazioni da diporto hanno una produzione limitata di tutte le tipologie di rifiuti.
Per valutare i traffici marittimi devono essere considerati:
- il movimento di navi;
- il movimento di merci.
Questi dati possono essere reperiti presso le locali Autorità Marittime e/o Autorità Portuali.
- Per i rifiuti genericamente prodotti nell’area portuale è necessario definire:
- il perimetro e l’area portuale entro cui deve essere svolto il servizio;
- la presenza e dislocazione di aree in concessione;
- la presenza di stazioni marittime passeggeri;
- la presenza e dislocazione di attività commerciali, produttive e di servizi.
Per i rifiuti derivanti dalla pulizia delle aree comuni e degli specchi acquei portuali dovranno essere chiaramente delimitate:
- le superfici degli specchi acquei da sottoporre al servizio di pulizia;
- il perimetro e l’area portuale entro cui deve essere svolto il servizio di spazzamento.
Queste informazioni preliminari saranno utilizzate per determinare l’origine dei diversi rifiuti portuali e dovranno essere associate ai dati relativi ai loro quantitativi, recuperati tramite la consultazione dei Moduli di notifica per i rifiuti prodotti dalle navi, dei MUD e dei soggetti concessionari del servizio di raccolta per le altre due tipologie di rifiuti.
Obblighi di notifica e di conferimento: valutazione dei dati contenuti nelle notifiche trasmesse all’Autorità Marittima o Portuale
In base a quanto stabilito all’art. 6 del D.Lgs. n. 182/2003, il Comandante di una nave mercantile, senza discriminazine di bandiera, diretta verso un porto italiano deve provvedere a trasmettere, all’Autorità competente nel porto (Autorità portuali o, laddove non istituite, le Autorità marittime), il «modulo di notifica». Sfuggono alla regola le navi militari da guerra ed ausiliarie o altre navi possedute o gestite dallo Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali, i pescherecci, le unità da diporto omologate per un massimo di 12 passeggeri e le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari. Anche i mezzi che svolgono attività di raccolta e di trasporto di rifiuti nell’ambito e per conto del proprio impianto portuale di raccolta e che ne costituiscono parte integrante non sono tenuti a comunicare la predetta notifica.
Nella notifica vanno riportate le quantità e la tipologia di rifiuti e residui trasportati, indicando quanti di questi debbono essere conferiti o trattenuti a bordo, oltre alla percentuale della capacità massima di stoccaggio possibile consentita della nave.
Per compiere un esame dei dati sui rifiuti contenuti nelle notifiche si possono verificare:
- il numero di notifiche rispetto al numero di arrivi attestati nell’apposito registro dell’Autorità competente nel porto per l’arco di tempo esaminato o disponibile;
- le modalità di rilevazione delle notifiche e di informatizzazione delle stesse presso l’Autorità Marittima e/o Portuale;
- il quantitativo dei rifiuti indicati, la percentuale dei campi compilati, non compilati o compilati male sul totale delle notifiche esaminate;
- le congruenze tra le capacità di stoccaggio e le quantità conferite o che verranno conferite nel porto successivo.
In merito alle acque di sentina e ai rifiuti da cucina e mensa, si sottolinea che sembra consuetudine per le navi scaricare questi rifiuti direttamente in mare in conformità con le procedure sancite dalla Convenzione MARPOL 73/78.
Gli obblighi di notifica della situazione relativa ai rifiuti a bordo da smaltire, di cui trattano le disposizioni generali in materia di rifiuti, sono imposti, entro i limiti temporali rigorosi, al Comandante della nave diretta verso un porto situato nel territorio nazionale mediante compilazione di «apposito modulo» da consegnarsi all’Autorità marittima competente.
Il modello dovrà essere trasmesso all’Autorità marittima comtetente almeno 24 ore prima dell'arrivo nel porto di scalo, se detto porto è noto. Qualora il porto di scalo venga conosciuto a meno di 24 ore dall'arrivo, la predetta notificazione va effettuata non appena il porto di scalo è noto. Se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore, tale notificazione va effettuata prima della partenza dal porto di scalo precedente. A notifica avvenuta, l'Autorità marittima trasmette i dati all'Autorità portuale, laddove istituita, al gestore dell'impianto di raccolta, all'ufficio di sanità marittima ed agli uffici veterinari.
Non sono sottoposti al predetto obbligo di notifica i pescherecci e le unità da diporto, omologate per un massimo di 12 passeggeri, dovendosi intendere però tale limite non comprensivo del numero dei componenti l'equipaggio.
Ricevuta la notifica, l'Autorità Marittima trasmette a sua volta i dati all'Autorità portuale, laddove istituita, al gestore dell'impianto di raccolta, agli uffici di Sanità Marittima ed agli Uffici Veterinari di porto. Le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari possono fornire le informazioni di cui sopra cumulativamente all'Autorità Marittima dello scalo di conferimento dei rifiuti.
Valutazione dei dati provenienti dai MUD – Modelli Unici di Dichiarazione ambientale
Il MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) deve essere obbligatoriamente compilato da chiunque effettua a titolo professionale o svolge attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, ovvero svolge operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi ed i consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuti (rif. art. 189, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006).
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006 i produttori di rifiuti non pericolosi (industria, commercio, artigianato e servizi) non hanno più l’obbligo di presentare il MUD (art. 189) e pertanto non sarà più possibile quantificare tali rifiuti con questa modalità; è comunque consigliabile ricercare alcuni dati storici sui rifiuti portuali non pericolosi analizzando i MUD relativi agli anni precedenti il 2005.
I dati derivanti dai MUD, riferiti a periodi di un anno, anche se acquisiti in modo indiretto, permettono di:
- valutare le tipologie e i quantitativi di rifiuti dichiarati dalle aziende concessionarie del servizio di raccolta dei rifiuti portuali;
- compiere una prima caratterizzazione della produzione di rifiuti provenienti da attività commerciali, produttive e di servizi presenti nell’area portuale.
Valutazione dei dati reperiti presso i soggetti concessionari dei servizi di raccolta dei rifiuti portuali
E’ possibile reperire numerose informazioni sui rifiuti portuali anche consultando i differenti soggetti concessionari dei servizi di raccolta. I dati andrebbero distinti considerando:
- la provenienza dei rifiuti;
- le differenti tipologie raccolte, compiendo anche una distinzione fra i rifiuti urbani o ad essi assimilati e/o assimilabili, e i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- i relativi quantitativi;
- le modalità di raccolta.
Nel caso in cui siano disponibili solo dati parziali sarà necessario compiere, in collaborazione con le ditte medesime, una stima dei quantitativi di rifiuti portuali mediamente raccolti basandosi sul numero di conferimenti effettuati presso gli impianti portuali, sul numero e dislocazione dei cassonetti presenti nell’area, sulla frequenza media di svuotamento annuale e sul quantitativo medio di rifiuti raccolti (kg) con ogni svuotamento, le principali tipologie di rifiuti raccolte, non sottovalutando le variabilità stagionali in porti soggetti a flussi turistici di passeggeri.
In ogni caso è buona prassi che, in fase di affidamento dei servizi di raccolta dei rifiuti portuali, l’Autorità competente nel porto preveda che i soggetti incaricati comunichino periodicamente informazioni dettagliate circa la provenienza, quantità e tipologie dei rifiuti portuali raccolti.
Un esempio di come organizzare i dati raccolti relativi a questi rifiuti è riportato nella Tabella seguente:
(2).png)
Schema tipo per il riepilogo delle informazioni raccolte presso le ditte concessionarie
dei servizi di raccolta
Procedure di raccolta dei rifiuti portuali
Le modalità con cui vengono raccolti i rifiuti portuali sono differenti a seconda della loro provenienza. Sono descritte di seguito le procedure adottate per:
- il ritiro dei rifiuti provenienti da navi soggette a notifica
- il conferimento dei rifiuti provenienti da navi non soggette a notifica
- il ritiro dei rifiuti genericamente prodotti nell’area portuale
- la raccolta dei rifiuti derivanti dalla pulizia delle aree comuni e degli specchi acquei portuali
(3).png)
Modalità di conferimento dei rifiuti prodotto dalla nave e dei residui del carico
L’art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 182/2003 stabilisce le modalità di conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave e quelle di conferimento dei residui del carico (articolo 10).
Il comandante della nave, ogniqualvolta lascia il porto di approdo, conferisce i rifiuti prodotti dalla nave all'impianto portuale di raccolta prima di lasciare il porto, salvo il caso di navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari. Tuttavia, la nave può proseguire verso il successivo porto di scalo senza avere adempiuto in deroga a tale prescrizione previa autorizzazione dell'Autorità marittima, che avvalendosi dell'Autorità sanitaria marittima e del chimico del porto, ove presenti, abbia accertato che la stessa nave abbia una capacità di stoccaggio sufficiente per i rifiuti già prodotti ed accumulati e per quelli che saranno prodotti fino al momento dell'arrivo presso il successivo porto di conferimento. Il conferimento dei rifiuti e dei residui ad un impianto di raccolta deve avvenire in conformità alle disposizioni della Convenzione Marpol 73/78.
L'Autorità competente, qualora ritenga che nel porto di conferimento previsto non siano disponibili impianti adeguati o nel caso in cui detto porto non sia conosciuto e sussista il rischio che i rifiuti vengano scaricati in mare, richiede alla nave di conferire i rifiuti prodotti prima di lasciare il porto.
Dunque la predetta deroga è subordinata dalla legge all'attività di controllo dell'Autorità Marittima, che è l'organo deputato ad effettuare i controlli in materia di Port State Control (PSC).
Ai rifiuti sanitari ed ai rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali si applicano le disposizioni vigenti in materia. Per quanto riguarda i residui del carico (art. 10) il comandante della nave che fa scalo nel porto li conferisce ad un impianto di raccolta in base alle disposizioni della convenzione Marpol 73/78 e dei relativi allegati I, II, II, IV e V (riguardanti le merci inquinanti, le sostanze liquide nocive, le sostanze dannose, le acque reflue e quelle di sentina, ed i rifiuti associati al carico); tali residui saranno avviati in via prioritaria al riciclaggio ed al recupero nel rispetto della normativa vigente.
Per assicurare il rispetto delle norme sopra descritte, l’art. 11 prevede che l'Autorità marittima esegua delle ispezioni. Nella scelta delle navi da ispezionare, l'Autorità marittima si interessa in particolare:
- della nave che non ha adempiuto agli obblighi di notifica di cui all'articolo 6;
- della nave per la quale le informazioni fornite dal comandante, ai sensi dell'articolo 6, possano far ritenere l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 10.
L’attività di accertamento consiste nella valutazione del «modulo di notifica» e della capacità di stoccaggio dei rifiuti a bordo in funzione degli spazi disponibili, della durata del viaggio nonché delle possibilità di successivo conferimento.
Qualora l'Autorità marittima accerti la violazione degli articoli 7 e 10, essa provvede affinché la nave non lasci il porto fino al conferimento dei rifiuti e dei residui del carico all'impianto di raccolta, in misura tale da ottemperare ai citati articoli. Nell’ipotesi in cui la nave contravvenga al divieto di lasciare il porto, l'Autorità marittima informa immediatamente l'Autorità marittima del successivo porto di scalo.
Il ritiro dei rifiuti provenienti da navi soggette a notifica
I Comandanti delle navi dirette verso un porto situato nel territorio italiano o di un altro Stato Membro della Comunità Europea devono comunicare e trasmettere all’Autorità competente nel porto di scalo tutte le «informazioni» inerenti i rifiuti prodotti dalla nave e dai residui del carico mediante la compilazione del «modulo di notifica» (Allegato). Tale modello, debitamente compilato in ogni sua parte può essere inviato anche a cura dell’Agenzia marittima della nave.
La tempistica dell’invio della notifica da parte del Comandante della nave è la seguente:
- almeno 24 ore prima dell’arrivo della nave presso il porto, se il porto è noto;
- non appena il porto di scalo è noto, qualora conosciuto a meno di 24 ore dall’arrivo;
- prima della partenza della nave dal porto di scalo precedente, in caso di durata del viaggio inferiore a 24 ore.
Il servizio di raccolta dei rifiuti può essere organizzato per erogare le prestazioni in modo continuativo (ad esempio dalle 8.00 h alle 24.00 (16 h) o 24 h su 24 h) in base alle esigenze del porto e alla regolamentazione locale; inoltre è possibile definire delle modalità operative per organizzare il servizio anche su chiamata ossia in seguito a necessità esplicitamente comunicate dal Comandante della nave. Il personale operativo deve essere in numero sufficiente ed adeguatamente formato per garantire l’efficacia del servizio.
Le fasi operative per la raccolta dei rifiuti distinti per tipologia, provenienti dalle navi soggette a notifica
►Rifiuti prodotti dalle attività di bordo
I rifiuti prodotti dalle attività di bordo (assimilabili agli urbani, alimentari e altri non speciali e non pericolosi) devono essere, differenziati per tipologia dal personale di bordo, per permettere un corretto conferimento. Compiute le fasi di accertamento preliminare del quantitativo e della tipologia, il ritiro dei rifiuti può avvenire, da parte del personale addetto al servizio, via terra o via mare a seconda se la nave si trova in all’ormeggio o in rada:
- navi all’ormeggio in banchina: mediante autocarro equipaggiato o altro mezzo. Il personale di bordo della nave richiedente provvede a scaricare i rifiuti, il personale addetto si reca sotto bordo e procede al ritiro dei sacchetti e/o dei contenitori.
- le navi in rada: mediante motobarca opportunamente equipaggiata. Le manovre di avvicinamento, di ormeggio e di disormeggio della nave dalla quale deve essere effettuato il ritiro dei rifiuti devono essere effettuate in osservanza delle norme di prevenzione degli abbordi in mare, a cura e sotto la responsabilità dei comandanti e con modalità con essi concordate. Il trasbordo dei rifiuti viene effettuato dal personale di bordo e dagli addetti al servizio e deve avvenire in condizioni meteomarine favorevoli.
Ultimate le operazioni di ritiro, sia via terra che via mare:
- viene fatto sottoscrivere dal Comandante della nave beneficiaria del servizio (o da un delegato) il “Buono di prestazione”;
- i mezzi nautici rientrano nel porto (nel caso di ritiro via mare);
- i rifiuti vengono trasportati presso l’apposito impianto portuale di raccolta o presso i centri di trattamento e/o smaltimento, opportunamente individuati ed autorizzati. Per i rifiuti assimilabili agli urbani e speciali non pericolosi, qualora non differenziati, sarà necessario compiere un’opportuna selezione e cernita allo scopo di separare le diverse tipologie di rifiuti, di assicurare il controllo e l’eliminazione di eventuali frazioni non compatibili di diversa classificazione e, successivamente, di avviare al corretto recupero i materiali recuperati e allo smaltimento gli altri residui;
- i rifiuti alimentari putrescibili non recuperabili dovranno essere trasportati in giornata presso gli impianti di smaltimento autorizzati; per le altre tipologie di rifiuti è possibile prevedere lo stoccaggio presso l’area di messa in riserva presente nell’impianto portuale di raccolta, con successivo periodico conferimento ai più vicini centri di trattamento e/o smaltimento autorizzati.
► I rifiuti alimentari provenienti dai Paesi Extra U.E. collocati in appositi contenitori, devono essere smaltiti in impianti di incenerimento o in discarica previa sterilizzazione da effettuarsi secondo le modalità tecniche indicate nell’art. 4 comma 3 del Decreto del Ministero della Sanità del 22 maggio 2001; ai sensi dello stesso Decreto la vigilanza relativa all’attività di sbarco e raggruppamento di detti rifiuti e l’attività di sterilizzazione, all’interno del sedime portuale, è esercitata dagli Uffici di Sanità Marittima ed Aerea e dagli Uffici Veterinari di Porto.
► Oli esauriti e residui oleosi
Il servizio di raccolta degli oli esauriti e di altri residui oleosi si svolge utilizzando un autocarro con cisterna scarrabile o gli altri appositi mezzi nautici qualora la nave sia in rada. Le cisterne/contenitori/serbatoi devono essere provvisti di sistemi di chiusura e di dispostivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. Tali sistemi devono essere dotati di dispositivi di antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno, devono inoltre prevedere indicatori di livello e sfiati captati ed abbattuti da un idoneo sistema di abbattimento. Le manichette e i raccordi dei tubi devono essere mantenuti in perfetta efficienza per evitare dispersioni nell’ambiente.
I liquidi possono essere pompati direttamente dal bordo della nave o dalla ditta concessionaria, sia che la nave sia in rada o all’ormeggio:
- se i liquidi sono pompati direttamente dal bordo della nave, gli operatori della ditta devono prendere in consegna la manichetta o le manichette e collocarla/e al bocchettone della cisterna. Una volta che la cisterna si è riempita, gli operatori addetti al controllo del livello del liquido nella cisterna fanno interrompere le operazioni di pompaggio a bordo della nave, riconsegnano la/e manichetta/e e chiudono il bocchettone della cisterna;
- se i liquidi sono pompati dai mezzi della ditta concessionaria, l’intervento viene eseguito dall’operatore con l’utilizzo di una motopompa con manichetta/e per aspirare i rifiuti liquidi dalla nave. L’operatore dovrà stendere la/e manichetta/e fino al punto di raccolta della nave e collegarla/e al bocchettone della cisterna, accendere la motopompa, controllare le operazioni di carico e una volta riempita la cisterna spegnere la motopompa e togliere la/e manichetta/e dal bocchettone.
Ultimate le operazioni di ritiro:
- viene fatto sottoscrivere dal Comandante della nave beneficiaria del servizio (o da un delegato) il “Buono di prestazione”;
- al riempimento della cisterna il personale addetto al servizio si recherà presso un apposito Centro Autorizzato per lo scarico dei rifiuti liquidi.
► Rifiuti speciali pericolosi e non
I rifiuti speciali, pericolosi e non, dovranno essere conferiti in appositi contenitori e opportunamente identificati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, evitando la miscelazione perché espressamente vietata. Compiute le fasi di accertamento preliminare del quantitativo e della tipologia, il ritiro dei rifiuti si svolge utilizzando un autocarro autorizzato con idoneo cassone.
Ultimate le operazioni di ritiro:
- viene fatto sottoscrivere dal Comandante della nave beneficiaria del servizio (o da un delegato) il “Buono di prestazione” (Allegato);
- i rifiuti vengono trasportati presso l’apposito impianto portuale di raccolta o presso i centri di trattamento e/o smaltimento autorizzati. Per i rifiuti speciali non pericolosi, qualora non differenziati, sarà necessario compiere un’opportuna selezione e cernita allo scopo di separare le diverse tipologie di rifiuti, di assicurare il controllo e l’eliminazione di eventuali frazioni non compatibili di diversa classificazione e, successivamente, di avviare al corretto recupero i materiali recuperati e allo smaltimento gli altri residui;
- i rifiuti potranno essere stoccati presso l’area di messa in riserva per rifiuti pericolosi o non pericolosi presente nell’impianto portuale di raccolta, con successivo periodico conferimento ai più vicini centri di trattamento e/o smaltimento autorizzati.
Fra i rifiuti speciali, pericolosi e non, possono rientrare anche i rifiuti sanitari il cui conferimento deve avvenire in sacchetti distinti; in caso di rifiuti a rischio infettivo gli stessi dovranno essere conferiti in appositi contenitori. La normativa di riferimento per i rifiuti sanitari è il Decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 15 luglio 2003 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”.
► Acque nere
Il servizio si svolge utilizzando un autocarro con cisterna scarrabile o gli altri appositi mezzi nautici qualora la nave sia in rada. I liquidi possono essere pompati direttamente dal bordo della nave o dalla ditta concessionaria (Vedi fasi operative Oli esauriti e residui oleosi) Al riempimento della cisterna il personale addetto al servizio si recherà presso un apposito impianto di depurazione per lo scarico dei rifiuti.
► Utilizzo di mezzi nautici e terrestri
Il ritiro dei rifiuti dalle navi soggette a notifica si attua attraverso l’utilizzo di mezzi nautici e terrestri. La prevalenza del ritiro dei rifiuti con mezzi nautici rispetto a quelli terrestri può trovare la sua ragione in base alle caratteristiche geografiche dell’area portuale, ai luoghi di ancoraggio delle navi che stazionano nel porto e al posizionamento delle banchine. Ad esempio nel caso di navi in rada la ditta dovrà provvedere al ritiro in loco dei rifiuti utilizzando mezzi nautici.
I possibili mezzi nautici e terrestri utili per il ritiro dei rifiuti sono di seguito elencati.
• Mezzi Nautici
- rimorchiatori di potenza variabile;
- motobarche abilitate al trasporto di merci pericolose;
- battelli ecologici polivalenti;
- bettoline per il trasporto di prodotti petroliferi;
- bettoline per il trasporto di rifiuti solidi;
- motobarche e/o bettoline per il ritiro giornaliero di rifiuti costituiti da frazioni organiche putrescibili e rifiuti solidi assimilati ed assimilabili;
- bettoline per ritiro delle acque di sentina.
• Mezzi terrestri
- autocarri scarrabili di portata;
- autocarri scarrabili con gru ragno;
- autocisterne;
- macchine operatrici con braccio a ragno/benna;
- compattatori ecologici;
- contenitori ecologici e/o cassoni scarrabili stagni e non;
- pressa-rifiuti;
- mezzi per il ritiro giornaliero di rifiuti costituiti da frazioni organiche putrescibili e rifiuti solidi assimilati ed assimilabili;
- mezzi di varia capacità e tipologia a seconda delle differenti tipologie di rifiuto da raccogliere e trasportare.
I mezzi nautici devono risultare conformi alle specifiche prescrizioni stabilite dalla vigente normativa ed essere abilitati allo svolgimento del relativo servizio, con particolare riferimento al trasporto di rifiuti pericolosi e all’indicazione della relativa classe. Ogni mezzo nautico è sottoposto a revisione e controllo periodico dal Registro Italiano Navale (RINa) per il rinnovo dell’abilitazione alla navigazione e dall’Autorità competente nel porto per la sicurezza.
I mezzi terrestri sono sottoposti ad autorizzazione e le ditte che effettuano il trasporto di rifiuti, pericolosi o non, devono essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale gestori ambientali (in ottemperanza all’art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006) e alle revisioni periodiche previste dalla legislazione in materia di trasporti (revisione annuale presso la MCTC – Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione).
Modulo di Notifica: Fac-Simile
Modulo di dichiarazione contenente le informazioni da notificare prima dell’entrata nel porto, come previsto nell’Allegato 3 del D.Lgs. n. 182/2003
L’art. 6 del decreto stabilisce infatti che il comandante deve notificare all’Autorità Marittima riportandoli sul citato modulo i seguenti dati:
- nome della nave, indicativo radio, numero IMO;
- stato di bandiera;
- ora presunta di arrivo (ETA);
- ora presunta di partenza (ETD);
- precedente e successivo porto di scalo;
- ultimo porto di scalo in cui sono stati conferiti i rifiuti prodotti dalla nave;
- la dicitura “intendete conferire tutti/alcuni/nessuno dei vostri rifiuti in impianti portuali di raccolta
- tipo e quantitativo di rifiuti e residui da conferire o trattenuti a bordo e percentuale della di stoccaggio della nave;
Nel caso in cui si intende scaricare tutti i rifiuti, bisogna compilare la seconda colonna come occorre. Se si intende scaricare alcuni rifiuti o nessun rifiuto, bisogna completare tutte le colonne.
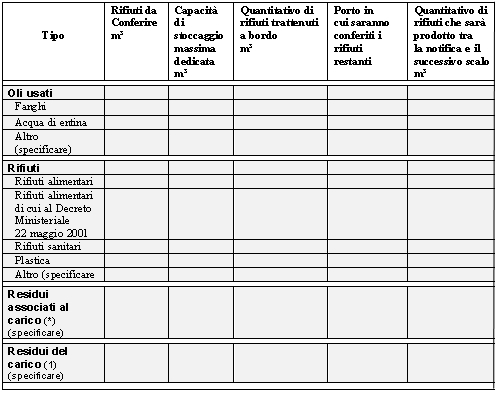
(1) Può trattarsi di stime
(*) Contrassegnare la casella appropriata
Note:
Tali informazioni possono essere usate per i controlli degli Stati di approdo e per altri scopi connessi con le ispezioni.
Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, salvo nel caso previsto all’art. 6, comma 3 del D.Lgs. n. 182/2003.
Io sottoscritto ………………………………… dichiaro che le suddette informazioni sono corrette e che a bordo vi è una capacità dedicata sufficiente per stoccare tutti i rifiuti prodotti tra il momento della notifica ed il successivo porto in cui saranno conferiti rifiuti.
Data ………………………….
Ora …………………………….. Firma
…………………………..
Buono di Prestazione: Fac-Simile
Schema tipo di un “Buono di prestazione “
(2).png)
Il conferimento dei rifiuti provenienti da navi non soggette a notifica
I Comandanti delle navi non soggette a notifica (pescherecci e unità da diporto fino a 12 passeggeri), dovranno provvedere ad organizzarsi autonomamente per consegnare i rifiuti prodotti. I rifiuti derivanti dalle normali attività di bordo, non pericolosi, potranno essere conferiti presso appositi cassonetti dislocati nell’area e/o presso gli impianti portuali di raccolta, in cui saranno presenti anche opportuni cassonetti dedicati alla raccolta delle frazioni differenziate (carta, plastica, vetro, metalli, ecc.). I rifiuti speciali, pericolosi e non, e gli oli esauriti e residui oleosi dovranno essere obbligatoriamente conferiti presso gli impianti di raccolta portuali negli orari stabiliti dall’Autorità competente nel porto, previa concertazione con gli operatori interessati.
Diversamente, per le acque nere, dovrà essere predisposto un idoneo servizio per il loro prelievo, utilizzando un autocarro con cisterna scarrabile. I liquidi possono essere pompati direttamente dal bordo delle imbarcazioni o dalla ditta concessionaria (Vedi fasi operative Oli esauriti e residui oleosi descritte per il ritiro dei rifiuti provenienti da navi soggette a notifica).
Al riempimento della cisterna il personale addetto al servizio si recherà presso un apposito impianto di depurazione per lo scarico dei rifiuti. I conferimenti presso gli appositi impianti di raccolta avverranno in determinati orari di apertura e alla presenza di un responsabile appositamente individuato dal soggetto concessionario del servizio, che avrà l’incarico di verificare, e registrare la provenienza dei conferimenti e rilasciare il buono di conferimento.
La raccolta dei rifiuti genericamente prodotti nell’area portuale
I rifiuti indifferenziati devono essere raccolti mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivi odori e conferiti, a cura del produttore, presso i cassonetti predisposti. Per le frazioni di rifiuti recuperabili deve essere vietata la possibilità di conferimento presso i cassonetti destinati al rifiuto indifferenziato.
Il servizio dovrà essere assicurato tutti i giorni lavorativi e dovranno essere predisposte misure particolari in caso di festività infrasettimanali o festività multiple.
I rifiuti oggetto di raccolta differenziata sono, a titolo esemplificativo:
- rifiuti organici putrescibili ad alto tenore di umidità;
- residui di potatura e sfalcio d’erba provenienti dalla manutenzione di aree verdi;
- vetro;
- lattine;
- carta e cartone;
- plastica;
- materiali metallici;
- legno;
- pile;
- farmaci;
- apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- rifiuti ingombranti;
- altri rifiuti riciclabili.
Il produttore dovrà provvedere alla preventiva selezione dei suddetti materiali alla fonte ed al successivo conferimento nell’apposito contenitore in base alle frazioni per cui lo stesso è destinato. Nel caso in cui i quantitativi e la pezzatura di detti rifiuti superino le capacità dei contenitori e per i rifiuti pericolosi (batterie esauste, prodotti tossici e/o infiammabili), possono essere previsti conferimenti su chiamata concordati con il soggetto concessionario del servizio.
Modalità particolari saranno invece adottate per i rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) che, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2005, dovranno essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all’acquisto di un bene di tipologia equivalente; nel caso in cui non avvenga l’acquisto contestuale di un bene equivalente potranno essere conferiti, previo accordo, al soggetto concessionario del servizio.
La raccolta dei rifiuti derivanti dalla pulizia delle aree comuni e degli specchi acquei portuali
I rifiuti derivanti dalla pulizia delle aree comuni e degli specchi acquei portuali possono essere, in via ordinaria, raccolti da un unico soggetto concessionario del servizio di raccolta.
Le aree portuali comuni sottoposte a pulizia e spazzamento sono:
- le strade, le piazze ed i marciapiedi, classificati come aree demaniali marittime ai sensi del Codice di Navigazione, di uso comune non date in concessione;
- le scogliere e le banchine lungo l’ambito marittimo cittadino non date in concessione;
- le zone di collegamento tra la città e il porto, ubicate in area demaniale marittima.
Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci o altri materiali non deve rilasciare rifiuti di qualsiasi genere sull’area di uso comune e dovrà provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell’area stessa.
La pulizia degli specchi acquei potrà essere periodica o avvenire “su chiamata” e si svolgerà con l’ausilio di appositi mezzi nautici in grado di recuperare i rifiuti galleggianti. Date le usuali caratteristiche dei rifiuti raccolti dagli specchi acquei (es. legno, polistirolo, plastiche) è possibile prevedere una loro differenziazione, con successivo avvio a recupero.
Gli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi
In un porto, in via ordinaria ed anche in conformità all’art. 4 del D.Lgs. n. 182/2003, devono essere presenti impianti e servizi portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico opportunamente dimensionati e gestiti in relazione alla classificazione dello scalo stesso, dei servizi presenti nel portoe alle tipologie e frequenze dei traffici marittimi, al fine di assicurare il rapido conferimento di detti rifiuti e residui, evitando ingiustificati ritardi e garantendo nel contempo standard di sicurezza per l'ambiente e per la salute dell'uomo raggiungibili con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili.
L’impianto portuale di raccolta è definito come una qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile collocata all’interno del porto dove possono essere conferiti i rifiuti della nave ed i residui del carico prima che vengano avviati al recupero o allo smaltimento.
Ogni porto è dotato di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi[1] [1] e dei residui del carico adeguati in relazione alla classificazione dello stesso porto[2] [1] .
In generale possono prevedersi tre differenti tipi di impianti:
- per un porto di grandi dimensioni, ossia interessato da frequenti ed importanti traffici merci e passeggeri, potrà prevedersi la predisposizione di specifici impianti definiti “basi operative”;
- per un porto di medie dimensioni, ad esempio, interessato principalmente dall’approdo di pescherecci e imbarcazioni da diporto, gli impianti potranno assumere le caratteristiche di “aree attrezzate”;
- per i porti di piccole dimensioni o interessati da un esiguo numero di imbarcazioni in approdo è comunque necessario prevedere una dotazione minima per la raccolta dei rifiuti pericolosi: l’Isola nel porto ne rappresenta un esempio.
Il dimensionamento, la collocazione e le caratteristiche basilari di tali impianti, siano essi fissi, mobili o galleggianti, deve essere commisurata alla tipologia ed al quantitativo di rifiuti prodotti da navi e di residui del carico provenienti dalle navi che in via ordinaria approdano nel porto, tenuto conto delle esigenze operative degli utenti dello scalo, dell'ubicazione geografica, delle dimensioni del porto e della tipologia delle navi che vi fanno scalo, e deve essere conforme a quanto previsto nel «piano di raccolta» e «piano di gestione» dei rifiuti disciplinati dall'art. 5 del D. Lgs. 182/03. nonché delle esenzioni di cui all'articolo 7, comma 1. Tali impianti devono inoltre conformarsi alle vigenti disposizioni di sicurezza e di prevenzione incendi (es. D.Lgs. n. 81/2008, “Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”)
Non si esclude che un porto possa dotarsi di più tipologie di impianti contemporaneamente, in relazione alle proprie esigenze, indipendentemente dalle classi di dimensioni individuate in precedenza. Gli impianti dovranno essere strutturati in modo tale da assicurare un rapido conferimento dei rifiuti, evitando ingiustificati ritardi ai soggetti conferitori e garantendo, nel contempo, i necessari standard di sicurezza per l’ambiente e la salute dell’uomo, comprese le conformità previste dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, anche con l’ausilio delle migliori tecnologie disponibili.
Oltre alla presenza di detti impianti, nel porto dovranno essere dislocati appositi contenitori atti a raccogliere sia i rifiuti differenziati che quelli indifferenziati che non possono essere conferiti presso tali installazioni.
Nel «Piano di raccolta» vanno descritte le caratteristiche tecniche e gestionali di tali impianti, come ad esempio:
- le tipologie e la localizzazione degli stessi all’interno dell’area portuale, comprese le indicazioni sulle dimensioni e la struttura, allegando se possibile una semplice descrizione a tre dimensioni; è consigliabile definire anche quali aree nel porto non sono idonee ad ospitare impianti di questo tipo;
- le tipologie di rifiuti che possono essere raccolti ed eventuali specifiche modalità di conferimento per particolari categorie, nonché il dettaglio delle attrezzature e dei procedimenti di pretrattamento eventualmente adottati nel porto;
- le capacità massime, giornaliere ed annuali, relative ad ogni tipologia di rifiuto;
- le modalità di presidio, con l’indicazione degli orari di apertura e chiusura, la disponibilità della persona responsabile a rilasciare chiarimenti in merito alle modalità di conferimento, la possibilità di apertura su chiamata, ecc.;
- eventuali altre informazioni necessarie a descrivere l’idonea operatività.
[1] [1] I rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78)
[2] [1]I resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio (slop) e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui; tali resti comprendono eccedenze di carico-scarico e fuoriuscite).
Caratteristiche tecniche della base operativa per la raccolta dei rifiuti nei porti di grandi dimensioni
Per il buon funzionamento del servizio di gestione dei rifiuti in un porto interessato da un notevole flusso di navi, si può ipotizzare di realizzare, in ambito portuale, una base operativa, ossia un edificio munito di:
- una centrale di comunicazione uffici e locali amministrativi;
- locali per i dipendenti (spogliatoi, bagni, mensa ecc.);
- un’area per il ricovero mezzi ed eventuale officina;
- un’area destinata al conferimento e pre-trattamento dei rifiuti pericolosi;
- un’area destinata al conferimento e pre-trattamento dei rifiuti non pericolosi.
- un’area dedicata per la messa in riserva18 dei rifiuti pericolosi;
- un’area dedicata per la messa in riserva dei rifiuti non pericolosi.
Tutte le aree dovranno essere ben delimitate e distinte, mentre nel caso sia predisposta un’area destinata ai rifiuti infiammabili dovranno essere prese tutte le adeguate precauzioni previste dalla normativa antincendio.
Le aree destinate al conferimento e pre-trattamento dei rifiuti pericolosi e non, sono necessarie per una eventuale selezione e cernita nel caso in cui i rifiuti non siano conferiti correttamente differenziati; la superficie dovrà essere impermeabile e dotata di sistemi di raccolta per i reflui che potrebbero fuoriuscire dagli automezzi o derivare dai rifiuti. In queste aree dovrà essere installata apposita cartellonistica esterna per la segnalazione dell’impianto. Dovrà inoltre essere esposto il regolamento dell’impianto in cui saranno indicate: le modalità di conferimento dei rifiuti, gli orari di accesso, gli obblighi e i divieti di chi conferisce, le sanzioni applicabili, i riferimenti del gestore dell’area, le modalità di segnalazione delle inadeguatezze riscontate dagli utenti e un numero telefonico a cui poter comunicare eventuali situazioni di emergenza.
Il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte a seconda della categoria di rifiuto in deposito ed adeguatamente contrassegnate da tabelle ben visibili, per dimensioni e collocazione, in cui siano presenti le seguenti informazioni:
- le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell’uomo e per l’ambiente;
- i relativi codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati.
I contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità del rifiuto e devono essere provvisti di sistema di chiusura, di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento.
L’area destinata alla messa in riserva dei rifiuti pericolosi può essere organizzata anche in scaffalature con più livelli in altezza dove è possibile movimentare i rifiuti con muletti o altro mezzo di trasporto idoneo. In ogni singola scaffalatura devono essere stoccati rifiuti compatibili della medesima categoria; se questi si presentano allo stato liquido o contengono liquidi che possono fuoriuscire, le scaffalature devono essere dotate di apposito bacino di contenimento in modo da poter recuperare eventuali sversamenti. L’utilizzo delle scaffalature deve comunque garantire la sistemazione del rifiuto in totale sicurezza e l’accessibilità agli stessi per verificare eventuali perdite.
Per definire i volumi necessari per la messa in riserva è possibile ipotizzare, indicativamente, il rapporto tra i volumi di rifiuti pericolosi da conferire sulla volumetria disponibile pari a: 1 mc (rifiuti): 6 mc (spazio). Per dimensionare invece l’area di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi il rapporto è pari circa ad 1 mc (rifiuto): 3 mc (spazio necessario). Tali rapporti potranno essere in ogni caso ottimizzati adottando le migliori tecnologie disponibili.
Il trasporto di rifiuti non pericolosi dall’area destinata al conferimento alla zona per la messa in riserva avverrà tramite cassoni scarrabili opportunamente identificati.
La base operativa dovrà essere localizzata in un’area logisticamente idonea per l’espletamento del servizio e sarà costituita da un fabbricato di estensione variabile, ma la cui superficie sia tale da consentire una movimentazione dei rifiuti e delle attrezzature in ingresso ed in uscita in sicurezza.
Per i rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l’approvvigionamento dell’equipaggio e dei passeggeri e i loro residui sbarcati da mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, provenienti da Paesi extra-UE (così come definiti dal Decreto del Ministero della Sanità del 22 maggio 2001) e che devono essere smaltiti in impianti di incenerimento (o in discarica previa sterilizzazione) potrebbe rendersi utile, in seguito alla valutazione delle reali necessità, la realizzazione di un impianto di sterilizzazione presso la base operativa; per lo stesso dovrà essere predisposta un’area di conferimento dedicata.
Caratteristiche tecniche dell’area attrezzata per la raccolta dei rifiuti nei porti di medie dimensioni
Per il servizio di raccolta dei rifiuti nei porti di medie dimensioni si dovranno realizzare una o più aree attrezzate, a seconda delle caratteristiche del porto; infatti può riscontrarsi la necessità di predisporre distinte aree attrezzate da destinare alle navi soggette a notifica, alla flotta pescherecci e/o ai diportisti (ad esempio nel caso in cui il porto turistico sia completamente separato dal resto del porto).
Le aree attrezzate dovranno assicurare la raccolta dei seguenti rifiuti sia pericolosi che non pericolosi; tra i rifiuti pericolosi si ricordano:
- oli esauriti, per un massimo stoccabile di 10 ton e un totale annuo di 100 ton (quattro contenitori);
- filtri dell’olio usati, assorbenti, materiale filtrante, stracci ed indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose, per un massimo stoccabile di 5 ton e un totale annuo di 20 ton (un contenitori);
- batterie al piombo, per un massimo stoccabile di 10 ton e un totale annuo di 100 ton.
Per l’area si dovrà stabilire il quantitativo giornaliero massimo stoccabile, che usualmente, è pari a circa 25 ton.
I rifiuti pericolosi liquidi conferiti presso l’area attrezzata saranno stoccati in serbatoi idonei a contenere sostanze liquide pericolose ed in particolare dovranno essere muniti di:
- sfiati di capacità residua del 10%, che devono essere captatati ed inviati ad idonei sistemi di abbattimento;
- dispositivi di anti-traboccamento o da tubazione di troppo pieno;
- indicatori di allarme o di livello;
- idonei dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento travaso e svuotamento;
- un bacino di contenimento di capacità pari al contenitore stesso oppure, nel caso di un bacino per più serbatoi, di capacità pari ad almeno il 30% del volume dei serbatoi; in ogni caso la capacità del bacino di contenimento non dovrà essere inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10%;
- cartelli mobili adeguatamente posizionati per indicare le tipologie di rifiuti stoccati.
L’area attrezzata potrà essere anche munita di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti differenziati (umido/organici, vetro, lattine, carta e cartone, plastica, umido, ecc.) ed indifferenziati, predisponendo per i cassonetti dell’umido una raccolta frequente.
L’area attrezzata dovrà soddisfare i seguenti requisiti:
- essere ubicata in un’area logisticamente idonea per consentire agli utenti di conferire agevolmente i rifiuti;
- avere una dimensione adeguata per la movimentazione dei mezzi;
- essere delimitata da un pannello grigliato e montata su una base di cemento armato di altezza di almeno 80 cm per impedire l’entrata di acqua di dilavamento; il fondo deve essere costituito da bitume;
- all’interno dell’area saranno ubicati i bacini di contenimento nei quali verranno posti dei serbatoi di capacità adeguata a seconda della tipologia di rifiuto; i bacini di contenimento chiusi nella parte superiore da un grigliato metallico;
- l’area dovrebbe essere adeguatamente coperta e l’acqua piovana opportunamente convogliata.
La copertura dell’area attrezzata potrà essere costituita a falde in laminato metallico, con una superficie piana maggiore del basamento per meglio garantire l’allontanamento dell’acqua piovana.
Si dovrà inoltre prevedere l’installazione di apposita cartellonistica esterna per la segnalazione dell’impianto. Dovrà inoltre essere esposto il regolamento dell’impianto in cui saranno indicate:
- le modalità di conferimento dei rifiuti,
- gli orari di accesso all’area,
- gli obblighi e i divieti di chi conferisce,
- le sanzioni applicabili,
- i riferimenti del gestore dell’area,
- le modalità di segnalazione delle inadeguatezze riscontate dagli utenti,
- un numero telefonico a cui poter comunicare eventuali situazioni di emergenza.
Nel caso di un porto turistico gestito in concessione, al fine di garantire la corretta gestione dei rifiuti raccolti, l’Autorità Marittima o Portuale potrebbe prevedere di richiedere al concessionario:
- copia del contratto con l’erogatore del servizio autorizzato per la gestione dei rifiuti provenienti dalle imbarcazioni da diporto;
- il progetto descrittivo dell’organizzazione preposta alla gestione dei rifiuti;
- la statistica annuale dei rifiuti raccolti suddivisi per tipologia.
Isole nel Porto: caratteristiche tecniche e la dotazione minima necessaria nei porti di piccole dimensioni
Sono aree attrezzate per la raccolta dei rifiuti portuali pericolosi, realizzate con il contributo del Consorzio Obbligatorio per gli Oli Usati (COOU) e del Consorzio Obbligatorio per le Batterie al Piombo Esauste (COBAT).
In un porto di piccole dimensioni ed interessato da ridotti traffici navali è in ogni caso necessario assicurare la raccolta dei rifiuti pericolosi prodotti dalle navi in approdo e l’Isola nel porto può rappresentare in questi casi la soluzione ottimale. Le «Isole nel porto» consistono in apposite strutture metalliche coperte (le cui caratteristiche tecniche sono riportate in dettaglio nell’Allegato 1), all’interno delle quali sono collocati differenti contenitori per la raccolta di oli usati, batterie al piombo esauste, filtri dell’olio usati ed eventualmente lattine di olio.
Con lo stesso termine “L’isola nel Porto” ci si riferisce al progetto promosso dal Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati (COOU) e dal Consorzio Obbligatorio per le Batterie al Piombo Esauste (COBAT), finalizzato a sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema della dispersione in mare degli oli lubrificanti usati e delle batterie esauste e sui relativi danni ambientali generati dal fenomeno del “fai da te”. Infatti la nautica costituisce, insieme all’agricoltura e al fai da te nell’autotrazione, uno dei segmenti critici della raccolta di olio lubrificante usato e di batterie al piombo esauste. L’iniziativa è rivolta in particolar modo all’utenza costituita da piccole unità per le quali, essendo relativamente contenuti i volumi di rifiuto prodotti, può risultare relativamente “semplice” liberarsene scaricando gli oli e gettando le batterie direttamente in mare.
Le Isole nel porto costituiscono una struttura funzionale dedicata agli utenti dei porti; che collocate in punti strategici agevolano il conferimento di oli lubrificanti usati, filtri dell’olio e batterie esauste che se raccolti con cura e riutilizzati, forniscono un importante contributo alla bilancia dei pagamenti del nostro Paese, consentendo di risparmiare sulle importazioni sia di piombo che di petrolio. Con l’ultima isola inaugurata nel porto di Venezia, salgono a 59 le isole ecologiche installate in 31 porti italiani e attualmente sono in trattativa numerosi altri porti di interesse sia commerciale che turistico (ad es. Pesaro, Siracusa, Formia (LT), Rimini, Bari).
In conformità del D.Lgs. n. 182/2003 per giungere all’installazione delle isole ecologiche, fornite in comodato d’uso gratuito, ed al successivo avvio del servizio, i due Consorzi richiedono che vengano ad essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- l’Autorità Marittima - o dove istituita l’Autorità Portuale – preveda nel Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico, previa intesa con la Regione competente nel territorio, la collocazione dell’Isola;
- venga individuato il soggetto gestore dell’Isola, il quale provvederà anche a tutti i necessari adempimenti previsti per legge.
I risultati finora ottenuti con questa iniziativa sono decisamente positivi: nelle 59 isole ecologiche, sono già state recuperate circa 550 tonnellate di olio lubrificante usato e oltre 4000 tonnellate di batterie esauste.
Altra interessante iniziativa intrapresa dal COOU, assieme al COBAT e al Gruppo Italia Navigando S.p.A., è rappresentata dal progetto “Porti turistici”, tramite cui è stato siglato un protocollo d’intesa per l’attivazione di un servizio di raccolta gratuita dei rifiuti costituiti da oli lubrificanti usati e batterie al piombo esauste anche attraverso l’installazione di appositi centri nei porti turistici. Con questo accordo, i tre soggetti si impegnano alla gestione dei punti di conferimento dei rifiuti pericolosi derivanti dall’attività di diporto, le già collaudate “Isole nel porto”. Anche in questo caso, se il porto turistico è gestito in concessione, l’Autorità Marittima o Portuale potrebbe prevedere di richiedere al concessionario:
- la copia del contratto con l’erogatore del servizio autorizzato per la gestione dei rifiuti provenienti dalle unità da diporto;
- il progetto descrittivo dell’organizzazione preposta alla gestione dei rifiuti;
- la statistica annuale dei rifiuti raccolti suddivisi per tipologia.
Isola nel porto
Prospetto di un’ Isola nel porto - Allegato 1
L’Isola nel porto è costituita da un gazebo zincato a caldo e verniciato generalmente in azzurro e a base esagonale. Sul basamento esagonale in lamiera è posizionata una pavimentazione in ferro grigliato calpestabile.
La cavità tra basamento e pavimentazione costituisce un bacino per la raccolta di quantità di olio usato. Ai sei spigoli del basamento sono collegati sei pali per la tenuta del tetto realizzato in lamiera. La struttura è inoltre chiusa da 6 pannelli in grigliato zincato a caldo e verniciato a tutta altezza, di cui due apribili.
All’interno dell’isola sono posti n° 4 contenitori di colore azzurro:
- serbatoio per la raccolta dell’olio usato;
- contenitore in PVC per la raccolta delle batterie al piombo esauste;
- fusto per la raccolta i filtri olio usati;
- fusto per la raccolta delle lattine di olio;
- grigliato pedonale.
L’ingombro massimo è di 3 m x 3 m x h. 3.2 m circa e il peso a vuoto stimato è di 850 kg.
SEZIONE DI ISOLA NEL PORTO PIANTA DI ISOLA NEL PORTO
(2).png)
Prospetto di un’usuale Isola nel porto - Caratteristiche tecniche dell’Isola nel porto
Autorizzazioni per la realizzazione degli impianti portuali di raccolta in Italia
Fatta salva la disciplina in materia di concessione di beni demaniali e di servizi esplicitati con mezzi navali in regime di concessione, gli impianti portuali di raccolta sono autorizzati ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006. Tale disposizione non si applica se gli stessi sono considerati depositi temporanei ossia, come definiti nell’art. 183, comma 1, lettera m) del citato decreto, un raggruppamento di rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm) né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
- i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:
- con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;
- i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:
- con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;
- il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti pericolosi.
Nel rispetto al sopramenzionato D.Lgs. n. 152/2006 (art. 208) i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda di autorizzazione alla Regione competente nel territorio; anche in questo caso tali disposizioni non si applicano ai depositi temporanei.
L’affidamento dei lavori per la realizzazione degli impianti portuali di raccolta avviene mediante gara ad evidenza pubblica in conformità alla legislazione nazionale e comunitaria vigente.
Competenze per la realizzazione di opere marittime in Italia
Gli impianti portuali di raccolta, se consistono in strutture fisse, ossia inamovibili, sono considerati «opere marittime» e per la loro realizzazione si dovranno considerare le differenti competenze che possono essere presenti in una realtà portuale.
In Italia attualmente l’ordinamento e le attività portuali sono disciplinate con la Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 “Riordino della legislazione in materia portuale”; la stessa abroga in parte, ma non del tutto, il Regio Decreto n. 713 del 26 settembre 1904 (che approva il regolamento per la esecuzione della legge sui porti, spiagge e fari) che costituisce ancora il riferimento per l’originaria specifica e nozione di opere portuali e marittime in genere. Già prima dell’emanazione della Legge n. 84/1994, con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 15 gennaio 1972 “Trasferimento alle Regioni a Statuto Ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici” e il Decreto del Presidente delle Repubblica n. 616 del 24 luglio 197 “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382” erano state trasferite alle Regioni le competenze per le opere marittime relative ai porti della seconda categoria dalla seconda classe in poi e quelle relative agli approdi turistici e le aree del demanio marittimo di interesse turistico-balneare (art. 59 del DPR n. 616/197).
La Legge n. 84/1994 ha dato una prima risposta all’esigenza di razionalizzazione e di ammodernamento istituzionale ed operativo dell’ordinamento portuale, istituendo nei principali porti nazionali le Autorità Portuali, enti di diritto pubblico dotati di autonomia organizzativa, finanziaria e decisionale, alle quali sono state affidate, tra le altre, le funzioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere portuali. La medesima legge ha introdotto una nuova classificazione dei porti marittimi nazionali (a modifica della classificazione adottata dal RD n. 713/1904), basata su nuovi criteri riguardanti:
- il bacino di utenza esistente e potenziale, l’entità e la qualità del traffico, la capacità operativa degli scali, il livello di efficienza dei servizi di collegamento con l’entroterra; in particolare i porti marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti categorie e classi:
- categoria I: porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato;
- categoria II, classe I: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica internazionale;
- categoria II, classe II: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica nazionale;
- categoria II, classe III: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica regionale e interregionale.
Con la Legge n. 30 del 27 febbraio 1998 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l’incremento dell’occupazione”, che ha in parte modificato la Legge n. 84/1994, si specifica che i porti sede di Autorità Portuale appartengono comunque ad una delle prime due classi della categoria II.
I porti, o le specifiche aree portuali di cui alla categoria II, classi I, II e III, hanno le seguenti funzioni:
a) commerciale;
b) industriale e petrolifera;
c) di servizio passeggeri;
d) peschereccia;
e) turistica e da diporto.
A distanza di oltre dieci anni dall’emanazione, la nuova normativa non è ancora a regime per la mancata emissione del Decreto Ministeriale con cui dovranno essere individuati i porti o le specifiche aree portuali appartenenti alla categoria I.
La riorganizzazione sopradescritta prevede che siano di competenza regionale le funzioni amministrative concernenti le opere marittime relative ai porti di categoria II, classi II e III, mentre spetta allo Stato l’onere per la realizzazione delle opere nei porti di categoria I e per le opere di grande infrastrutturazione nei porti appartenenti alla categoria II, classi I e II. Infine spetta alle Regioni interessate l’onere per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di categoria II, classe III.
Con il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59” è stata confermata la precedente normativa sulla ripartizione delle competenze, prevedendo il conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative:
- all’estimo navale;
- alla disciplina della navigazione interna;
- alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale ed interregionale delle opere edilizie a servizio dell’attività portuale;
- al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia;
- all’attività di escavazione dei fondali dei porti in cui non è istituita l’Autorità Portuale.
Nei porti di categoria II, classi I, II e III, con esclusione di quelli aventi le funzioni turistiche e da diporto, l’ambito e l’assetto complessivo del porto, comprese le aree destinate alla produzione industriale, all’attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono rispettivamente delimitati e disegnati dal "Piano Regolatore Portuale" che individua inoltre le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate. Le previsioni del Piano Regolatore Portuale non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti. Nei porti nei quali è istituita l’Autorità Portuale, il Piano Regolatore è adottato dal Comitato portuale, previa intesa con il Comune o i Comuni interessati. Nei porti di categoria II nei quali non è istituita l’Autorità Portuale, il Piano Regolatore è adottato dall’Autorità Marittima, previa intesa con il Comune o i Comuni interessati. Il Piano è quindi inviato per il parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il Piano Regolatore relativo a tutti i porti di categoria II, esaurite le procedure di consultazione, è sottoposto alla valutazione dell’impatto ambientale ed è quindi approvato dalla Regione competente.
I contenitori per la raccolta dei rifiuti dislocati nell’area portuale
I rifiuti portuali che non vengono conferiti presso gli impianti di raccolta dovranno essere raccolti tramite appositi «contenitori/cassonetti» dislocati nell’area portuale.
La collocazione dei contenitori nell’area portuale avverrà considerando:
- le categorie di produttori presenti nell’area portuale;
- le categorie di rifiuti che in via ordinaria devono essere conferiti;
- le principali tipologie di raccolte differenziate da attivare.
In una stessa area possono essere collocati più cassonetti in funzione della richiesta del servizio e delle condizioni oggettive dei luoghi. Per le frazioni organiche putrescibili costituite da residui provenienti da mense pubbliche e private, punti di ristorazione ed esercizi commerciali, dovranno adottarsi delle misure aggiuntive in quanto devono essere conferite in contenitori situati in piazzole o altre aree appositamente individuate presso le mense, i centri di ristorazione ed in genere presso le utenze collettive.
Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, nel collocare i cassonetti deve essere mantenuta una distanza di 5 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati, e ingressi di attività commerciali (bar, supermercati, tavole calde, ristoranti, ecc.). I contenitori dovranno essere posti in luoghi in cui si possano eseguire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi; per consentire tali operazioni da parte dei mezzi del soggetto concessionario del servizio, gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati liberi dall’utenza automobilistica, come anche previsto dall’art. 158 del Codice della Strada, e gli stessi non dovranno costituire intralcio alla circolazione veicolare e pedonale (art. 25 del Codice della Strada).
L’area occupata dai contenitori deve essere delimitata da apposita segnaletica orizzontale di colore giallo e, se necessario, devono essere installate protezioni di ancoraggio e di fermo.
I contenitori dovranno essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali; i cassonetti destinati alla raccolta dei rifiuti organici putrescibili dovranno disporre di chiusura ermetica non solo per impedire il rovistamento da parte di animali, ma anche per evitare la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti o di eventuali liquidi formatisi.
La capacità dei cassonetti sarà variabile in relazione al tipo di rifiuto raccolto, all’utenza portuale che ne usufruirà, considerando i relativi indici di produzione, alle dimensioni della rete stradale e alle caratteristiche dei mezzi che li devono movimentare. Sui contenitori dovranno essere chiaramente indicate le tipologie di rifiuti che in essi possono essere inseriti e le modalità di conferimento.
I contenitori dovranno essere sottoposti a manutenzione, pulizia e disinfezione periodica.
Infine, per garantire il mantenimento della pulizia delle aree portuali comuni, dovranno essere dislocati appositi contenitori portarifiuti, dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti minuti prodotti occasionalmente dagli utenti delle aree sopra indicate; in essi non potranno essere conferite altre tipologie di rifiuti.
I compiti dei soggetti concessionari dei servizi di raccolta dei rifiuti portuali
Il soggetto pubblico o privato che intende realizzare un impianto fisso di raccolta, deve dapprima ottenere il rilascio di una «concessione demaniale» dall’ Autorità Portuale ai sensi dell’art. 18 della Legge 84/94, limitatamente agli scali marittimi ove la stessa sia stata istituita, collocandosi tale struttura nell’ambito portuale così come individuato dal “Piano regolatore portuale”. Di contro, le incombenze amministrative dell’atto concessorio ricadranno sull’Autorità Marittima, che esplica la sua funzione amministrativa attraverso il Capo del Compartimento Marittimo o Direttore marittimo, fermo restando che per il rilascio delle concessioni di durata superiore ai 15 anni la competenza ricade sul Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Nel rispetto al D.Lgs. n. 152/2006 (art. 208) i soggetti che intendono realizzare e gestire impianti di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda di "autorizzazione" alla Regione competente nel territorio; anche in questo caso tali disposizioni non si applicano ai depositi temporanei. L’affidamento dei lavori per la realizzazione degli impianti portuali di raccolta avviene mediante gara ad evidenza pubblica in conformità alla legislazione nazionale e comunitaria vigente. Sulla base dell’esperienza italiana, la gestione delle varie tipologie di rifiuti portuali è svolta da soggetti concessionari differenti selezionati tramite gara ad evidenza pubblica.
Sulla base dell’esperienza italiana, la gestione delle varie tipologie di rifiuti portuali è svolta da soggetti concessionari differenti selezionati tramite gara ad evidenza pubblica.
- Per i rifiuti prodotti dalle navi, il soggetto incaricato del servizio deve:
- assicurare che raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento avvengano in condizioni di massima sicurezza e comunque nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente; in particolare si dovrà verificare che i rifiuti vengano consegnati ad impianti dedicati, appositamente autorizzati;
- provvedere alla gestione dei cassonetti e degli impianti portuali di raccolta;
- provvedere agli adempimenti relativi alla vigente normativa sui rifiuti;
- documentare il conferimento presso gli impianti rilasciando al soggetto conferitore di rifiuti il “Buono di prestazione”;
- comunicare periodicamente all’Autorità competente nel porto i quantitativi di rifiuti raccolti, recuperati, smaltiti, la loro provenienza e destinazione e altre informazioni che possano essere utili per valutare l’andamento della produzione degli stessi;
- distribuire, ai potenziali utenti del servizio, materiale informativo sull’organizzazione del servizio di raccolta rifiuti in ambito portuale, completo di una «scheda per la segnalazione delle inadeguatezze» (Allegato).
- Per i rifiuti genericamente prodotti nell’area portuale, il soggetto concessionario dovrà:
- assicurare che raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento avvengano in conformità alla normativa vigente;
- provvedere agli adempimenti amministrativi richiesti dalla legge;
- comunicare periodicamente all’Autorità competente nel porto i quantitativi di rifiuti raccolti, recuperati, smaltiti, la loro provenienza e destinazione e altre informazioni che possano essere utili per valutare l’andamento della produzione degli stessi;
- predisporre opportune campagne informative rivolte all’utenza portuale per potenziare la raccolta differenziata, in particolare dei rifiuti pericolosi.
- Il servizio di raccolta dei rifiuti derivanti dalla pulizia delle aree comuni e degli specchi acquei portuali potrà essere affidato ad un ulteriore soggetto concessionario che dovrà:
- eseguire la pulizia e lo spazzamento delle suddette aree;
- provvedere all’installazione di apposita segnaletica con pannelli integrativi, fissi e verticali, come descritti dal Codice della Strada;
- assicurare la pulizia, il diserbamento e la potatura periodica delle aree verdi comuni, nonché alla conseguente asportazione e smaltimento dei rifiuti così prodotti;
- fornire altri servizi su richiesta da parte dell’Autorità competente nel porto, da valutarsi di volta in volta, previo pagamento laddove eseguiti, come ad esempio può accadere per servizi “su chiamata”, da attivare in occasione di specifiche emergenze;
- garantire il servizio di pulizia degli specchi acquei portuali soprattutto nei periodi dell’anno in cui si riscontra una maggiore presenza di rifiuti galleggianti (es. in corrispondenza di elevati flussi di merci o di passeggeri nel porto);
- prevedere la raccolta differenziata delle frazioni di rifiuti raccolte e recuperabili provenienti dagli specchi acquei;
- comunicare periodicamente all’Autorità competente nel porto i quantitativi di rifiuti raccolti, recuperati, smaltiti, la loro destinazione e altre informazioni che possano essere utili per valutare l’andamento della produzione degli stessi.
Si sottolinea che in ambito nazionale, nei porti in cui non è istituita l’Autorità Portuale, per queste specifiche tipologie di rifiuti, si riscontrano modalità di gestione e di affidamento del servizio molto diversificate, calibrate sulla specificità della realtà locale.
Modalità di affidamento dei servizi di raccolta
Le Autorità Portuali e/o Autorità Marittime hanno la competenza in materia di rifiuti provenienti dalle navi e le stesse possono disciplinare il settore con atti di regolamentazione ed organizzazione, sia stabilendo i capitolati per le imprese erogatrici dei servizi, sia emanando apposite Ordinanze regolanti facoltà, diritti ed obblighi degli utenti e dei prestatori dei servizi.
Per i porti in cui è istituita l’Autorità Portuale, l’art. 6 della L. n. 84/1994 prevede che siano affidati in concessione dall’Autorità Portuale stessa mediante gara pubblica, i seguenti servizi di interesse generale da fornire a titolo oneroso all’utenza portuale (individuati con il D.M. del 14.11.199430):
- la pulizia, raccolta dei rifiuti e sversamento a discarica relativa agli spazi, ai locali e alle infrastrutture comuni e presso i soggetti terzi;
- la pulizia e disinquinamento degli specchi acquei portuali.
Per i rifiuti provenienti dalle navi e residui del carico, l’affidamento del servizio di raccolta deve avvenire mediante gara ad evidenza pubblica in conformità alla legislazione nazionale e comunitaria vigente, come riferito all’art. 4, comma 5 del D. Lgs. n. 182/2003. In considerazione del fatto che la concessione del servizio di ritiro rifiuti dalle navi rientra pienamente nella categoria delle concessioni di servizio, non è applicabile a tale istituto la normativa sugli appalti di servizio ed in particolare le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 157 del 17 marzo 1995, “Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi”.
E’ stato riconosciuto dalla giurisprudenza nazionale e dalla Commissione Europea che, pur non richiedendosi l’applicazione del D.Lgs. n. 157/95, il ricorso all’istituto concessorio non rende libera la scelta del soggetto a cui affidare la concessione, restando la scelta dell’erogatore assoggettata ai principi generali del Trattato U.E. costitutivo, nonché ai principi generali che governano la materia dei contratti pubblici (par condicio dei concorrenti, pubblicità dei bandi, trasparenza delle procedure, segretezze delle offerte economiche).
Tenuto conto di quanto sopra, la procedura selettiva di affidamento non necessariamente deve prevedere tutti gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 157/95, ma è sufficiente che siano pienamente soddisfatti i principi di parità di trattamento, di trasparenza, di non discriminazione, di proporzionalità.
Si stabiliscono pertanto le seguenti linee guida per la procedura selettiva:
- massima divulgazione dell’Avviso di gara il cui estratto andrà pubblicato su almeno due quotidiani a diffusione nazionale;
- possibilità ampia di partecipazione a livello comunitario senza discriminazione di nazionalità;
- individuazione preventiva dei requisiti che i candidati devono soddisfare durante la fase selettiva;
- scelta del candidato in base a criteri obiettivi, nel rispetto delle regole e dei requisiti inizialmente stabiliti.
Per la definizione dei requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria dei partecipanti dovrà ovviamente tenersi conto del principio di proporzionalità, evitando di fissare requisiti professionali o finanziari sproporzionati rispetto all’oggetto della concessione. Ad ogni modo potranno partecipare alla gara le imprese provviste del certificato di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori ambientali (art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006).
L’impresa concorrente dovrà dimostrare con idonea documentazione, di disporre, all’atto della partecipazione della gara, di tutti i mezzi d’opera ad attrezzature necessarie per lo svolgimento dei servizi.
Per garantire idonea capacità finanziaria sarà richiesto un capitale sociale minimo e un patrimonio netto di importo adeguato e ciò in base al bilancio dell’ultimo anno o a successiva documentazione legale, oltre ad una referenza bancaria di solvibilità e a fideiussioni il cui importo sarà stabilito nel bando di gara.
Per assicurare che i candidati abbiano un’esperienza qualificata nel settore, quale requisito tecnico per lo svolgimento ottimale del servizio, sarà legittimamente inseribile la clausola che limiti l’ammissione ai soli concorrenti che abbiano svolto servizi identici a quelli oggetto della concessione nei tre anni precedenti (in conformità alla Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 919 del 15 febbraio 2002) e che abbiano realizzato nel triennio precedente un fatturato, per ciascun esercizio finanziario, pari alla metà dell’importo presunto del servizio.
Completeranno il quadro i requisiti di moralità e di onorabilità e ciò secondo le consuete verifiche dei casellari giudiziali, della certificazione antimafia e dell’assenza di procedure concorsuali.
L’aggiudicazione del servizio sarà poi effettuata a favore dell’”offerta economicamente più vantaggiosa” (in linea con l’art. 23, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 157/95 in materia di appalti di servizi) da valutare sulla base di specifici parametri (ad es. ribasso sulla tariffa posta a base di gara, possesso di certificazione di qualità ISO 9001, ISO 14001 o EMAS, proposta tecnicooperativa migliorativa per l’espletamento del servizio, anni di esperienza per prestazioni identiche) attribuendo a ciascuno di essi un punteggio proporzionale all’importanza attribuita ad ogni parametro.
I soggetti concessionari dei servizi di raccolta dei rifiuti portuali non provenienti da navi potranno essere selezionati con le stesse modalità sopra descritte qualora il soggetto a cui fa capo il loro affidamento è l’Autorità Portuale o Marittima.
Si sottolinea che in ambito nazionale, nei porti in cui non è istituita l’Autorità Portuale, per queste specifiche tipologie di rifiuti, si riscontrano modalità di gestione e di affidamento del servizio molto diversificate, calibrate sulla specificità della realtà locale. Può, ad esempio, riscontrarsi che gli Enti Locali siano preposti alla manutenzione del porto: in questo caso gli stessi dovranno provvedere ad affidare i servizi di gestione di tali rifiuti tramite apposite gare, in conformità a quanto stabilito dall’art. 202 del D.Lgs. n. 152/2006.
Le ditte selezionate dovranno in ogni caso dimostrare di possedere idonei mezzi per svolgere questi servizi, come ad esempio imbarcazioni adatte al recupero di rifiuti galleggianti, automezzi per lo spazzamento e la disinfestazione stradale, automezzi per lo svuotamento dei cassonetti stradali, ecc.
Scheda di segnalazione inadeguatezze per impianti e servizi per il conferimento dei rifiuti
Fac-Simile
(2).png)
Quadro dei costi di gestione e regime tariffario
In seguito alla valutazione e pianificazione delle attività necessarie per una gestione completa dei rifiuti portuali dovranno essere stimati, il più fedelmente possibile, i costi di gestione sulla base delle voci successivamente individuate. E’ fondamentale valutare opportunamente tali importi per strutturare adeguatamente le tariffe a carico dell’utenza portuale che usufruirà dei servizi di raccolta dei rifiuti portuali. Tali tariffe saranno modulate anche in base alle differenti tipologie di imbarcazioni che approdano in via ordinaria nel porto. Il piano dovrà contenere il dettaglio di come le stesse sono state calcolate ed i relativi importi.
► Costi di gestione
Considerate le modalità di organizzazione, un generico soggetto concessionario di uno dei servizi di raccolta dei rifiuti portuali, dovrà sostenere i seguenti costi di gestione:
- COSTI PER LE STRUTTURE E ATTREZZATURE:
- installazione e manutenzione degli impianti portuali di raccolta (per il soggetto concessionario del servizio di raccolta dei rifiuti provenienti dalle navi);
- acquisto dei contenitori per la raccolta dei rifiuti portuali;
- COSTI DIRETTI:
- ritiro, trattamento e smaltimento dei rifiuti portuali;
- logistica (gasolio automezzi, gasolio unità navali impiegate, acqua, ecc.);
- personale impiegato per il presidio/custodia degli impianti di raccolta e per il rilascio delle ricevute di conferimento ai singoli utenti;
- personale operativo per l’impiego dei mezzi terrestri/nautici;
- altri costi operativi derivanti dall’espletamento del sevizio (manutenzione e riparazione dei mezzi e dei contenitori, assicurazione mezzi, vigilanza, ecc.).
- COSTI AMMINISTRATIVI:
- telefonia fissa e mobile;
- spese generali;
- consulenze;
- personale amministrativo
Regime tariffario per la raccolta dei rifiuti
- Regime tariffario per la raccolta dei rifiuti genericamente prodotti nell’area portuale e derivanti dalla pulizia delle aree comuni e degli specchi acquei portuali
In base all’art. 8 D.Lgs. n. 182/2003 i costi degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, quelli di investimento e quelli relativi al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti stessi sono recuperati attraverso la riscossione di tariffe a carico delle navi che approdano nel porto; i criteri per la determinazione della tariffa sono esposti nell’Allegato IV del Decreto stesso, ed in particolare l’Autorità competente nel porto determina l’importo della tariffa prevedendo:
- una quota fissa, indipendente dall’effettivo utilizzo degli impianti portuali di raccolta, commisurata in modo da coprire almeno il 35% dei costi di investimento e quelli relativi al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti. Detta tariffa può essere incorporata nei diritti portuali o costituire una tariffa standard distinta per i rifiuti, nonché essere differenziata in funzione della categoria, del tipo e della dimensione della nave;
- una quota correlata al quantitativo ed al tipo di rifiuti prodotti ed effettivamente conferiti dalla nave agli impianti portuali di raccolta, commisurata in modo da coprire la parte dei costi non coperta dalla quota di cui alla lettera a).
Per garantire l’equità e la trasparenza delle tariffe, il loro importo e i criteri sulla base dei quali sono state calcolate sono portati a conoscenza degli utenti del porto, come previsto all’art. 14 e nell’Allegato II del D.Lgs. n. 182/2003. Le tariffe possono essere ridotte se la gestione ambientale, la concezione, le attrezzature ed il funzionamento della nave sono tali che il Comandante della nave stessa può dimostrare che essa produce quantità ridotte di rifiuti. Possono essere previsti sconti o incentivi ad esempio per quelle unità che raccolgono i rifiuti abbandonati in mare o nei fondali, e raccolti occasionalmente con l’attività di pesca.
La tariffa per il conferimento dei residui del carico è richiesta esclusivamente per le navi che richiedono un apposito servizio. Si possono prevedere tariffe ridotte se la gestione ambientale, le attrezzature ed il funzionamento della nave sono tali da assicurare una produzione ridotta di questi rifiuti. Si potrà altresì prevedere un’ulteriore riduzione tariffaria qualora, in relazione all’incremento di traffico mercantile, aumentino le richieste di erogazione del servizio.
La tariffa per le unità da pesca e da diporto sarà costituita da una quota fissa, diversa per tipologia imbarcazione, obbligatoria, calcolata facendo riferimento ad un quantitativo standard; qualora l’unità conferisca quantitativi che superino la quantità standard o per particolari richieste di conferimento, si applicherà una maggiorazione per coprire le spese aggiuntive legate all’erogazione del servizio. Per le unità da diporto in transito potrebbe prevedersi il pagamento della tariffa solo nel caso in cui usufruiscano di un servizio erogato a titolo oneroso.
Per le navi in servizio di linea che effettuano scali frequenti e regolari il D.Lgs. n. 182/2003 prevede una deroga all’obbligo di conferimento prima dell’abbandono del porto. Per questa categoria di imbarcazioni è consigliabile applicare una tariffa base standard, ed una quota aggiuntiva in caso di richiesta di servizi particolari: tale strutturazione della tariffa dovrebbe incentivare il conferimento dei rifiuti presso il porto, scoraggiando lo scarico in mare degli stessi.
- Regime tariffario per la raccolta dei rifiuti genericamente prodotti nell’area portuale e derivanti dalla pulizia delle aree comuni e degli specchi acquei portuali
Per i rifiuti genericamente prodotti nell’area portuale dovranno essere previste apposite tariffe a carico dell’utenza portuale. Il loro importo dovrà essere commisurato all’effettivo quantitativo di rifiuti conferiti dall’utenza prevedendo appositi sistemi di misurazione/pesatura.
Nel caso in cui non siano disponibili tali sistemi si potranno adottare opportuni criteri di calcolo, basati ad esempio sull’individuazione di tariffe al mq di superficie tassabile, diversificate in base alla categoria dei locali.
Per i rifiuti derivanti dalla pulizia delle aree comuni e degli specchi acquei portuali i costi di gestione potranno essere recuperati, ad esempio, tramite i canoni di concessione applicati ai concessionari di aree portuali.
Sistema informativo integrato ed iniziative per la tutela dell’ambiente marino
Anche in conformità a quanto previsto nell’Allegato II del D.Lgs. n. 182/2003, l’Autorità competente nel porto dovrà fornire al Comandante della nave, al gestore del servizio ed agli altri utenti del porto un «Documento Informativo» che, in generale, contenga:
- un breve accenno sulla fondamentale importanza della corretta differenziazione e conferimento dei rifiuti portuali;
- l’ubicazione degli impianti portuali di raccolta per ogni banchina di ormeggio con diagramma e cartina;
- l’ubicazione dei contenitori per la raccolta differenziata ed indifferenziata dei rifiuti portuali;
- l’elenco dei rifiuti portuali raccolti in via ordinaria;
- l’elenco dei gestori delle attività di raccolta dei rifiuti portuali;
- l’elenco dei punti di contatto, degli operatori e dei servizi offerti;
- la descrizione delle procedure per il conferimento;
- la descrizione delle tariffe e del sistema di tariffazione;
- le eventuali agevolazioni concesse per comportamenti “virtuosi”;
- le sanzioni applicabili;
- le procedure per la segnalazione delle inadeguatezze rilevate.
In merito alle procedure per la segnalazione delle inadeguatezze i Comandanti delle navi che usufruiscono degli impianti portuali e dei servizi di raccolta, avranno in particolare a disposizione delle «Schede di segnalazione inadeguatezze» tramite cui comunicare eventuali disservizi riscontrati (un esempio di scheda è riportato nell’Allegato 6).
Nel Piano vanno inoltre indicate le procedure relative alle consultazioni permanenti con gli utenti del porto, con i soggetti concessionari dei servizi e con le altre parti interessate.
L’Autorità competente nel porto deve infine descrivere nel Piano le iniziative che intende realizzare per promuovere l’informazione agli utenti del porto al fine di ridurre i rischi di inquinamento dei mari causati dallo scarico in mare dei rifiuti e per favorire forme corrette di raccolta e trasporto.
I controlli in materia di Port State Control (PSC)
Per quanto riguarda il controllo e l’autorizzazione all’espletamento delle operazioni di carico e scarico, trasporto, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali, l’ambito è regolato dal combinato disposto dall’art. 16 della legge 84/94 e dall’art. 28, comma 6, del D.Lgs 22/97; ne consegue, quindi, la subordinazione ad un atto autorizzativo da parte dell’Autorità Portuale o, laddove non istituita, dall’Autorità Marittima. Mentre nel primo caso le Capitanerie di Porto svolgono attività di controllo e di polizia sotto l’aspetto inerente la “sicurezza della navigazione”, ed in effetti tale compito è riconosciuto anche in seno alla legislazione portuale del 1994 più volte citata; nel secondo, invece, espletano anche funzioni amministrative vere e proprie attraverso, appunto, il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni commerciali che, come si è detto, ricomprendono il carico, lo scarico, il trasbordo, deposito e maneggio di merci, materiali e persone in genere svolte in ambito portuale.
L’attività di controllo sull’adempimento delle disposizioni in materia di conferimento di rifiuti è demandato all’Autorità marittima che lo attua mediante «ispezioni» da effettuare su navi individuate, in particolare, tra quelle non adempienti agli obblighi di notifica di cui all'articolo 6 o per le quali le informazioni fornite dal comandante possano far ritenere che siano rimaste inosservate le disposizioni in materia di conferimento dei rifiuti di cui agli articoli 7 e 10.
Le Capitanerie di Porto, ai sensi dell’art. 11, hanno il compito di verificare l’osservanza delle disposizioni relative alla fase del “conferimento”, dando attuazione al D.M. n. 305/03 relativo all’attività di controllo dello stato di approdo. L’attività di accertamento ha inizio con un’attenta valutazione del modulo di notifica e della capacità di stoccaggio dei rifiuti a bordo in funzione degli spazi disponibili, della durata del viaggio nonché delle possibilità di successivo conferimento. Ne consegue, quindi, che in un siffatto quadro operativo, il personale della Guardia Costiera, darà priorità ai casi in cui la notifica non sia stata resa, oppure, anche se resa, la stessa risulti palesemente incongrua. Inoltre, è da evidenziare come l’Autorità Marittima, in via del tutto cautelativa, possa non esonerare la nave dall’obbligo di conferire i rifiuti qualora il porto di destinazione sia sconosciuto o vi sia la certezza che il medesimo non sia adeguatamente attrezzato per il conferimento. In caso di accertata violazione, l’Autorità marittima deve provvedere affinché la nave non lasci il porto fino al conferimento dei rifiuti o dei residui del carico all’impianto di raccolta., in misura tale da ottemperare alle disposizioni violate o, qualora la nave abbia già lasciato il porto, ad informare la corrispondente Autorità del successivo porto di scalo, in modo tale che provveda con le stesse modalità. L’impianto sanzionatorio è contenuto nell’art. 13.
Pur essendo state escluse dall’obbligo di notifica i pescherecci e le unità da diporto rimane fondamentale il ruolo assegnato alle Capitanerie di Porto–Guardia Costiera sull’attività di prevenzione, controllo e vigilanza sull’osservanza degli artt. 7 e 10 anche da parte di queste unità. Infatti, il comma 5 dell’art. 14, affida all’Autorità Marittima il compito di definire le procedure di controllo atte ad espletare l’attività cui prima si è fatto riferimento (si pensi al potere di regolamentazione esplicabile a mezzo ordinanza).
I compiti che vanno a delinearsi, quindi, si presentano piuttosto complessi e ricchi di particolari caratteri e problematiche tecnico–operative, ai quali si può ottemperare soltanto se si dispone di una grande responsabilità, dedizione e professionalità. Tutte prerogative che da sempre hanno contraddistinto e contraddistinguono gli uomini delle Capitanerie di Porto che si prodigano per la salvaguardia della vita umana in mare, per la sicurezza della navigazione e del personale marittimo e la protezione e salvaguardia dell’ambiente marino.
Impianto sanzionatorio in materia di rifiuti prodotti dalle navi
Per quanto concerne il sistema sanzionatorio attualmente vigente in materia di rifiuti, l'art. 13 del D.L.vo 24 giugno 2003 n. 182 “Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico”, prevede una serie di «sanzioni amministrative» per le violazioni commesse dai gestori degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti e dai comandanti delle navi.
- I gestori degli impianti e i responsabili del servizio raccolta che non adempiono ai dovuti «obblighi di comunicazione» e di «tenuta dei registri» sono soggetti alle sanzioni di cui all'art. 52 del D.Lgs 22/97, ora contenute nell'art. 258 del Testo Unico sull'ambiente (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari):
- Per le mancate o inesatte comunicazioni vi è la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro, mentre per l'omessa tenuta dei registri di carico e scarico, ovvero per l'incompletezza di tali registri, vi è la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro.
- Per i registri relativi a rifiuti pericolosi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 93.000 euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione.
- Il comandante della nave che non ottempera agli «obblighi di notifica» di cui all'art. 6, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3000 euro a 30.000 euro.
- Il comandante di una nave, diversa da un peschereccio o da un'unità da diporto che, approdando in un porto, «non conferisce i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico», in violazione degli artt. 7, comma 1, e 10, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3000 euro a 30.000 euro.
- Il comandante di un peschereccio o di un'unità da diporto che «non conferisce i rifiuti prodotti ad un sistema di raccolta», è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 500 euro.
► Competenza e giurisdizione
L’articolo 135, al comma 2 (Competenza e giurisdizione) del Testo Unico sull'ambiente dispone:«Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , ai fini della sorveglianza e dell’accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall’inquinamento provvede il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.); può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato. Il Corpo delle capitanerie di porto, Guardia costiera, provvede alla sorveglianza e all’accertamento delle violazioni di cui alla parte terza del presente decreto quando dalle stesse possano derivare danni o situazioni di pericolo per l’ambiente marino e costiero».
L’articolo 195, n. 5 (Competenze) del Testo Unico sull'ambiente dispone : «Fatto salvo quanto previsto da decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dell’accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di “rifiuti nonché della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti” (di cui alla parte quarta del presente decreto), provvedono il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) e il Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato».
Giurisprudenza
La giurisprudenza si è occupata più volte della tematica dei rifiuti prodotti dalle navi e dai porti. Con riferimento a quali sostanze possano essere ricondotte nell’ambito applicativo del D. Lgs. N. 182/2003, si legge che “Gli slops (e cioè le miscele contenenti idrocarburi derivanti dallo svuotamento dei bracci di carico delle navi dallo scarico delle valvole di sicurezza), se sono effettivamente ed oggettivamente riutilizzati in un diverso ciclo produttivo, anche dopo aver subito un trattamento preventivo minimo (decantazione), fuoriescono dal regime dei rifiuti in virtù dell'art. 14 l. 178/02: essi possono essere considerati sottoprodotti se ricorrono i requisiti dettati dall'art. 183, comma 1. lett. p), d.lg. 152/06 (vale a dire: origine da un processo non direttamente finalizzato alla sua produzione, che può consistere anche nella produzione di un servizio come il trasporto di beni, assenza della volontà del produttore di disfarsene, reimpiego certo ed integrale, rispetto di standard merceologici e di tutela ambientale, riutilizzo senza necessità di trattamento preventivo, valore economico)” (Cassazione penale, sez. III, 30 settembre 2008, n. 41839). Sono invece considerati rifiuti (pericolosi) le acque di sentina che vengono raccolte e ritirate all'esito delle operazioni di pulizia delle navi (Cassazione penale, sez. III, 27 giugno 2003, n. 38567).
Per quanto concerne le «autorizzazioni», invece, è stata ritenuta legittima l'attribuzione del servizio di prelievo dei rifiuti da navi nelle rade e nei porti nazionali, in via temporanea e d'urgenza, mediante autorizzazione temporanea, al fine di sopperire ad urgenti esigenze nelle more del procedimento di concessione (Consiglio di Stato, sex. VI, 21 febbraio 2001, n. 895). Non è invece consentito che un soggetto, autorizzato dall'autorità portuale alla sola raccolta dei rifiuti solidi scaricati dalle navi, provveda di fatto alla raccolta ed allo stoccaggio di ogni altro rifiuto delle attività portuali in mancanza di ulteriore espressa autorizzazione (Tribunale di Genova, 25 febbraio 2003).
La Cassazione civile, poi, con sentenza n. 19800 del 14 settembre 2006, è intervenuta in materia di sanzioni amministrative. In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che “l'ordinanza della Capitaneria di Porto che vincoli le navi in ingresso nel porto a tempi (nella specie di non oltre ventiquattro ore) di consegna dei rifiuti di bordo (anche non alimentari), non è in contrasto con le disposizioni della convenzione internazionale di Londra del 2 novembre 1973 (Marpol 73/78) per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, ratificata in Italia con l. 29 settembre 1980 n. 662, sebbene tale convenzione, nello stabilire (allegato V) le linee guida dei piani di smaltimento dei rifiuti da adottare dalle singole navi, non imponga limiti temporali vincolanti per lo scarico. Conseguentemente, in caso di inottemperanza alle disposizioni regolamentari temporali imposte dalla Capitaneria è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 1174 c.nav.”.
Infine, la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 25 settembre 2008, causa C-368/07, ha condannato l'Italia per omessa elaborazione ed applicazione dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti per tutti i porti italiani. Lo Stato italiano risulta infatti inadempiente relativamente agli obblighi previsti dagli art. 5, n. 1 e 16, n.1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico. Tala direttiva, infatti, impone ai Paesi dell’Unione Europea di ridurre gli scarichi in mare dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico, di rafforzare la protezione dell'ambiente marino e di far sì che ogni porto abbia un piano adeguato di raccolta e di gestione dei rifiuti. Il ricorso arriva dopo numerose sollecitazioni da parte della Commissione delle comunità europee, che già nel luglio 2004 aveva chiesto alla Repubblica italiana la conferma dell'adozione dei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti per tutti i porti italiani ed in particolare la trasmissione dei piani concernenti un campione di 19 porti. Nell'anno successivo lo Stato italiano aveva comunicato i piani di raccolta di alcuni porti (Napoli, Ravenna, Taranto e Trieste) ed i progetti di piani di raccolta di altri, portando la Commissione a formulare un parere motivato, in data 18 ottobre 2005, con il quale invitava a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi a tale parere nel termine dei due mesi successivi. Alla scadenza del termine l'Italia non aveva ancora adottato piani di raccolta per 10 dei 19 porti segnalati dalla Commissione.


