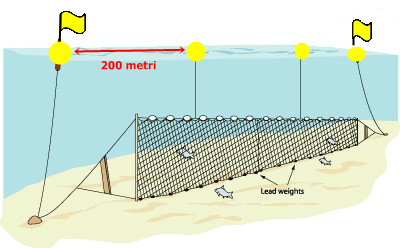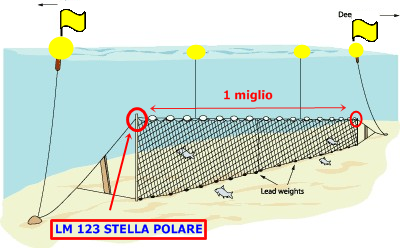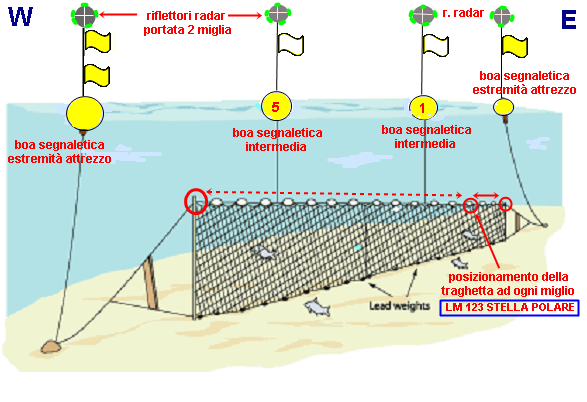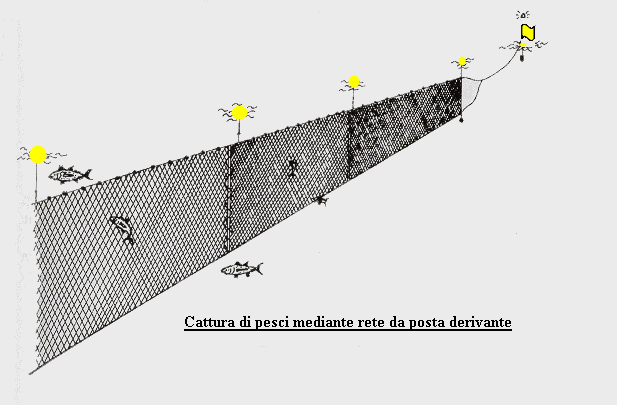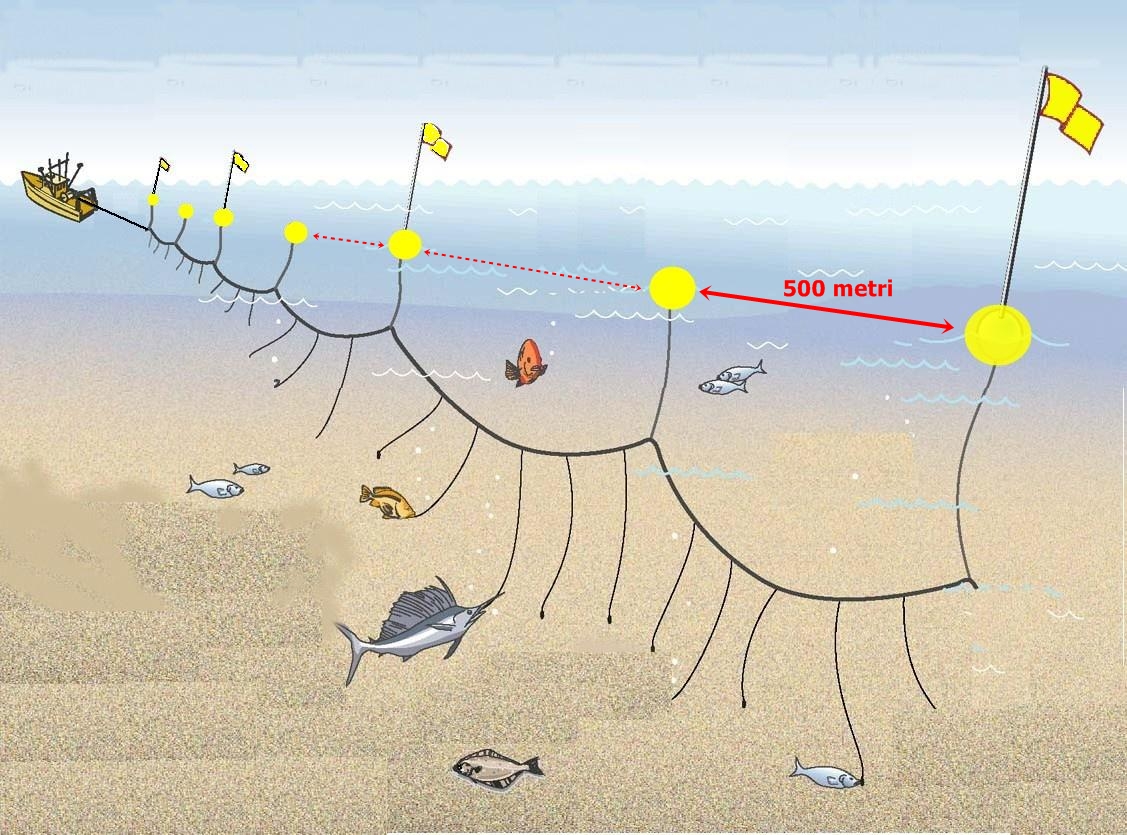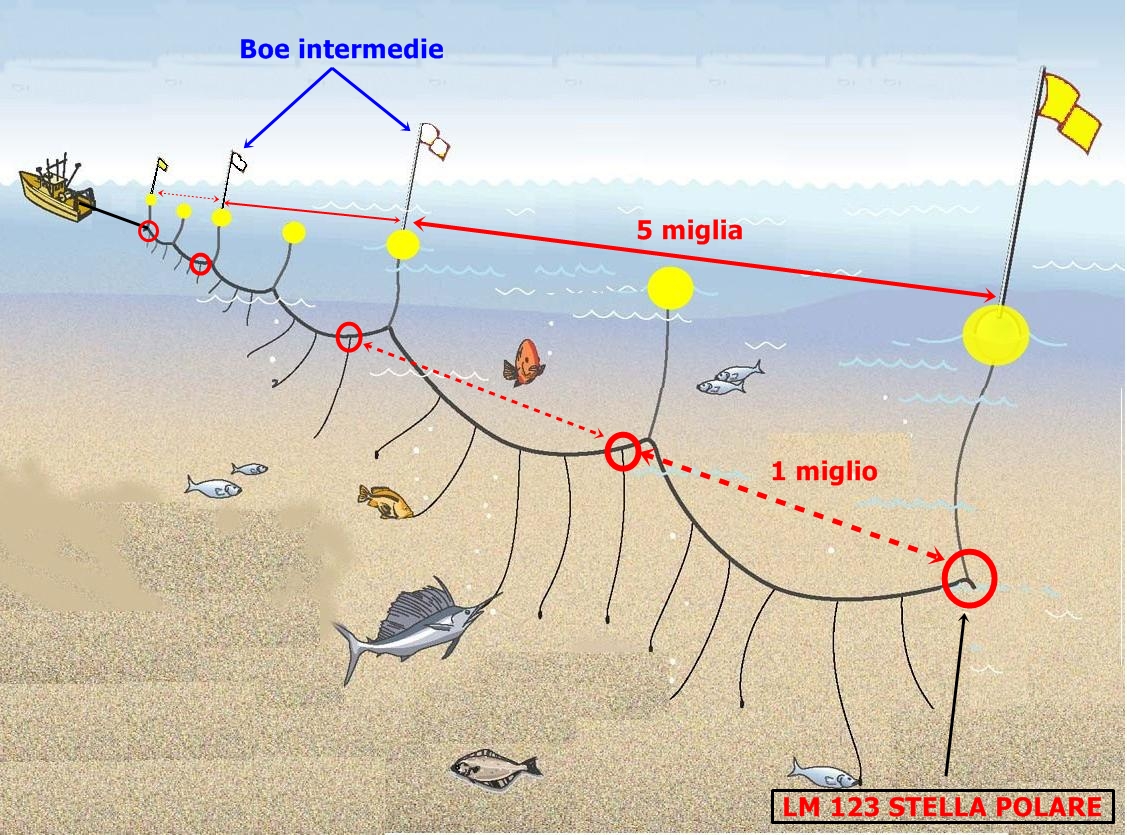Disciplina speciale dei sistemi di pesca
I «sistemi di pesca» normalmente impiegati in Italia sono regolamentati da una fonte legislativa specifica finalizzata, principalmente, alla tutela ambientale ed alla salvaguardia delle risorse ittiche.
L’attività di pesca viene esercitata utilizzando un peschereccio e una particolare attrezzatura che può:
- venire trainata dalla nave, a contatto o a una certa distanza dal fondo marino;
- essere utilizzata per circondare un banco di pesce;
- o, infine, venire posizionata in una zona di mare per un certo tempo e successivamente ritirata assieme al pesce da essa catturato.
- Alcuni sistemi sono "a numero chiuso" e sono disciplinati da apposita normativa:
- la draga idraulica
- la rete a circuizione per i tonni
- la rete da posta derivante
- il rastrello da natante
-
il palangaro per i tonni
Ogni unità da pesca, in relazione al tipo di pesca a cui è autorizzata, può esercitare l’attività in un compartimento (draga idraulica), nel compartimento di iscrizione e nei due ad esso contigui (pesca costiera locale) o in tutti i compartimenti marittimi (costiera ravvicinata).
- I principali metodi di pesca sono raggruppati nello schema che segue:
Sistemi di pesca professionali
(art.11 del D.M. 26.07.1995)
| Sistema a Circuizione: | Cianciolo per pesce azzurro, cianciolo per pesce bianco, Lampara, Tonnara volante, circuizione senza chiusura |
| Sistema Sciabica: | Sciabica da natante (danese), Sciabica da spiaggia |
| Sistema Strascico: | Strascico a divergenti, Strascico a bocca fissa, Traino pelagico a divergenti, Rapido, Sfogliara |
| Sistema Volante: | Traino pelagico a coppia, Agugliara |
| Sistema Traino per Molluschi: | Attrezzo di traino per molluschi, Ostreghero, Rampone per molluschi, Sfogliara per molluschi |
| Sistema Draga Idraulica: | Sostituisce quello denominato turbosoffiante: Vongolara, Cannellara, Fasolara |
| Sistema Rastrello da Natante: | Sostituisce la draga manuale: Draga da natante |
| Sistemi Attrezzi da Posta: | Imbrocco, tremaglio, nasse, cestelli, cogolli, bertovelli, rete circuitante, rete da posta fissa, rete da posta a circuizione |
| Sistemi Reti da Posta derivanti: Sistemi Reti da Posta derivanti: | Spadara, Alalungara |
| Sistema Ferrettara: | Piccola derivante, menaide, sangusara, bisantonara, alacciara, bisara, bogara, sgomberara, occhiatara, e palamitara; |
| Sistena Palangari: | Palangari fissi, Palangari derivatiPalangari fissi, Palangari derivati |
| Sistema Lenze: Sistema Lenze: | Lenze a mano, Lenze a canna, Lenze trainate |
| Sistema Arpione: Sistema Arpione: | Arpione, Fiocina, l’asta e specchio per ricci Rastrello per ricci |
Sistema a circuizione
Le «reti a circuizione» sono quelle reti calate in mare al fine di recingere e catturare, con immediata azione di recupero, un branco di pesci localizzato o aggregato artificialmente. Le reti possono essere calate da una sola unità o da due: nel primo caso l'unità compie un cerchio, nel secondo, le due unità gemelle percorrono un semicerchio ciascuna.
Le reti da circuizione distese in banchina o viste nel loro piano costruttivo si presentano come enormi lenzuoli rettangolari che possono essere formate o no da varie pezze, esse pure rettangolari, diverse per la dimensione di maglia o il titolo del filo con cui le pezze stesse sono costruite. La base superiore viene armata (unita) con una lima (cavo) munita di numerosi galleggianti per tenerla in superficie mentre la base inferiore, armata con una lima munita di piombi (cavo piombato o catena), mantiene la rete distesa nel senso verticale.
Su questa ultima lima sono sistemate, a intervalli regolari, delle bretelle (cavetti) che hanno, alla loro estremità, degli anelli in ferro. Attraverso questi anelli passa un cavo di acciaio grazie al quale si effettua la chiusura meccanica della rete. A fine cala, questo cavo viene recuperato per primo trasformando la rete in un sacco, dal quale il pesce non può più scappare.
- Le reti a circuizione possono essere:
-
“a chiusura”
- “senza chiusura”.
Appartengono alla prima categoria la maggioranza delle reti a circuizione utilizzate per la cattura di specie pelagiche piccole o grandi o specie demersali (cianciolo per acciughe e sarde, cianciolo per tonni, cianciolo per pesce bianco o costiero). Hanno la caratteristica fondamentale di avere la possibilità di essere chiuse in basso tramite un cavo che, passando attraverso grossi anelli di ferro collegati alla lima dei piombi, viene tirato meccanicamente.
Quelle senza chiusura sono presenti dove si opera manualmente la pesca con rete a circuizione, infatti non hanno la possibilità di essere chiuse dal fondo. Il rendimento di pesca in confronto a quelle con chiusura è ridotto. Le prede più frequenti sono rappresentate dal bianchetto, rossetto, ciccerello e pesce bianco in genere. Quest'ultimo tipo di attrezzo oggi è praticamente scomparso.
- In relazione alla loro costruzione ed impiego le reti da circuizione si suddividono in:
- Ciancioli
- Lampare
- Tonnare volanti
Approfondimenti:
Questo tipo di pesca si effettua chiudendo le reti al fondo, mentre il galleggiamento della parte superiore è garantito dalla lima dei galleggianti. La lima dei piombi costituisce la zavorra che permette l’affondamento della rete stessa. Le reti da circuizione possono essere calate in mare da una o da due unità. Nel primo caso il motopesca percorre un cerchio completo per circondare il pesce. Una volta individuato il banco, la rete è calata e fissata ad un natante chiamato “stazza”, che rimane fermo. Il motopesca ha invece il compito di stendere completamente la rete, per poi chiudere il cerchio ricongiungendosi alla stazza. Nel secondo caso due unità simili della stessa potenza percorrono un semicerchio ciascuno
In relazione alla loro costruzione ed impiego, le reti da circuizione si suddividono in due categorie: reti da circuizione abbinate alla attrazione luminosa del pesce che sono usate per la cattura del pesce azzurro (acciughe e sarde) e reti da circuizione per la cattura di pesce di grossa taglia, tonni o più in generale sgombriformi.
Per la cattura di alici e sarde le reti sono chiamate dai pescatori “lampare”, “ciancioli” e “saccoleve”.
Per la cattura dei tonni e sgombri è nota come “tonnara volante”
Questa pesca pelagica è effettuata da unità di media grandezza da 20-120 tsl, con potenza motore superiore i 400 cavalli. Le dimensioni delle maglie variano lungo la rete: le maglie più piccole stanno al centro dove si forma il sacco.
Le reti a circuizione per la cattura del pesce azzurro sono abbinate da lungo tempo all’uso della luce quale artificio per agevolare la concentrazione del pesce. Tale pesca, detta a lampara, viene effettuata ovviamente solo di notte e in assenza di luna piena affinché la luce artificiale abbia un effetto maggiore su questi pesci che, in queste ore, si avvicinano alla superficie. In passato, queste lampade funzionavano a gas o a petrolio ma attualmente sono elettriche e vengono alimentate da un generatore montato direttamente sulle barche.
Cianciolo
Si chiama «cianciolo» la rete da circuizione a chiusura meccanica. I ciancioli per i piccoli pelagici sono confezionati con maglie colorate, generalmente marrone scuro, di piccole dimensioni (apertura non inferiore ai 14 mm) e filato piuttosto sottile; i galleggianti sono numerosi e di piccole dimensioni, la lima dei piombi è munita di bretelle ed anelli di ferro.
Le unità che effettuano questo tipo di pesca hanno la poppa libera da sovrastrutture e il verricello principale posto in parallelo con la chiglia.
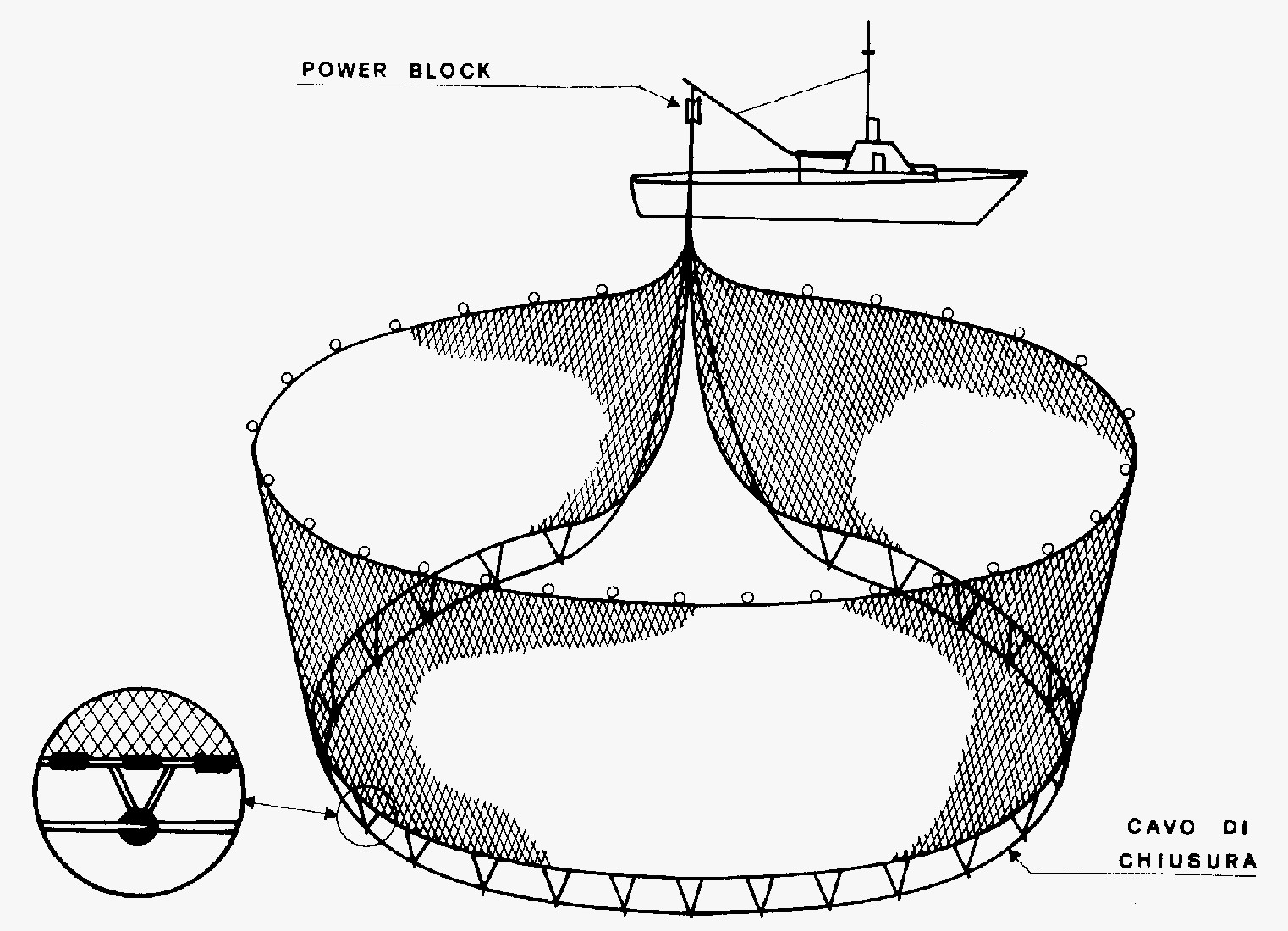
Circuizione a chiusura meccanizzata (Cianciolo)
Si presenta come un enorme rete rettangolare di dimensioni non inferiori agli 800 metri di lunghezza e 120 metri di altezza (tranne per le tonnare volanti) E' una rete a circuizione che viene impiegata per la pesca di pesci pelagici, per la cattura del pesce azzurro, principalmente acciughe, sardine e sgombri. Nella pesca con il cianciolo vengono impiegate spesso delle fonti luminose che servono ad attirare il pesce sotto le unità da pesca.
Questo tipo di pesca viene fatto essenzialmente in Tirreno, Adriatico e dai motopescherecci siciliani.
Dato che in Italia questa pesca si effettua solo di notte, è possibile vedere, a bordo della barca grande, dei battellini più piccoli con le luci per la concentrazione artificiale dei pesci.
La luce gioca un ruolo molto importante nella attrazione dei piccoli pelagici, poiché l'aggregazione "a banco" è una forma di difesa visiva contro i predatori Una volta che la barca ha raggiunto il luogo di pesca, di solito a notte inoltrata, si calano in mare due o tre battellini, ad una certa distanza l'uno dall'altro.
Sui battellini vengono accese le luci per aggregare il pesce, e quando questo si è accumulato in quantità sufficiente, i marinai a guardia delle luci, remando l'un verso l'altro, riuniscono i battellini in un unico punto.
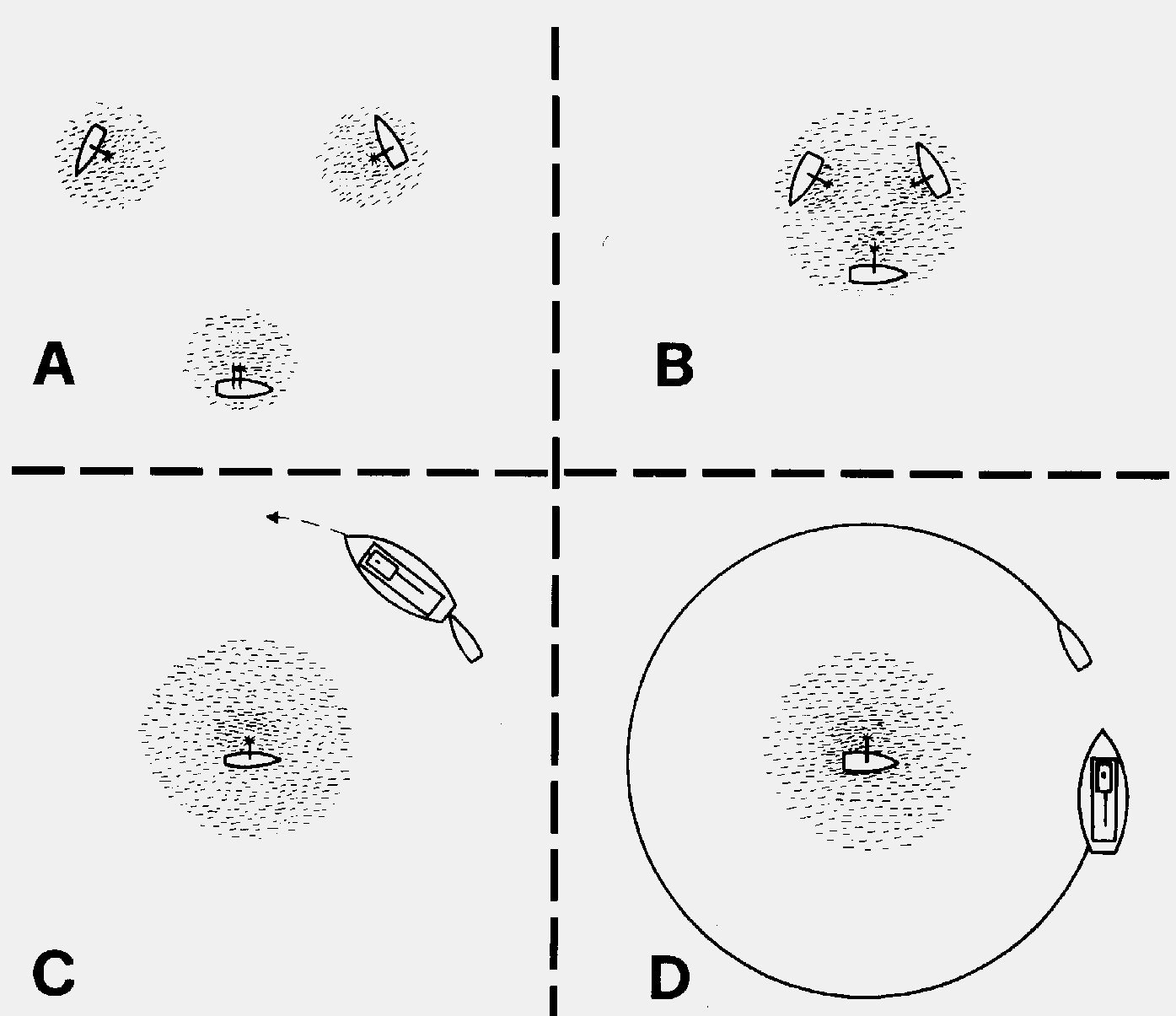
Nella figura vengono schematizzate le fasi della pesca
a circuizione
Successivamente si lasciano accese le luci di un solo battellino, per mantenere il pesce in aggregazione, mentre un altro si porta ad una distanza da esso pari al raggio del cerchio che il Comandante deve effettuare per circondare il pesce aggregato. Il Comandante dirige la barca su quest'ultimo battellino, gli consegna un capo della rete, detto "stazza", e cala la rete in mare, in cerchio. Alla fine della cala si ritroverà nuovamente sul punto di partenza e riprenderà la "stazza" del battellino, iniziando la chiusura del cianciolo. A questo punto il battellino che si trova al centro del cerchio con il pesce aggregato, spegnerà le luci e remando si dirigerà all'esterno della rete. Il pesce catturato verrà portato a bordo con grosse volighe o ittiopompe, e stivato in recipienti pieni di acqua ghiacciata (baie) prima di essere cernito e incassettato.
-
Cianciolo (peculiarità):
-
Rete a circuizione a chiusura meccanica formata da enormi pannelli rettangolari (lunghezza ≤ 800 metri e altezza ≤ 120) dotati di lima da sugheri e lima da piombi munita di bretelle ed anelli di ferro.
-
caratteristica principale: prevalenza dei galleggianti sui piombi: la lima dei sugheri rimane sempre in superficie.
-
le dimensioni delle maglie, di colore marrone scuro, variano lungo la rete (≥14 mm.): le maglie più piccole stanno al centro dove si forma il sacco
-
opera su banchi di pesce formati artificialmente, mediante attrazione luminosa.
-
specie bersaglio: pesci pelagici, pesce azzurro (principalmente acciughe, sardine e sgombri).
Lampara
Sono chiamate «lampare» le reti da circuizione la cui chiusura non è meccanica, ma a rovesciamento, cioè la raccolta del pesce si ottiene issando a bordo la lima dei piombi, in modo da portare la parte centrale del panno rettangolare, che subisce un rovesciamento, nella posizione opposta alla superficie del mare.
La rete, come confezione, non si discosta molto dal cianciolo, ma a differenza di questo non ha le bretelle con gli anelli.
Le catture non sono paragonabili in termini di rendimento con le reti a circuizione a chiusura meccanizzata (cianciolo) in quanto le reti sono molto più piccole.
Questo sistema di pesca, molto in voga negli anni '50 e '60, oggi è pressoché in disuso e trova qualche applicazione con unità di dimensioni ridotte.
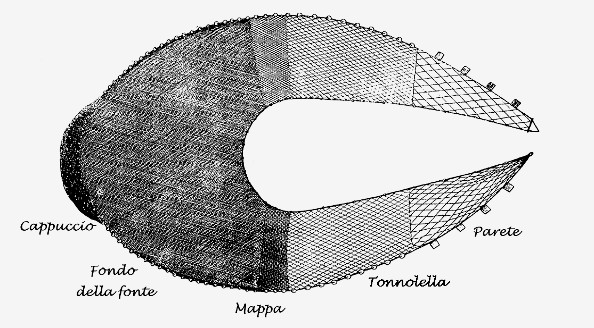
-
Lampara (peculiarità):
-
Rete a circuizione senza chiusura (a rovesciamento) formata da pannelli rettangolari (lunghezza ≤ 800 metri e altezza ≤ 120) dotati di lima da sugheri e lima da piombi senza bretelle ed anelli di ferro.
-
caratteristica principale: prevalenza dei galleggianti sui piombi: la lima dei sugheri rimane sempre in superficie.
-
le dimensioni delle maglie, di colore marrone scuro, variano lungo la rete (≥14 mm.): le maglie più piccole stanno al centro dove si forma il sacco
-
specie bersaglio: pesci pelagici, pesce azzurro (principalmente acciughe, sardine e sgombri).
Tonnara volante
La «tonnara volante» si identifica con i ciancioli adibiti alla cattura dei grossi pelagici, tonni e affini. Sia le reti che le unità sono facilmente riconoscibili per le dimensioni più grandi rispetto a quelle normalmente usate per i Ciancioli, per la cattura di sardine e acciughe: questo tipo di pesca può utilizzare motopescherecci di grosse dimensioni se lavorano singolarmente, oppure di dimensioni medie quando lavorano in coppia. Presenza sul motopesca del “power block” (bozzello salparete).
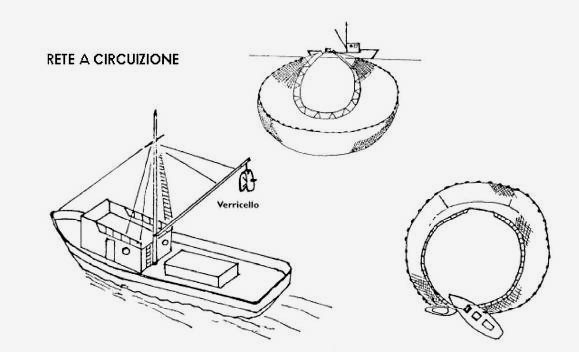
Power bloc” (bozzello salparete)
La rete può raggiungere i 2000 m di lunghezza e 400 m di altezza e ha maglie di 70-120 mm di lato. Lo spessore del filato è di circa 4 mm e generalmente di colore nero.
I galleggianti sono molto più grandi ed il volume complessivo di tutta la rete, generalmente copre tutta la coperta di bordo, con un peso che, mediamente, non supera le 50 t.
Il mestiere della circuizione permette la cattura di banchi di pesce molto numerosi; il metodo di pesca comporta che la rete sia calata in modo da circondare completamente il pesce in mare ed impedirne, di fatto, la fuga.
Le reti sono formate da varie pezze di forma rettangolare che presentano maglie e filo di dimensioni diverse.
La pesca si effettua chiudendo le reti al fondo, mentre il galleggiamento della parte superiore è al solito garantito dalla lima dei galleggianti. La parte sommersa della rete presenta un cavo di chiusura presso la lima dei piombi, che costituisce, appunto la zavorra che permette l’affondamento della rete stessa. La chiusura del cavo fa assumere alla rete la forma di un sacco in cui il pesce resta imprigionato. Le reti a circuizione possono essere calate in mare da una o due barche.
L'individuazione dei tonni viene fatta a vista grazie al "coffista" (il marinaio che sta di vedetta sulla coffa), ma anche grazie agli aeroplani che guidano i motopesca (l'utilizzo dell'aeroplano è consentito solo in alcuni mesi dell'anno).
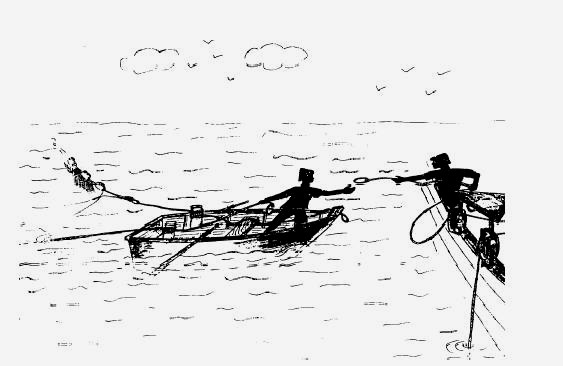
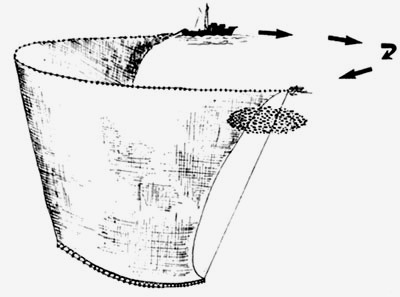
Tonnara volante
(Rete in fase di accerchiamento)
Nel primo caso l’unità percorre un cerchio completo per circondare il banco di pesce. Una volta individuato il banco, la rete è calata e fissata ad un natante chiamato «stazza», che rimane fermo. Il motopesca ha invece il compito di stendere completamente la rete, superando i tonni in velocità, per poi chiudere il cerchio ricongiungendosi alla "stazza".
Nel secondo caso, le due barche percorrono un semicerchio ciascuno. Questa pesca è effettuata da imbarcazioni superiori le 200 tsl.
-
Tonnara volante (peculiarità):
- reti a circuizione per tonni e sgombriformi
- la rete, di grande dimensione (lunghezza fino a 2000 metri ed altezza anche di 400 metri), è formata di varie pezze rettangolari con maglie di colore nero, di dimensioni 70 - 120 mm. di lato
- i galleggianti sono molto più grandi ed il volume della rete copre tutta la coperta di bordo, con un peso che, mediamente, non supera le 50 t.
- questo tipo di pesca può utilizzare motopescherecci di grosse dimensioni se lavorano singolarmente, oppure di dimensioni medie quando lavorano in coppia.
- la parte sommersa della rete presenta un cavo di chiusura presso la lima dei piombi, che costituisce la zavorra che permette l’affondamento della rete stessa. La chiusura del cavo fa assumere alla rete la forma di un sacco
Disciplina della pesca con reti a circuizione
- D.P.R. 1639/68:
E’ vietato l’uso di ciancioli (reti a circuizione a chiusura meccanizzata) entro una distanza di 3 miglia dalla costa o all’interno dell’isobata di 50 m (quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa).
E’ vietato l’uso di fonti luminose ad una distanza dalla costa inferiore ai 300 metri e nelle zone di mare entro le 3 miglia in cui la profondità sia inferiore ai 30 metri. Il Capo del compartimento, al fine della tutela delle risorse biologiche del mare, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, può stabilire ogni altra disposizione circa la località di esercizio, i periodi di tempo e i tipi degli strumenti pescherecci per la pesca con fonti luminose nelle acque del compartimento.
La tonnara volante può raggiungere 2000 metri di lunghezza e 400 di altezza.
- Reg. (CE) 1967/06:
E’ comunque vietato l’uso di ciancioli ad una profondità inferiore al 70% dell’altezza totale dei ciancioli stessi.
E’ vietata la pesca con ciancioli sulle praterie di Posidonia (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine. In deroga l’uso di ciancioli la cui altezza totale e il cui comportamento nelle operazioni di pesca implicano che il cavo di chiusura, la lima da piombo o le corde da salpamaneto non tocchino le praterie può essere autorizzato nel quadro dei piani di gestione. L’apertura della Maglia della circuizione è fissata in 14 mm.
E’ consentito l’impiego di tutti i tipi di rete da circuizione per piccoli pelagici (ciancioli, lampare) di Lunghezza non superiore agli 800 metri e di Altezza non superiore a 120 metri (tranne per le tonnare volanti).
- Reg. (CE) 1559/07:
E’ vietata la pesca del tonno rosso dal 01/07 al 31/12
E’ vietato l’uso di aeromobili per la ricerca del tonno rosso

Sistema a sciabica
La «Sciabica» è un antichissimo tipo di rete da pesca usato in passato in tutte le marinerie. E' utilizzata in modo completamente manuale da un elevato numero di persone (una dozzina) o tramite verricello a unità ferma e ancorata.
Sono reti molto simili alle reti a circuizione con chiusura manuale. Generalmente vengono calate a bassa profondità e catturano gli organismi marini durante la fase di recupero. La sciabica può considerarsi un attrezzo “ibrido” in quanto viene calata a semicerchio (come una circuizione) e recuperata a traino.
La sciabica è formata da varie pezze di rete di forma e dimensioni di maglie diverse. L’apertura verticale di bocca è assicurata dai galleggianti sulla lima dei sugheri e dai piombi sulla lima dei piombi: mentre l’apertura orizzontale è ottenuta con il particolare metodo di calo e di tiro.
La lima da piombi sta sempre in contatto con il fondo, per questo motivo segue la stessa normativa della rete a strascico.
Le dimensioni delle maglie variano lungo la rete: le più piccole sono al centro dove si forma il sacco. Le maglie sono grandi sulle braccia da cui si dipartono due lunghi cavi detti “calamenti” o “reste” (anche centinaia di metri) che servono per spaventare e aggregare il pesce verso la parte centrale della rete, e trainare la rete. Caratteristica principale dell’attrezzo: prevalenza dei piombi sui galleggianti (non si vedono i galleggianti in superficie); braccia molto lunghe (5-6 volte il corpo) e sacco molto corto (da essere un tutt’uno con il corpo della rete) Le sciabiche somigliano molto alle reti a strascico, ma si differenziano sostanzialmente da queste ultime per la lunghezza dei bracci, tant'è che in realtà il corpo si identifica con il sacco di raccolta.
- In relazione al loro impiego le sciabiche si suddividono in:
-
sciabiche da natante (danese)
- sciabiche da spiaggia
- In base alle specie bersaglio si distinguono in:
-
sciabica per bianchetto (novellame di sardina,sardina pilchardus);
-
sciabica per rossetto (aphia minuta);
-
sciabiche per novellame da semina;
-
sciabiche per pesce vario.
- Sciabiche (peculiarità):
-
questi attrezzi sono formati da varie pezze di rete di forma e dimensioni di maglie diverse, molto simili alle reti a circuizione.
-
caratteristica principale dell’attrezzo: prevalenza dei piombi sui galleggianti (non si vedono i galleggianti in superficie); la lima da piombi tocca il fondo, per questo motivo segue la normativa delle reti a strascico.
-
le dimensioni delle maglie variano lungo la rete: le più piccole sono al centro dove si forma il sacco. Le maglie sono grandi sulle braccia da cui si dipartono due lunghi cavi detti “calamenti” o “reste” che servono per aggregare il pesce e trainare la rete.
Sciabica da spiaggia
E’ il tipo più diffuso in Italia anche se in alcune località è rimasta solo come tradizione. Viene utilizzata nella pesca del novellame destinato all'allevamento (cefali, spigole, orate, ecc.) ed al consumo diretto: bianchetto (clupeiformi) e rossetto (Aphia minuta).
La rete viene calata a semicerchio utilizzando una unità a remi di piccole dimensioni. Un capo del "calamento" (cavo di collegamento tra i bracci della rete ed un punto del traino) viene lasciato sulla spiaggia mentre con la piccola unità, si cala in mare la rete a semicerchio attorno a pesce, e quindi si ritorna sulla riva portando con sè il capo dell'altro calamento.
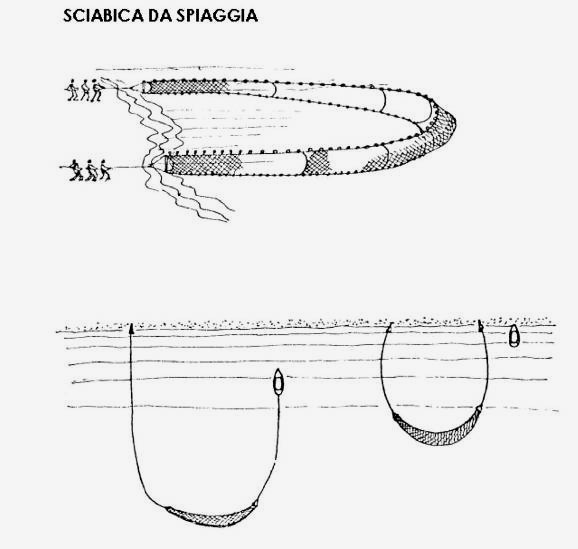
La figura descrive le varie fasi della cala e recupero della rete:
I calamenti tirati dalle due squadre convergono sulla spiaggia
Sulla spiaggia si formano “due squadre” di pescatori che, camminando a ritroso e in modo convergente tirano i due calamenti in modo che, quando la rete è nuovamente sulla spiaggia, risulti chiusa.
- Sciabica da spaggia (peculiarità):
-
questi attrezzi sono formati da varie pezze di rete di forma e dimensioni di maglie diverse, molto simili alle reti a circuizione.
-
caratteristica principale dell’attrezzo: prevalenza dei piombi sui galleggianti (non si vedono i galleggianti in superficie); la lima da piombi tocca il fondo, per questo motivo segue la normativa delle reti a strascico.
-
le dimensioni delle maglie variano lungo la rete: le più piccole sono al centro dove si forma il sacco. Le maglie sono grandi sulle braccia da cui si dipartono due lunghi cavi detti “calamenti” o “reste” che servono per aggregare il pesce e trainare la rete.
-
in alcune località è rimasta solo come tradizione
-
il tiro dalla spiaggia necessita di molte persone
-
i calamenti hanno lo scopo di spaventare il pesce e incanalarlo verso la parte centrale della rete
Sciabica da natante
La «sciabica da natante» ha origini danesi e risale a oltre un secolo fa. E’ poco diffusa in Italia e la si usa generalmente su quei fondali dove lo strascico, causa le asperità varie, è possibile solo per tratti brevi. Le maglie devono avere 40 mm di apertura. Deroghe possono essere concesse per la cattura di novellame
Dalla barca si getta in mare una “boa” con il capo di un calamento e si inizia a calare in mare la rete a semicerchio. Alla fine della cala si ritorna sulla “boa”. Tale operazione in origine del tutto manuale, oggi si avvale dell'aiuto di verricelli.
Questa fase assomiglia molto al sistema di pesca con lo strascico.
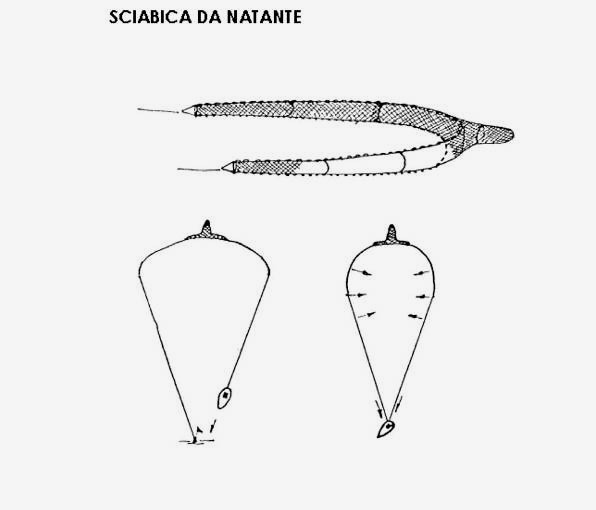
La figura descrive le fasi di pesca con questo sistema
Con la sciabica si pescano soprattutto latterini, triglie, sogliole, cefali, orate, rossetto e bianchetto ed alcuni cefalopodi, come polpi e seppie.
- Sciabica da spaggia (peculiarità):
- questi attrezzi sono formati da varie pezze di rete di forma e dimensioni di maglie diverse, molto simili alle reti a circuizione.
- caratteristica principale dell’attrezzo: prevalenza dei piombi sui galleggianti (non si vedono i galleggianti in superficie); la lima da piombi tocca il fondo, per questo motivo segue la normativa delle reti a strascico.
- le dimensioni delle maglie variano lungo la rete: le più piccole sono al centro dove si forma il sacco. Le maglie sono grandi sulle braccia da cui si dipartono due lunghi cavi detti “calamenti” o “reste” che servono per aggregare il pesce e trainare la rete.
- in alcune località è rimasta solo come tradizione.
- il tiro dalla spiaggia necessita di molte persone.
-
i calamenti hanno .,o scopo di spaventare il pesce e incanalarlo verso la parte centrale della rete.
Disciplina della pesca con sciabiche
- Reg. (CE) 1967/06:
Dal 1° luglio 2008, la sciabica è costituita da una pezza di rete a maglia quadrata da 40 mm. nel sacco o, su richiesta motivata da parte del proprietario del peschereccio, da una rete a maglia romboidale da 50 mm.
E’ vietato l’uso delle sciabiche entro le 3 miglia nautiche dalla costa o entro i 50 metri di profondità, se tale profondità è raggiunta a distanze inferiori ad eccezione delle deroghe concesse dal Regolamento.
- D.M. 28/12/81 e D.M. 07/08/96:
E’ consentito l’uso della sciabica per la cattura di “novellame da allevamento” purché tale pesca sia effettuata senza motore (recupero manuale).
La Lunghezza della lima da sugheri della sciabica deve essere inferiore ai 40 metri.
L’apertura della maglia deve essere uguale o superiore a 1 mm. (fino al 31/5/2010, ai sensi dell’art. 14 Reg. CE 1967/06).
- D.M. 28/08/96:
E’ consentito l’impiego di tutti i tipi di sciabica per la pesca del rossetto e del bianchetto.
E’ consentito l’uso di sciabiche, senza limiti di distanza dalla costa, con unità da pesca di stazza lorda non superiore a 10 t. e potenza apparato motore non superiore a 100 HP.
L’apertura della maglia dell’attrezzo deve essere uguale o superiore ai 5 mm. (fino al 31/5/2010 Reg. CE 1967/08):
E’ vietato in tale pesca l’uso di catene o denti.
Tale pesca è consentita dalle ore 04 alle 18 di ogni giorno.
-
D.M. 30/11/99:
Pesca di rossetto in Toscana: dimensioni delle unità – TSL ≤ 10, HP ≤ 150.
Apertura della maglia: ≥ 3 mm. (fino al 31/5/2010 art. 14 Reg. CE 1967/06)
- D.M. Annuali:
Pesca di rossetto e bianchetto: fino al 31/5/2010. I DM indicheranno annualmente le modalità, i tempi e le unità autorizzate.
E’ vietato l’uso delle sciabiche su prateria di Posidonia

Sistema a traino
Rientra in questo sistema, qualsiasi attrezzo da pesca, ad eccezione delle lenze trainate, trainato dalla forza motrice del peschereccio o tirato per mezzo di vericelli con il peschereccio all’ancora o in movimento a bassa velocità, incluse in particolare le reti trainate e le draghe
In particolare, fra questi attrezzi, le reti da traino oggi sono gli attrezzi più usati nel mondo a livello di pesca industriale. Questa predominanza è dovuta alla introduzione sui pescherecci, in quest'ultimo mezzo secolo, di motori sempre più potenti.
Le reti a traino sono “reti attive”, reti cioè che sono portate incontro al pesce che viene catturato per il loro progressivo avanzamento. Sono formate da molte pezze di rete diverse come dimensione del filo e dimensione di maglia. Le pezze di rete che compongono le rete da traino sono cucite tra loro in modo da formare durante il traino un tronco di cono o un tronco di piramide (corpo della rete).
Sulla parte terminale della rete, sul sacco, vi è un sistema di chiusura formato da una cimetta che permette facilmente di riaprire il sacco quando la saccata è issata a bordo.
Sulla base maggiore sono montate le braccia e le lime, o la struttura rigida nel caso di reti a bocca fissa.
- Tutte le reti al traino hanno in comune alcuni particolari come:
- i bracci,
- il corpo conico,
- il sacco di raccolta cilindrico,
- le pezze di rete trapezoidali,
- le lime d'ornamento dei galleggianti,
- i piombi o le catene.
Le reti al traino si differenziano fra loro perché, sia il sistema di confezione che l'attrezzatura variano in base alle specie che si vogliono catturare.
- Possiamo fare una prima distinzione fra:
- reti trainate sul fondo (sistema strascico)
- reti trainate a mezz’acqua (sistema volante)
► Le “reti trainate sul fondo” (o a strascico), vengono trainate facendole strisciare sul fondo marino con lo scopo di catturare le specie bentoniche, che sono tra quelle più pregiate dal punto di vista commerciale. Sono attrezzi attivi, perché trainati da pescherecci (un’unica unità per rete) ad una velocità tale da mantenerne aperta l’imboccatura. La tipica rete a strascico è la “tartana”. Ha forma conica ed è distinta in tre parti, i bracci, il corpo e il sacco, in cui si accumula il pesce.
- Le reti a «strascico» si suddividono in:
-
reti a strascico propriamente dette
-
reti a grande apertura verticale (relingate o francesi)
- reti a bocca fissa (rapidi centro-Nord adriatico)
► Le “reti trainate a mezz’acqua” (pelagiche o semipelagiche) vengono impiegate per la cattura delle specie pelagiche, come le acciughe, le sardine, e gli sgombri. La più comune è la “volante“, la quale viene trainata a mezz’acqua da due pescherecci (le volanti) dalle caratteristiche simili e viene utilizzata per la cattura del pesce azzurro. Regolando la lunghezza dei cavi di traino della rete è possibile variare la profondità alla quale si pesca.
-
Le reti «trainate a mezz’acqua» si suddividono in:
-
a coppia (con due unità);
-
monobarca (con una unità);,
- agugliara (praticamente scomparsa).
(2).png)
Sistema a strascico (D.M. 26/7/1995)
Lo «Strascico» è la pesca più praticata in Italia e nel Mondo per la cattura del pesce di fondo, quello più pregiato e più richiesto (triglie, naselli, cernie, pagelli, saraghi, sogliole, rane pescatrici, razze, palombi, scampi, gamberi rossi, aragoste, pannocchie, moscardini, seppie e calamari).
Vi sono molti tipi di rete, praticamente uno per ogni paese in cui vi è una fiorente pesca. In Italia la rete a strascico più nota ed usata è la rete mediterranea o rete italiana (tartana).
(1).png)
Schema Sistema italiano (Tartana)
Le reti a strascico sono costituite da molte pezze di rete, con filo di diverse dimensioni e maglie di varia apertura. I pescatori italiani preferiscono operare con una unità; in questo caso, la bocca della rete viene tenuta aperta in senso orizzontale da due "divergenti", strutture in legno o in metallo che, grazie all'azione dell'acqua, tengono bene aperta la bocca della rete in senso orizzontale.
La rete è collegata all’unità per mezzo di "cavi d’acciaio" e "calamenti" fissati a loro volta a due "mazzette" (estremità della rete). Il sacco è tenuto aperto verso l’alto dalla lima dei sugheri e poggia sul fondo con la "lima dei piombi", a volte zavorrata con catene.
La rete può essere trainata da una o due unità. Il traino a coppia alla fine della II guerra mondiale è stato abbandonato poiché la propulsione meccanica consentiva ai divergenti di sviluppare dalle forze idrodinamiche tali da provocare l’apertura della bocca della rete.
La rete a strascico presenta diverse lunghezze nelle lime. Quella dei piombi è più lunga di quella dei sugheri per evitare che, quando questa muove il pesce dal fondo, esso non sfugga verso l’alto. Molto utilizzata nell’Adriatico per la pesca dei merluzzi, triglie, sogliole, scampi, gamberi, pannocchie, rospi, seppie e calamari. Esiste anche lo strascico a coppia. La pesca a strascico può essere effettuata con diversi tipi di attrezzi che, tra l'altro, variano in relazione alle tradizioni e al bagaglio culturale locale e regionale.
- Comprende:
-
strascico a divergenti
- traino pelagico a divergenti
-
strascico a bocca fissa
-
rapido
- sfogliara
Strascico a divergenti
Questo sistema di pesca è il più diffuso in Italia e le unità che lo usano sono facilmente riconoscibili perché a bordo hanno una serie di strutture ed apparecchiature proprie dello strascico, come il “verricello dei cavi d'acciaio”, “l'arco di potenza” e i “divergenti”.
.png)
Rete in assetto di pesca
Sezione, da sinistra: cavo di traino, divergente, braga, calamento, restone, catena, mazzetta, braccia
Nel Mediterraneo lo strascico a divergenti viene effettuato principalmente con due sistemi diversi:
-
Sistema italiano (Tartana);
- Sistema francese (Vigneron).
I due sistemi sono abbastanza diversi, in particolare per quanto attiene la confezione della rete e l'attrezzatura per il traino.
I “divergenti” sono componenti essenziali del traino perché assicurano l'apertura orizzontale di tutta l'attrezzatura.
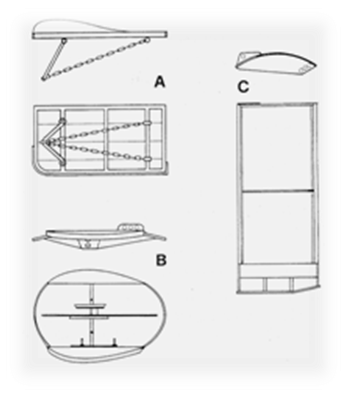
Vari tipi di divergenti visti dall'alto e di lato:
A - Rettangolare piatto.
B - Ovale in ferro, tipo polivalente.
C - Pelagico in ferro, tipo Süberkrüb.
- Questi due sistemi hanno delle peculiarità intrinseche:
- nella rete “italiana” l'imbando del pannello inferiore garantisce un ottimo contatto con il fondo, ma contemporaneamente ne limita l'apertura verticale (1-1,5 metri);
- viceversa la rete “francese” ha uno scarso contatto con il fondo, ma un'apertura verticale maggiore (3-4 metri) ed in funzione di ciò anche l'attrezzatura del traino è diversa.
-
inoltre, la rete italiana, generalmente, è senza nodo, mentre quella francese è con nodo.
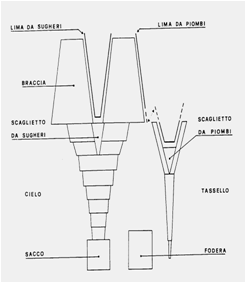
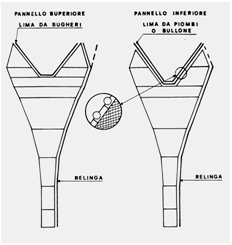
Schema dello strascico: sistemi italiano (Taratana) e francese (Vigneron) a confronto
-
La rete italiana è asimmetrica; la parte superiore (cielo) è molto più grande della parte inferiore (tassello), che è anche più lunga del 15 - 20% (imbando).
- La rete francese, invece è simmetrica, e i due pannelli, superiore e inferiore hanno la stessa lunghezza.
In Italia, la quasi totalità delle marinerie usa la “Tartana”, perché le specie pregiate da catturare (specie bersaglio) sono demersali o bentoniche, e quindi non è necessaria una grande apertura verticale della rete. Inoltre, più acqua entra nel corpo della rete, maggiore è la resistenza che si riscontra nel traino e spesso ciò non significa una cattura maggiore, ma può tradursi in un aumento dei costi di gestione per unità di prodotto catturato.
Tartana
La rete italiana a strascico con divergenti è caratterizzata da alcune parti costitutive:
-
bracci
-
bocca
-
corpo
- sacco di raccolta
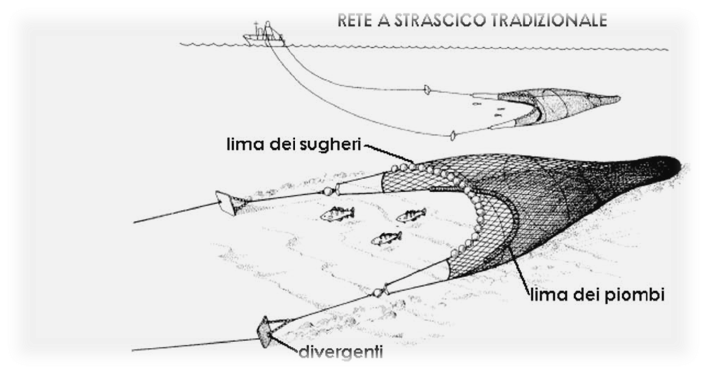
Schema Tartana
La rete è assimmetrica. Ha le maglie “senza nodo”. Costruttivamente la rete è formata da una parte superiore, detta “cielo”, e da una inferiore detta “tassello” che strascica sul fondo: tra cielo e tassello c’è una differenza di lunghezza (15-20%), imbando, che contribuisce a garantire il contatto tra rete e fondo.
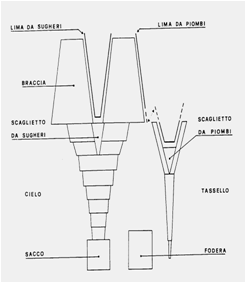
Schema di base della rete
-
Tartana (peculiarità):
-
braccia lunghe circa quanto il resto della rete escluso il sacco;
- la rete ha maglie senza nodo. La dimensione delle maglie decresce progressivamente dai bracci (100 mm.) e infine al sacco (40 mm.);
- è una rete assimetrica: il tassello (parte inferiore) è più lungo e più stretto del cielo (parte superiore = Imbando), può avere maglie con nodo ed il traino si esercita maggiormente sulla lima da sugheri lasciando libera la lima da piombi di aderire meglio al fondo. La trazione sulla parte superiore condiziona fortemente l’apertura verticale (da 0,8 a 1, 5 m) e l’apertura delle maglie del corpo;
- velocita’ di pesca 3 - 4 nodi;
- cattura specie demersali, o che vivono a contatto con il fondale marino;
- caratteristica principale: presenza di divergenti che ne assicurano l’apertura orizzontale
- range di operatività fino a 700 metri.
Vigneron
La rete francese (Vigneron), è simmetrica e i due pannelli, superiore e inferiore hanno la stessa lunghezza. La rete - a differenza della tartana - ha uno scarso contatto con il fondo, ma un'apertura verticale maggiore (3-4 metri) ed in funzione di ciò anche l'attrezzatura del traino è diversa. Inoltre, la rete francese, generalmente, è senza nodo, mentre quella italiana è con nodo.
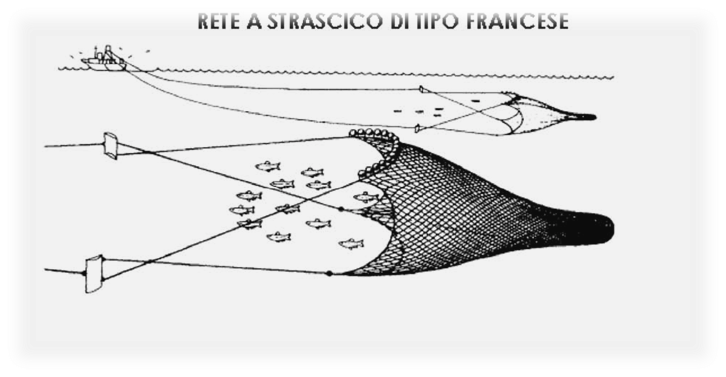
Schema Vigneron
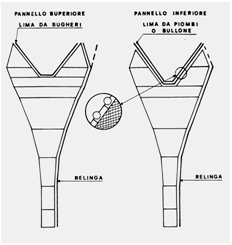
Schema di base di una rete francese
- Vigneron (peculiarità):
-
la rete ha maglie con nodo. Manca l’imbando del pannello inefriore;
-
scarso contatto con il fondo;
-
simmetria tra la parte inferiore e superiore.
-
apertura verticale maggiore (3-4 m.) dovuta alla presenza di 4 cavi che dai divergenti raggiungono la rete.;
-
range di operatività ottimale fino a 200 m
-
cattura prevalentemente specie bento-nectoniche, ma per la maggiore resistenza al traino (entra più acqua nel corpo della rete) può avere costi di gestione più elevati.
Traino pelagico a divergenti
La rete è la stessa che normalmente viene utilizzata per il traino pelagico a coppia, la differenza è solo nell'impiego dei divergenti. A differenza della rete a strascico, la rete pelagica è simmetrica ed ha quattro pannelli, uguali a due a due (sopra-sotto e laterali). La rete inoltre è facilmente riconoscibile per la grandezza delle maglie dei bracci (600-800 mm di apertura), per le ridotte dimensioni delle maglie del sacco (20 mm di apertura) e per la lunghezza complessiva (tripla rispetto alla Tartana).
Le reti non vengono a contatto con il fondo; nelle singole unità l’apertura orizzontale della rete è assicurata da “divergenti” (volante monobarca) mentre nella coppia l’apertura è assicurata dalla “distanza” delle due unità.
Nelle reti le maglie possono avere apertura ≥ 20 mm, purché il 80% delle catture, a cernita avvenuta, sia di sardine e acciughe [R. (CE) 1967/06]
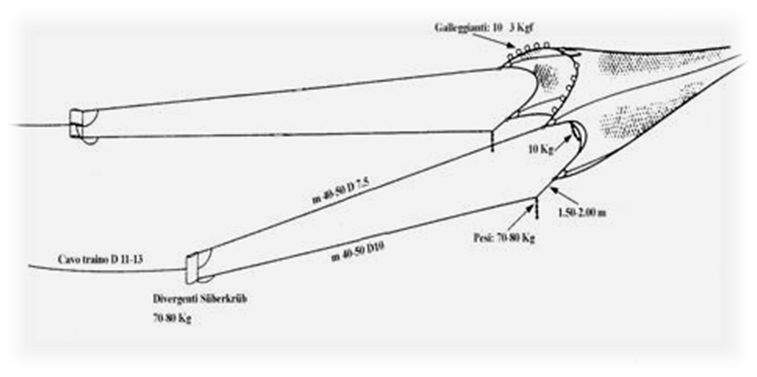
Schema del traino pelagico a divergenti: volante monobarca
[da sinistra] Cavo traino D 11-13 ; Divergenti Süberkrüb 70-80 Kg ; [in alto] m 40-50 D 7,5 ;
[in basso] m 40-50 D 10 ; [a destra, dall'alto] Galleggianti: 10 3 Kgf ; 10 Kg ; peso 70-80 Kg ; 1,50-2,00m.
Un' altra caratteristica peculiare di questa rete è riscontrabile nei "pannelli" che sono confezionati con tortiglia (rete con nodo) e non con catenella (rete senza nodo) come per le altre reti a strascico di tipo italiano. Il traino pelagico a divergenti chiamato anche "volante monobarca". L'apertura orizzontale della rete è assicurata dalla spinta dei divergenti "Süberkrüb", mentre l'apertura verticale è dovuta all'effetto combinato dei pesi, verso il basso, e della posizione del cavo superiore di traino, verso l'alto.
Questo sistema di pesca essenzialmente è rivolto alla cattura dei piccoli pelagici (alici, sardine, sgombri, suri, ecc). Questa rete, che teoricamente dovrebbe pescare nel dominio pelagico (mezz'acqua) in realtà viene usata anche con la lima dei piombi in contatto col fondo.
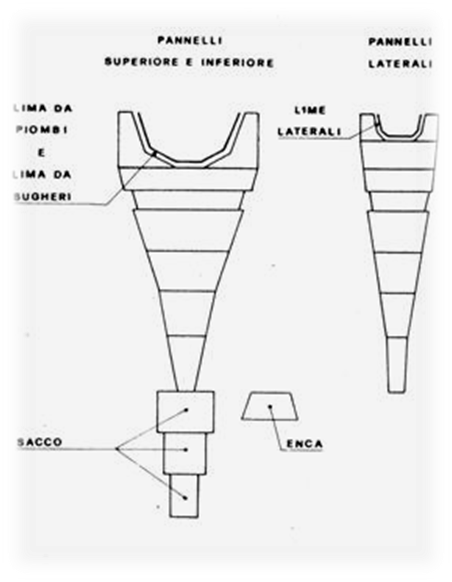
Schema di base di una rete pelagica
La pesca pelagica a divergenti è nota da anni in altri paesi sopratutto per unità da pesca con potenze elevate.
La pesca pelagica a divergenti può essere effettuata solo con particolari strumenti di bordo quasi sconosciuti in Italia (net sonde ad esempio) e con divergenti pelagici o polivalenti il cui funzionamento, più delicato di quello dei divergenti da fondo, necessita di una esperienza che non è ancora entrata come bagaglio normale nelle nostre marinerie.
Strascico a bocca fissa
Tale sistema di pesca, rivolto essenzialmente alle specie bentoniche ed usato in particolare per la pesca delle sogliole, si vale di attrezzi composti da una rete montata su una intelaiatura rigida che ne assicura l'apertura orizzontale e verticale.
Naturalmente, questa rete non ha i bracci e praticamente il corpo ed il sacco di raccolta sono un tutt'uno.
- Gli attrezzi più noti sono:
-
Sfogliara
-
Rapido
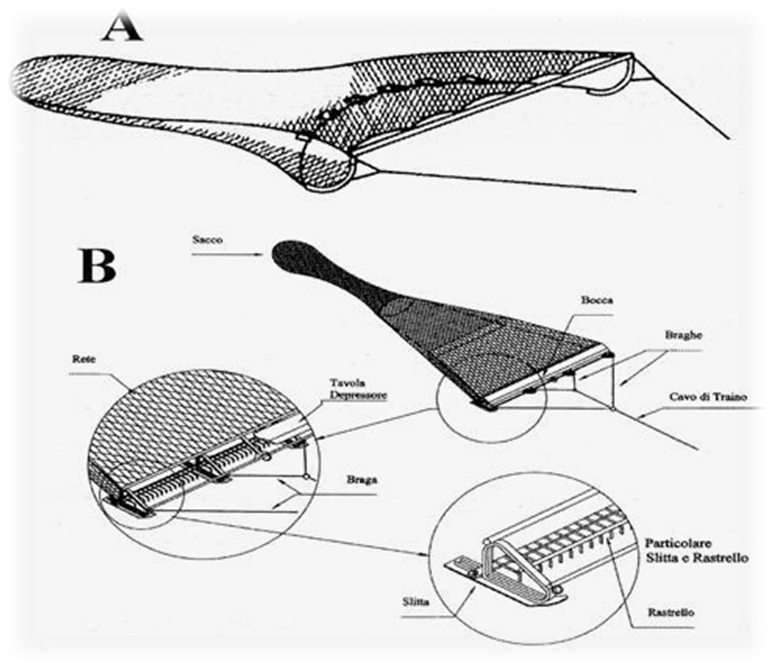
Sfogliara (A) e Rapido (B)
- Struttura del rapido (Fig. B) :
In alto: sacco, bocca, braghe, cavo di traino.
Al centro: rete, tavola depressore, braga.
In basso: slitta, particolare slitta e rastrello, rastrello.
Sfogliara
La “Sfogliara“ o Rampone, può definirsi l'antenato della categoria. Attualmente è quasi in disuso, ma in passato ha trovato largo impiego nelle marinerie dell'Alto e Medio Adriatico, per la cattura di sogliole, rombi e passere.
Le dimensioni della sfogliara variano a seconda della potenza della nave da pesca che deve trainarla: generalmente è costituita da una rete che forma un sacco allungato la cui bocca è costituita superiormente da un telaio metallico fissato su due slitte, che permettono lo scivolamento sul fondo; l'altezza della slitta determina l'apertura verticale. Il lato inferiore della bocca non presenta invece supporti rigidi ed è formato da cavo misto, appesantito da una serie di piombi che lo fanno aderire fortemente al fondale. La parte inferiore è unita alla struttura con una lima dei piombi a forma di corona, che assicura un forte contatto con il fondo.
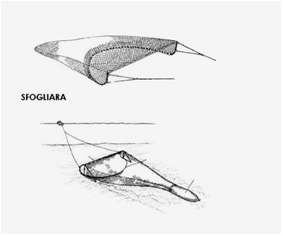
Sistema di pesca Sfogliara
Ogni unità può tirarne due (come indicato in figura), ma contrariamente al rapido, la velocità non è consigliata poiché l’attrezzo si alza dal fondo. Attualmente è poco usata in Italia sostituita dal rapido più redditizio.
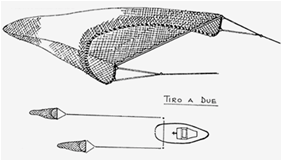
Tiro a due
- Sfogliara (peculiarità):
- Rete da traino la cui bocca è tenuta aperta da un'asta fissata a due slitte che ne permettono lo scivolamento sul fondo.
- Ogni imbarcazione può trainare fino a 2 attrezzi.
- Poco usata in Italia.
-
Specie bersaglio: sogliola.
Rapido
Il “Rapido“ può definirsi come un'evoluzione tecnologica della Sfogliara; in effetti rimane la struttura del telaio con le slitte, ma per aumentare la penetrazione nel substrato sono stati introdotti degli accorgimenti: la tavola depressore e il rastrello.
Il rapido è una rete da pesca utilizzata in Adriatico per la cattura di specie bentoniche: sogliole, seppie, pannocchie, cappesante, rombi, passere, ghiozzo.
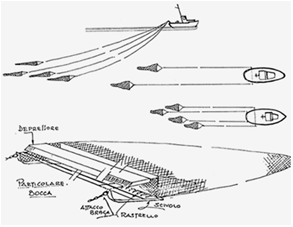
Sistema Rapido
E’ costituito da un'armatura rettangolare interamente in ferro sulla quale è fissato il corpo della rete. La parte superiore della bocca, lunga non più di 4 metri, è inclinata in avanti con un angolo di circa 22°, su cui è fissata una tavola di legno che funziona come un “depressore”, facendo in modo che l'attrezzo aderisca al fondo. La parte inferiore dell'armatura è munita di “denti ricurvi”, che sporgono di 2 o 3 cm dal piano d'appoggio dell'armatura e che penetrano nel fondo marino.
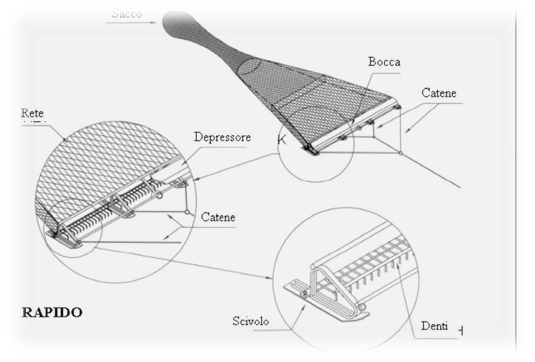
Struttura rapido
Lo scivolamento è consentito da “slitte” collegate al cavo di traino tramite catene. I denti arcuati penetrano nel fondo sabbioso e obbligano le sogliole a sollevarsi e a finire nella rete. La tavola depressore è fissata sulla parte superiore del telaio con un angolo che si può variare per regolare la spinta verso il basso dell'attrezzatura, al variare della velocità del traino.
L’ apertura verticale dell’attrezzo è circa 15-20 cm., quella orizzontale 3-4 metri (le dimensioni non sono soggette a normativa).
La rete è composta di più pezze in poliammide senza nodo e la sua larghezza complessiva è di circa 8-10 metri. In genere è presente un foderone, eventualmente una fodera di rinforzo ed il sacco presenta sempre un cavo di chiusura.
L’avanzamento sul fondale è agevolato dalle slitte metalliche montate sulla parte inferiore dell’armatura; è costituito da denti metallici ricurvi che si infossano di circa 2-3 cm. stanando gli organismi nascosti sotto la sabbia.
Questo tipo di pesca generalmente si effettua a una velocità di 6-7 nodi [1], contro i 3-4 nodi . dello strascico a divergenti
Il nome "Rapido" trae origine proprio dall'alta velocità del traino. Questo tipo di pesca, come abbiamo detto in precedenza. è ancora molto praticato nelle marinerie dell'Alto e Medio Adriatico e si effettua generalmente di notte in alternativa alla rete a strascico, tanto che alcune unità da pesca hanno a bordo entrambe le attrezzature.
Ogni unità pesca con due o più rapidi per volta, con la tecnica illustrata nella figura che segue. Ogni unità può tirare anche 4 rapidi simultaneamente.
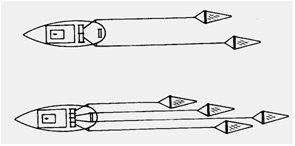
Rapido (reti in assetto di pesca)
La pesca con il rapido è vietata in Tirreno (D.M. 26.07.95) dove è ancora utilizzato da poche unità autorizzate (D.M. 04.08.2000).
E' usato principalmente per la cattura delle sogliole.
Le dimensioni variano a seconda la potenza del motore dell’unità ma generalmente non superano i quattro metri.
- Rapido (peculiarità):
- Rete a strascico a bocca fissa.
- la bocca è formata da una intelaiatura rigida su cui sono montati dei denti arcuati che penetrano nel substrato.
- le dimensioni orizzontali non superano mai i 4 metri.
- le cale sono brevi, in genere di 1 ora.
- ogni unità può tirare da 2 a 4 attrezzi.
- molto usato in Adriatico, meno nel Tirreno.
- specie bersaglio: pesci piatti, seppie, cicale e mazzancolle (in alcune aree viene usato per la pesca delle capasante).
[1] Il termine "nodo", significa "un miglio all'ora".
Disciplina della pesca con sistema a strascico
Alla luce delle deroghe concesse all’art. 14, punto 2, del Reg. (CE) 1967/2006, lo strascico è vietato entro le 3 (tre) miglia nautiche dalla costa o entro i 50 (cinquanta) metri di profondità, se tale profondità è raggiunta a distanze inferiori.
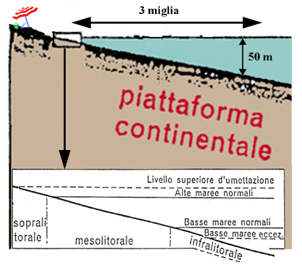
- Dal 1° giugno 2010 sarà comunque vietato l’uso entro 1.5 miglia nautiche dalla costa.
La Commissione può autorizzare deroghe per attività di pesca già autorizzate dagli Stati membri e per le unità da pesca aventi un’attività comprovata nella pesca di più di cinque anni e solo se l’attività non comporta alcun aumento futuro nello sforzo di pesca previsto.
- Peraltro lo strascico è vietato:
-
sulle praterie di Posidonia oceanica o di altre fanerogame marine;
-
su habitat coralligeni e letti di maerl;
- a più di 1000 metri di profondità
Il divieto si applica a tutte le zone Natura 2000, alle zone particolarmente protette, alle zone particolarmente protette di rilevanza mediterranea (ASPIM).
Maglie delle reti a strascico: dal 30/06/2008 pezza di rete a maglia quadrata[1] da 40 mm nel sacco o, su richiesta debitamente motivata da parte del proprietario del peschereccio, una rete a maglia romboidale da 50 mm.
E’ vietato utilizzare coperture della maglia del sacco o comunque dispositivi atti ad ostruire o chiudere le maglie con conseguente riduzione della dimensioni e quindi della selettività.
Gli unici dispositivi autorizzati sono i seguenti (Reg. CE 3440/1984 e Reg. CE 1967/2006):
- foderoni di rinforzo: anche più di uno sovrapposti, possono essere utilizzati unicamente nella parte inferiore del sacco per attenuare i danni derivanti dal contatto con il fondo marino;
- fodera: avvolge completamente il sacco. Nelle reti italiane è possibile utilizzare 2 fodere di rinforzo. Maglia non ≥ 120 mm e dimensioni (circonferenza) ≥ 1,3 volte il sacco;
-
fodere superiori: montate sulla parte superiore del sacco. Di tipo A (apertura delle maglie almeno pari a quelle del sacco, larghezza 1,5 volte quella del sacco), di tipo B (maglia doppia rispetto al sacco). In Italia è consentito usare contemporaneamente fodera superiore e fodera di rinforzo.
► Recenti innovazioni tecniche della pesca a strascico
Attualmente questo tipo di pesca può essere effettuato mediante l’uso di due (raramente più di 2) reti di dimensioni inferiori rispetto alle reti tradizionali che vengono trainate contemporaneamente. Tali reti devono rispettare la normativa relativa allo strascico (maglie, fodere, ecc.).
In molte marinerie il sacco delle reti a strascico non è unico ma è diviso in due settori uno superiore e uno inferiore: nella parte inferiore si accumulano granchi, scampi, ecc ma anche tutto lo “sporco”, nella parte superiore viene convogliato il pescato commerciale. Entrambe le sezioni devono rispettare la normativa relativa alla maglia, alla circonferenza e alle fodere.
E’ fatto divieto di utilizzare coperture del sacco o comunque dispositivi di montaggio e di armamento atti ad ostruire o chiudere le maglie o di avere per effetto la riduzione della selettività del sacco.
È consentito l'uso di foderoni di protezione o di altro materiale fissato unicamente al di sotto del sacco per attenuare o prevenire i danni derivanti alla rete dall'abrasione del fondo marino.
È consentito l'uso di doppi sacchi, a condizione che l'apertura delle maglie dei sacchi esterni risulti almeno tre volte quella delle maglie del sacco della rete e che la loro larghezza stirata corrisponda ad un valore compreso tra 100 e 150 per cento della larghezza stirata del sacco interno.
Il Ministro, con la procedura di cui all'articolo 32 della legge 14 luglio 1965, n. 963, può consentire l'uso di reti a strascico con maglie aventi apertura inferiore a 40 mm nel caso di “pesche speciali” rivolte alla cattura di specie i cui individui, allo stadio adulto, non possono essere convenientemente pescati con reti a maglia regolamentare.
[1] Per quanto riguarda le maglie delle reti da traino: dai 40 mm, a forma «romboidale», si passa ai 40 mm a forma «quadra». Quest'ultima, per effetto della trazione dell'unità da pesca, non si comporta come quella a rombo, ovverosia, non si chiude, assicurando maggiore selettività dell'attrezzo. Per tale motivo è stata data possibilità alle imprese di pesca di dotarsi, in alternativa, di reti con sacchi a maglia romboidale, di misura pari a 50 mm, dietro autorizzazione ministeriale. E' questa l'opzione scelta dalla maggioranza degli armatori delle unità da pesca che hanno presentato domanda alle Capitanerie di porto.
Sistema volante
La «volante» è una rete che viene trainata in superficie, a mezz'acqua o che sfiora appena il fondo a seconda del tipo di pesce che si vuole catturare. Queste reti vengono anche chiamate "pelagiche" perché non toccano il fondo. La tecnica della volante permette di catturare alici, sardine, sgombri e aguglie.
In questi ultimi anni il sistema ha soppiantato le reti a circuizione per la cattura del pesce azzurro. Il sistema di pesca è effettuato in prevalentemente in Adriatico. Queste reti sono state, infatti, introdotte in Italia dai pescatori del Nord Adriatico che hanno importato il sistema da retifici che lo producevano per l’uso nel mare del Nord, dove sono nate e si sono rapidamente sviluppate.
La rete volante è usata solo "a coppia", trainata, a mezz'acqua o sfiorante appena il fondo, da due pescherecci per la cattura di pesci pelagici come: alici, spratti, aguglie, sgombriformi e cefali: anche più di 10 t in un’unica cala.
Il sistema "volante" comprende quelli attualmente denominati come:
-
traino pelagico a coppia
- agugliara
La denominazione di "traino pelagico" è soppressa (Art. 11, n. 5 del D.M. 26 luglio 1995 “Disciplina del rilascio delle licenze di pesca). (G.U. 31 agosto 1995 n. 203).
Traino pelagico a coppia
Si tratta di reti “volanti” che sono trainate a mezz'acqua o sfiorano appena il fondo (reti semipelagiche). Sono reti “attive” in quanto catturano il pesce nel loro progressivo avanzamento.
Nel sistema volante a coppia ogni peschereccio traina due cavi della rete. Dai due lati della rete parte un cavo dalla mazzetta superiore e uno da quella inferiore.
La rete volante ha in tutto quattro mazzette e quattro lime: lima da sugheri, lima da piombi e due laterali.
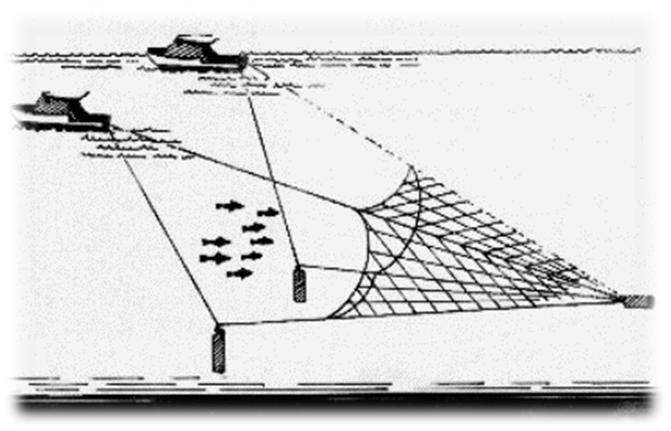
Traino pelagico a coppia (volante)
La possibilità di pescare in superficie, a mezz'acqua o vicino al fondo (operando in quest’ultimo caso come rete semipelagica) dipende dalla lunghezza del cavo filato e dalla velocità di pesca.
Per basse profondità, quando la lunghezza del cavo filato è minima (100-150 metri) la distanza è controllata da un cavo detto "traversino" che unisce i due pescherecci; per alte profondità, quando il cavo filato è superiore ai 150 m, la distanza è sotto controllo radar.
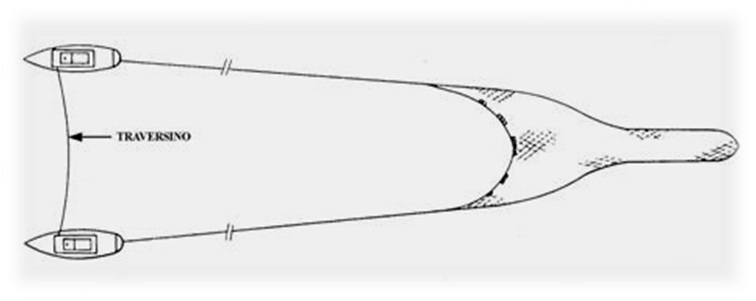
Schema della volante a coppia
La rete volante viene usata spesso come rete “semipelagica” perché nei nostri mari e soprattutto di giorno, il pesce azzurro staziona in prossimità del fondo. D’altra parte la pesca semipelagica è più sicura sia perchè il pesce ha una possibilità di fuga in meno (da sotto rete) sia perchè, non disponendo i pescherecci di strumenti di controllo della rete (net sonde), è più facile lavorare la lima da piombi sul fondo. A mezz’acqua non si ha la certezza di esplorare la zona in cui lo scandaglio ha evidenziato il pesce e quindi cattura è più aleatoria. L’apertura orizzontale (20-40 metri) è naturalmente assicurata dai due pescherecci che trainano in coppia, mentre quella verticale (10-14 metri) è assicurata da due grossi pesi (di 250-300 Kg ciascuno) sui due cavi di traino che vanno alle mazzette inferiori, dai piombi e dai galleggianti, questi ultimi, praticamente sempre presenti, anche se non indispensabili.
La rete, di forma conica o piramidale, è formata da moltissime pezze di maglie e filo diversi e termina con un sacco a maglia più piccola dove viene trattenuto il pescato.
Il corpo della rete è composto da quattro parti che sono a due a due uguali: le due parti laterali e la parte superiore ed inferiore.
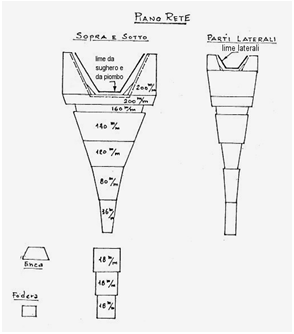
Schema di base della volante a coppia
La parte superiore e la parte inferiore identiche tra loro e le due parti laterali, anch’esse identiche. Nella rete volante, come modificata e prevalentemente usata in Italia, si ha che le parti laterali sono la metà come numero di maglie della parte superiore ed inferiore.
Le maglie nella prima parte della rete (braccia e prima parte del corpo) sono molto grandi normalmente intorno ai 660 mm di lato e gradatamente diminuiscono man mano che ci si avvicina alle prime pezze del cielo (600-200 mm.) fino al sacco e nel sacco sono generalmente molto piccole con nodo (16 - 18 mm.).
Le maglie del sacco quindi sono molto piccole: ciò però non è dovuto alla volontà del pescatore di usare una maglia, anche proibita, ma consenta migliori catture. L’uso di una maglia piccola è imposto dalle necessità di evitare l’imbrocco anche alla più piccola delle tre specie pelagiche che prevalentemente compongono le saccate delle reti volanti: sarde, acciughe e spratti.
Se si dovesse avere l’imbrocco ci si troverebbe con un pesce ogni maglia e si impedirebbe quindi lo scarico dell’acqua da parte della reti provocando in questo modo la rottura della rete stessa.
Questo attrezzo, se incontra un grosso banco di pesce, può fare catture superiori alle 10 t in una sola cala, e la rete non può essere issata a bordo in una sola volta; per supplire a ciò, il sacco è costruito in modo tale (Enca e Strozzatoio).
L'Enca è un panno di rete inserito all'interno e nella parte iniziale del sacco, che funziona da valvola di non ritorno ed è sollevato quando la barca è in movimento, mentre si abbassa quando la barca si ferma.
Lo Strozzatoio è posto verso la fine del sacco e, tirato da una manovra volante di bordo (ghia), divide la saccata nelle quantità volute dal Capopesca.
Oltre alla volante a coppia esiste anche la volante monobarca ma in Italia e in Mediterraneo è molto rara e spesso viene usata a livello sperimentale.
-
Traino pelagico a coppia (peculiarità):
-
La volante usata in Italia è simmetrica, costituita da 4 facce, uguali a due a due (1 Superiore, 1 inferiore e due laterali).
-
La rete ha 4 lime: linea da sughero, linea da piombo e due lime laterali; l’apertura orrizzontale (20-40 metri) è garantita dalla distanaza tra i due pescherecci aventi caratteristiche di potenza simili; l’apertura verticale (10-14 metri) è garantita dagli opposti effetti dei galleggianti e dei piombi. Per mantenere queste aperture a velocità di 4.5 nodi, si impiegano ulteriori pesi (due, di 250-300 Kg. ciascuno) montati sui cavi inferiori ad una distanza di circa 30 metri dalle punte dei bracci.
- Le dimensioni delle maglie decresce dai bracci (660 mm.) alle prime pezze del cielo (600-200 mm.) fino al sacco, dotato di maglie molto piccole con nodo (16-18 mm.)
- Il sacco è costituito dall’enca e dallo strozzatoio; l’enca è un pannello di rete dentro il sacco (una sorta di imbuto) che impedisce al pesce di tornare in dietro una volta catturato; lo strozzatoio, posto alla fine del sacco divide la saccata nelle quantita volute dal capopesca.
-
Specie bersaglio: piccoli pelagici (acciughe e sardine) anche 5-10 t. a cala.
Agugliara
Tra le reti da traino pelagiche a coppia la agugliara merita un posto a parte. Questo attrezzo, poco conosciuto nelle marinerie italiane, ha riscontrato un discreto successo negli anni '60 - '70 nel Medio Adriatico.
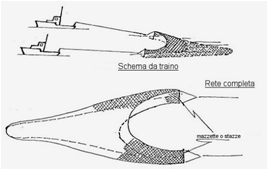
Sistema Agugliara
Attualmente il suo uso è molto limitato anche in questa zona, perchè cattura una sola specie (aguglie) e solo in particolari condizioni ambientali (estate e mare completamente calmo). Infatti le aguglie, durante il periodo estivo, si portano in vicinanza della superficie e spesso saltano fuori dall'acqua.
E’ una rete quindi molto selettiva che praticamente cattura solo aguglie e saltuariamente, quando ne incontra il banco, cefali.
Si tratta di una rete di superficie unica nel suo genere poiché viene trainata con la lima da sugheri (che chiameremo ancora così anche se è completamente priva di sugheri) fuori dell’acqua per evitare che le aguglie, con i loro caratteristici balzi fuori dall’acqua possono evitare la cattura.
L'agugliara è trainata da una coppia di pescherecci, in modo tale che le mazzette su cui sono montati i bracci sporgano dall'acqua consentendo alla rete di "emergere" e catturare anche i pesci che tentano di saltare fuori dall'acqua, con la tecnica illustrata nella figura.
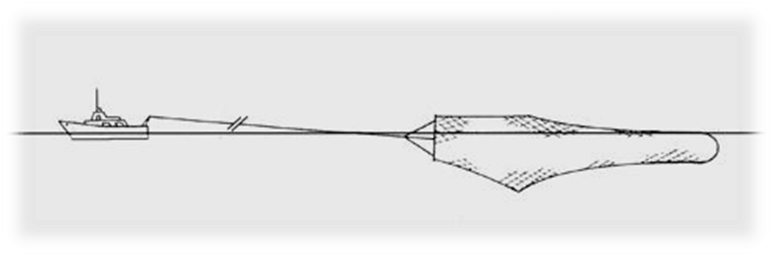
Agugliara in assetto di pesca
Contrariamente alla volante, la agugliara è formata da sole due parti, perfettamente simmetriche e viene trainata con un solo cavo per ciascuna unità.
L’apertura orizzontale e naturalmente garantita dai due pescherecci, mentre quella verticale è assicurata da due lunghe aste in ferro che fanno da mazzette
E’ una rete usata praticamente solo in Adriatico da tanti di modeste potenze. Di preferenza viene pescata di notte.
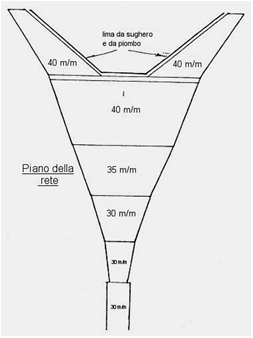
Schema di base agugliara
- Agugliara (peculiarità):
-
Rete di superficie usata in Adriatico, costituita da 2 parti perfettamente simmetriche; viene trainata con un solo cavo per ciascuna unità.
-
L’apertura orrizzontale (20-40 metri) è garantita dalla distanaza tra i due pescherecci aventi caratteristiche di potenza simili; l’apertura verticale (10-14 metri) è assicurata da 2 lunghe aste in ferro che fanno da mazzette.
-
Specie bersaglio: è una rete molto selettiva che praticamente cattura solo agug1ie e saltuariamente, quando ne incontra il banco, cefali.
Disciplina del sistema volante
Alla luce delle deroghe concesse all’art. 14, punto 2, del Reg. (CE) 1967/2006, lo strascico è vietato entro le 3 (tre) miglia nautiche dalla costa o entro i 50 (cinquanta) metri di profondità, se tale profondità è raggiunta a distanze inferiori.
- Dal 1° giugno 2010 sarà comunque vietato l’uso entro 1.5 miglia nautiche dalla costa.
La Commissione può autorizzare deroghe in certe situazioni (art. 13) per attività di pesca già autorizzate dagli Stati membri e per le unità da pesca aventi un’attività comprovata nella pesca di più di cinque anni e solo se l’attività non comporta alcun aumento futuro nello sforzo di pesca previsto.
- Le reti volanti sono vietate:
-
sulle praterie di Posidonia oceanica o di altre fanerogame marine;
-
su habitat coralligeni e letti di maerl;
- a più di 1000 metri di profondità
L’apertura della maglia delle volanti non deve essere inferiore ai 20 mm quando sardina e acciuga rappresentano almeno l’80% delle catture in peso vivo misurate dopo la cernita.
E’ vietato ostruire le maglie o ridurre di fatto le dimensioni. Gli unici dispositivi autorizzati sono i seguenti (Reg. CE 3440/1984 e Reg. CE 1967/2006):
- foderoni di protezione: anche più di uno sovrapposti, possono essere utilizzati unicamente nella parte inferiore;
-
fodera di rinforzo: avvolge completamente il sacco. Nelle reti italiane è possibile utilizzare 2 fodere di rinforzo. Maglia ≥ 40 mm e dimensioni (circonferenza) uguali al sacco;
Per la CE la fodera di rinforzo deve avere la larghezza (circonferenza) e la lunghezza almeno pari a quella parte del sacco a cui è attaccata e la maglia non deve essere in ogni caso inferiore a 80 mm per una sola fodera e 120 mm se si sovrappone un’altra fodera. -
fodere superiori: dispositivo che consta di un pannello di rete rettangolare cucito solo nella parte superiore del sacco e ve ne possono essere di due tipi:
- Tipo A: se la fodera è confezionata con la stessa maglia del sacco (es.40 mm.), la sua larghezza deve essere almeno una volta e mezza più grande della porzione del sacco interessata, cioè la metà.
- Tipo B: se la fodera è confezionata con una maglia doppia rispetto a quella del sacco (es. 80mm), la sua larghezza può essere uguale a quella del sacco (metà)
In Italia è consentito usare contemporaneamente fodera superiore e fodera di rinforzo.
Sistema draga
La pesca dei molluschi bivalvi è diventata in questi ultimi anni un'attività estremamente redditizia. Alla base della convenienza economica di questo tipo di mestiere, sono le qualità organolettiche del prodotto e le capacità di cattura degli attrezzi. La pesca viene fatta soprattutto su fondi sabbiosi, che rappresentano il substrato più sfruttato in Italia per l'abbondanza del prodotto. Possono essere impiegati diversi tipi di attrezzi, con barche di tonnellaggio variabile tra le 10 e le 15 tsl
Le «Draghe», in genere, sono attrezzi molto noti e molto usati per la pesca dei molluschi. L’attrezzo deve strappare e o raccogliere molluschi sessili o che si annidano nel substrato. In questa operazione naturalmente si raccoglie anche altro materiale non voluto. Da qui la nascita e l'evoluzione di vari attrezzi diversi, che con vari metodi riescono a trattenere i molluschi e a perdere il materiale di fondo. In alcuni casi si usano nei sacchi di raccolta, maglie molto grandi e fenditure nella parte superiore del sacco stesso e ciò è sufficiente a perdere buona parte dello sporco, in altri casi quando l’attrezzo penetra molto si pompa nell’attrezzo stesso acqua in modo che si abbia la perdita della sabbia e del fango. Generalmente questi attrezzi vengono usati in prossimità della costa soprattutto su fondali sabbiosi da pescherecci di limitata potenza che effettuano uscite giornaliere. Le catture sono generalmente abbastanza consistenti e ciò spiega l’elevato numero di unità che soprattutto in Adriatico operano con tali attrezzi.
Come già in precedenza accennato, le draghe idrauliche sono esse stesse attrezzi per molluschi. E’ bene comunque distinguere tra draghe idrauliche ed attrezzi da traino per molluschi. Anche la draga è tirata, ma molto lentamente. Il peschereccio tramite verricello recupera lentamente l’ancora che ha prima lasciato a congrua distanza. L’attrezzo da traino per molluschi invece è sì trainato a velocità abbastanza bassa, ma il traino avviene, come per le reti da traino, con l’elica stessa del motopeschereccio.
- Tra le draghe in generale troviamo:
-
draghe tirate da natanti, ossia attrezzi trainati attivamente dal motore principale del peschereccio (corrispondente all’italiano “Traino per molluschi”);
-
draghe meccanizzate, tirate da un verricello a motore di una nave ancorata (corrispondente all’italiano “Rastrello da natante”);
-
draghe idrauliche, draghe attrezzate di dispositivi idraulici;
-
draghe manuali, tirate a mano o da un verricello a mano in acqua bassa con o senza unità.
Disciplina delle draghe (Reg. CE 1967/2006)
L’uso delle draghe è autorizzato entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa, indipendentemente dalla profondità, purché le specie catturate diverse dai molluschi non superino il 10% del peso vivo totale della cattura.
Alla luce delle deroghe concesse dall’art.14, punto 2, del Reg. (CE) 1967/2006, fino al 31/05/2010, rimane in vigore la norma nazionale che vieta unicamente l’uso di “draghe idrauliche”, ad eccezione della "cannellara", a profondità inferiori a 3 metri (D.M. 22/12/2000).
Dal 01/06/2010 sarà vietato l’uso di “draghe tirate da natanti” (traino per molluschi) e di “draghe idrauliche” entro una distanza di 0,3 miglia nautiche dalla costa.
- La pesca con draghe è vietata:
-
sulle praterie di posidonia (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine;
-
su habitat coralligeni e letti di maerl;
- a più di 1000 metri di profondità con “draghe tirate da natanti” e “draghe idrauliche”.
La larghezza massima consentita per le draghe è di 3 metri (concordata con quella italiana solo per le draghe idrauliche, per il rastrello da natante e il traino per molluschi è più restrittiva la legislazione italiana) a eccezione delle draghe per la pesca delle spugne.
Sistema draghe tirate da natanti
Questo sistema (corrispondente all’italiano “Traino per molluschi” comprende attrezzi, privi di getti d’acqua in pressione, che trainati sul fondo marino staccano e trattengono i molluschi bivalvi che vivono sul fondo annidati nel substrato; generalmente, a questi attrezzi non si richiede una forte spinta verso il basso (tranne che per il Rampone). Il traino dei detti attrezzi può avvenire sia in modo rettilineo che circolare.
- Il sistema comprende i seguenti attrezzi:
-
Traino per molluschi (a lama)
-
Ostreghero
-
Rampone per molluschi
-
Sfogliara per molluschi
-
Ganghero (Sardegna, Puglia e Campania)
Sono molto diversi l’uno dall’altro per forma e dimensioni, ma generalmente consistono di una bocca rigida seguita da un corto sacco di rete tessile.
Assomigliano molto alle reti a strascico a bocca fissa, quali rapido e sfogliara da cui però è possibile distinguerli per alcune caratteristiche, quali:
-
larghezza della bocca o apertura orizzontale (più piccola) max 1.60 metri;
-
apertura di maglia del sacco in rete tessile o metallica (più grande) 50-60 mm.;
-
assenza di apertura posteriore del sacco (il recupero della cattura avviene per rovesciamento del sacco);
-
la lunghezza del corpo è molto limitata tanto da confondersi con il sacco di raccolta;
-
possono operare dentro le 3 (tre) miglia nautiche dalla costa;
- il traino dei suddetti attrezzi per molluschi può essere effettuato sia in linea retta che a cerchio utilizzando l’elica e/o l’ancora.
- Traino per molluschi (a lama)
Questi attrezzi da traino a telaio rigido, generalmente sono molto simili tra loro e cambiano il nome da zona a zona, in funzione dell'organismo catturato o del modo d'impiego.
Sono molto simili ai "rapidi", ma ne differiscono in particolari come: larghezza della bocca (ridotta), dimensioni delle maglie della rete del sacco di raccolta (più grandi), assenza del sistema di apertura del sacco nella parte posteriore (la cattura viene rovesciata sul ponte di coperta), lunghezza della rete molto ridotta (tanto da considerarla come fosse solo sacco).
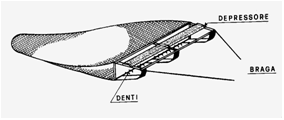
Traino per molluschi
- Ostreghero (senza lama e senza denti)
Per "Ostreghero" si intende un attrezzo a bocca rigida utilizzato essenzialmente per il prelievo delle ostriche. Ha una forma simile a quella di una sfogliara ed è munito di un sacco di raccolta in rete sintetica o metallica.
La bocca rigida è formata da un'asta trasversale in ferro, senza slitte agli estremi: nella parte inferiore è montata una lima da piombi, spesso in catena.
La larghezza della bocca non deve essere superiore a 1.6 m , la maglia della rete deve essere inferiore ai 60 mm
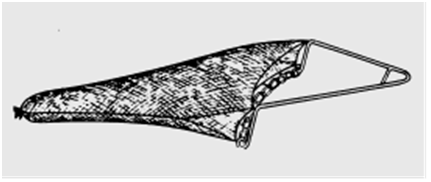
Ostreghero
- Rampone (a denti)
Il "rampone" tradizionale per molluschi è un attrezzo a bocca rigida che trova impiego particolarmente in alcune marinerie del Basso Adriatico (Manfredonia) per la cattura di cozze pelose (Modiolus barbatus), canestrelli (Chlamys glabrar), mussoli (Arca noae), cappesante (Pecten jacobaeus).
La struttura del telaio è molto simile a quella del rapido (un telaio rigido con lama a denti ricurvi che poggiano su due slitte), ma ha dimensioni ridotte e i denti del rastrello, sempre in tondino ricurvo, non sono appiattiti.
Se ne differenzia per la presenza di due depressori (tavole) con inclinazioni diverse che aumentano fortemente la pressione dei denti sul substrato.
Attrezzo simile al rampone è la “Cassa”: bocca rigida formata da un rettangolo in tondino in ferro a cui è armato un sacco di rete.
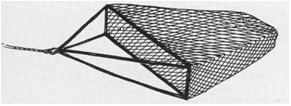
Rampone tradizionale a Cassa
Questo tipo particolare di pesca non necessita di una velocità elevata, bensì di una forte spinta verso il basso perchè gli organismi da catturare vivono su fondali abbastanza duri. Il sistema di traino non è rettilineo, ma circolare, e la velocità è piuttosto bassa.
In effetti, spesso il traino di questo attrezzo non è effettuato in modo rettilineo, ma circolare, cioè si passa più volte sulla stessa circonferenza, in quanto il mollusco da catturare, ad esempio la cozza pelosa, è fortemente attaccato sul fondo e la sua cattura avviene per “sradicamento”.
- Sfogliara per molluschi
Simile all’Ostreghero.
- Il Ganghero
Viene usato da piccole unità da pesca (in Sardegna, Puglia e Campania) per la cattura di gamberi, granchi e pesci bentonici. Viene trainato da una unità con un solo cavo.
La bocca ha forma rettangolare: la parte superiore è formata da un tubo di ferro piegato alle estremità mentre quella inferiore è formata da un cavo piombato Potrebbe definirsi come una sfogliara a grande apertura verticale: la bocca è infatti alta circa un metro e larga circa 5.

Ganghero
Due piccole slitte laterali consentono all’attrezzo di rimanere diritto. Il corpo della rete è costituito da diverse pezze con varie dimensioni di maglia: il corpo misura circa 20 m Si salpa su una fiancata.
- Sistema traino per molluschi (peculiarità):
- Comprende: attrezzo da traino per molluschi, ostreghero, rampone per molluschi, sfogliara per molluschi, il ganghero.
- Sono attrezzi privi di getti d’acqua che trainati sul fondo marino staccano e trattengono molluschi bivalvi annidati nel substrato.
- Diversi per forma e dimensioni, generalmente sono attrezzi a bocca rigida seguita da un corto sacco di rete tessile.
- Assomigliano alle reti a strascico a bocca fissa, quali il rapido e la sfogliara ma si differenziano da essi per alcune caratteristiche quali:
- Larghezza della bocca o apertura orizzontale (più piccola): max 1.60 metri;
- Apertura di maglia del sacco in rete tessile o metallica (più grande): 50-60 mm;
- Assenza di apertura posteriore del sacco (il recupero della cattura avviene per rovesciamento del sacco);
- La lunghezza del corpo è molto limitata tanto da confondersi con il sacco di raccolta;
- Possono operare entro le 3 miglia dalla costa.
- Il traino degli attrezzi per molluschi può essere effettuato sia in linea retta che a cerchio utilizzando l’elica e/o l’ancora.
Disciplina del sistema traino per molluschi (D.M. 22/12/2000)
Il telaio del Rampone e della Cassa: non deve avere una larghezza superiore a 1,60 metri. L’apertura della maglia non deve essere inferiore a 50 mm.
Nella parte superiore della rete (sacco) devono essere presenti tre aperture longitudinali che agevolano la fuoriuscita dei detriti (solo per il rampone di manfredonia).
Il telaio dell’Ostreghero e della Sfogliara per molluschi non deve avere una larghezza superiore a 1,60 metri; l’apertura della maglia non deve essere inferiore a 60 mm;
Nel telaio non devono essere presenti le slitte che ne vincolano l’apertura verticale come nella sfogliara per sogliole.
Possono essere adibite a tale tipo di pesca le navi di lunghezza tra le perpendicolari (Lpp) di 10 metri, di stazza lorda non superiore a 10 t. e potenza motrice non superiore a 100 HP.
L’uso del sistema traino per molluschi è autorizzato entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa, indipendentemente dalla profondità, purché le specie catturate diverse dai molluschi non superino il 10% del peso vivo totale della cattura.
Alla luce delle deroghe concesse dall’ 14, punto 2, del Reg. (CE) 1967/2006, fino al 31/05/2010, rimane in vigore la norma nazionale che vieta unicamente l’uso del “sistema traino per molluschi”, ad eccezione della cannellara, a profondità inferiori a 3 metri (D.M. 22/12/2000).
Dal 01/06/2010 sarà vietato l’uso del “sistema traino per molluschi” entro una distanza di 0,3 miglia nautiche dalla costa.
Sistema draghe meccanizzate
Il sistema corrisponde all'italiano "Rastrello da natante ". I rastrelli da natante sono attrezzi a bocca rigida che trainati sul fondo marino, staccano e trattengono molluschi bivalvi annidati nel substrato. La parte superiore della bocca, normalmente, è un semicerchio la cui parte inferiore è il diametro. Alla bocca è montato un corto sacco di rete tessile per la raccolta dei molluschi.
I rastrelli sono attrezzi che possono essere trainati a mano o da piccole unità di massimo 10 tonnellate di stazza lorda; in quest'ultimo caso il traino e il recupero sono completamente manuali e non utilizzano il movimento delle unità.
- A questo sistema di pesca fanno riferimento due attrezzi:
-
rastrello a denti
- rastrello a lama.
Il «rastrello a denti» è munito di un manico piuttosto corto (1-2 m), che ha lo scopo di regolare l'inclinazione dei denti: sono in genere molto vicini e piuttosto lunghi (30 cm), affilati e ravvicinati (ad esempio, il rastrello napoletano) e servono a raccogliere le vongole dal fondo e convogliarle nel sacco.
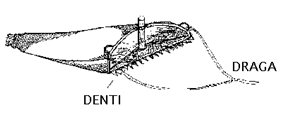
Rastrello da natanti a denti
Il «rastrello a lama», invece, ha un manico più lungo rispetto all'altro e penetra nel substrato raccogliendo sia il sedimento che vongole. Durante il recupero un marinaio di tanto in tanto scuote il manico per agevolare la fuoruscita del sedimento.
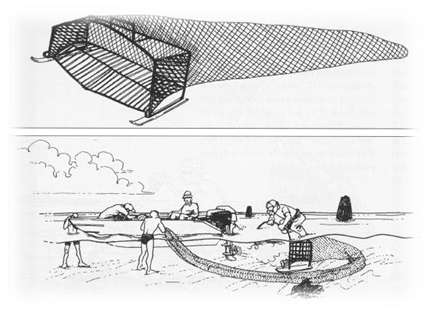
Rastrello a lama (Rusca)
Laguna di Venezia
Il traino avviene tramite recupero dell'ancora con il verricello. Ogni unità traina due attrezzi, con un cavo ciascuno, che agisce sulla bocca del rastrello.
Il salpamento dell'attrezzo è manuale; esso viene issato a bordo senza l'uso di verricello meccanico, o bigo. Questo tipo di attrezzo, data la sua particolare costruzione (manico di regolazione), ha una profondità di pesca molto limitata.
- I rastrelli da natanti sono molto diversi l'uno dall'altro per forma e dimensioni. Tra di essi si annoverano:
- Rastrello napoletano (Mar Tirreno)
- A mano da bordo a barca ancorata:
-
Rastrello per vongole (Viareggio);
-
Rastrello a denti (Margellina)
-
Rasca a manico lungo (Alto Adriatico)
- Rasca a manico corto (Alto Adriatico).
I rastrelli da natante sono maggiormente usati nei litorali campani, laziali e toscani, mentre quelli senza ausilio di forza motrice in Alto Adriatico e sono impiegati soprattutto per la pesca delle telline, mentre quelli trainati a mano per la cattura delle vongole.
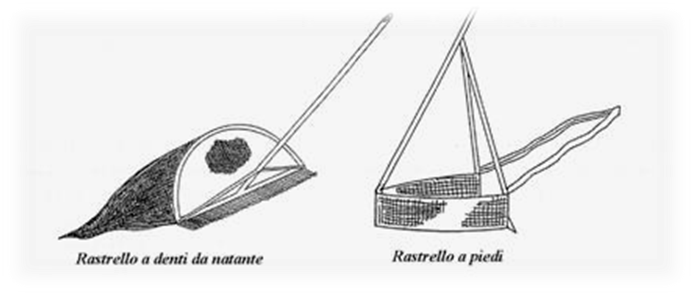
- Sistema rastrello da natante (peculiarità):
- Attrezzo a bocca rigida con la parte inferiore armata con lunghi denti di ferro
- I denti sono in genere molto lunghi (circa 30 cm.), affilati e ravvicinati per la raccolta di telline (es. rastrello napoletano).
- Alla bocca è montato un sacco in rete per la raccolta dei molluschi.
- Il rastrello è munito di un corto manico (1-2 metri) che regola l’iclinazione dei denti e in fase di recupero viene scosso per far uscire il sedimento.
- Il traino dell’attrezzo avviene tramite recupero dell’ancora con vericello.
-
Ogni unità traina 2 attrezzi ognuno con un cavo fissato alla bocca del rastrello.
Disciplina del sistema rastrello da natante
Il «rastrello da natante» deve avere le seguenti caratteristiche:
-
la bocca non deve essere superiore (=larghezza) a 1,50 metri;
-
l’apertura della maglia non deve essere inferiore a 20 mm. per le Telline e a 30 mm. per le altre specie di molluschi;
- il sacco di raccolta non deve essere più lungo di 2 metri.
Le unità da pesca non devono superare la stazza di 10 t, e la potenza dell’apparato motore non deve essere superiore a 100 HP. Il pescato massimo giornaliero è di 150 Kg.
L’uso dell’attrezzo è consentito solo nel Mar Tirreno ed è soggetto a limitazioni temporali (fermi,giornalieri e mensili).
.png)
Rastrello a piedi e rastrello senza l'ausilio di forza motrice
Per «rastrello a piedi» e «rastrello senza ausilio di forza motrice» si intendono attrezzi azionati esclusivamente da energia umana. Ve ne sono essenzialmente di due tipi; infatti la bocca inferiormente può essere provvista di una lama metallica (come nel caso della vongolara manuale), o di denti (come nel caso del rastrello a denti). L’attrezzo può essere fornito di sacco in rete tessile o cesto di raccolta in rete o grigliato metallico. L’attrezzo può essere adoperato a piedi o da bordo di un natante, in quest’ultimo caso il traino ed il recupero sono totalmente manuali.
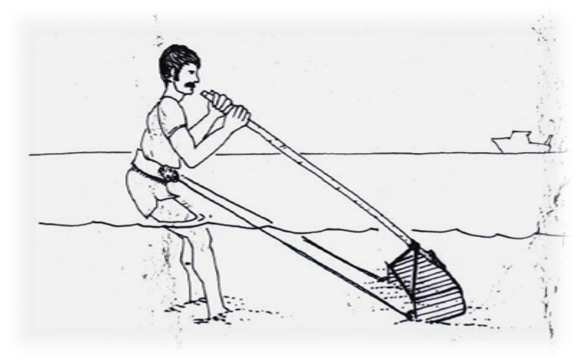
Rastrello a mano
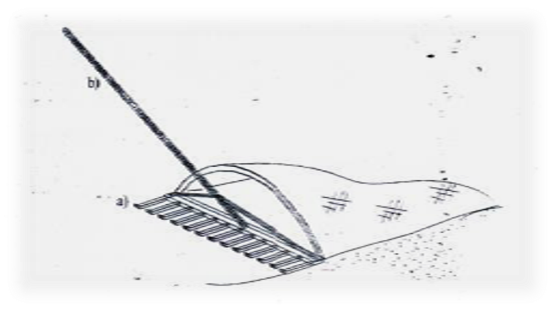
Rastrello a denti
Sistema draga idraulica
Le «draghe idrauliche» (o turbosoffianti) sono attrezzi utilizzati per la pesca dei molluschi bivalvi, in particolare di vongole, cannolicchi e fasolari, che vivono adagiati o affossati nel sedimento. Sono attrezzi che penetrano nel fondo marino per raccogliere, avanzando, tutti gli organismi presenti nel substrato.
Il sistema consente di trattenere i molluschi espellendo con una serie di getti d'acqua la sabbia e il fango.
La draga vera e propria è costituita da una gabbia completamente metallica (a forma di parallelepipedo) nel cui interno vengono iniettati getti d'acqua a pressione (draghe turbosoffianti), che agevolano sia la penetrazione dell'attrezzo nel sedimento che la fuoruscita di materiale come sabbia o fango, che possono intasare.
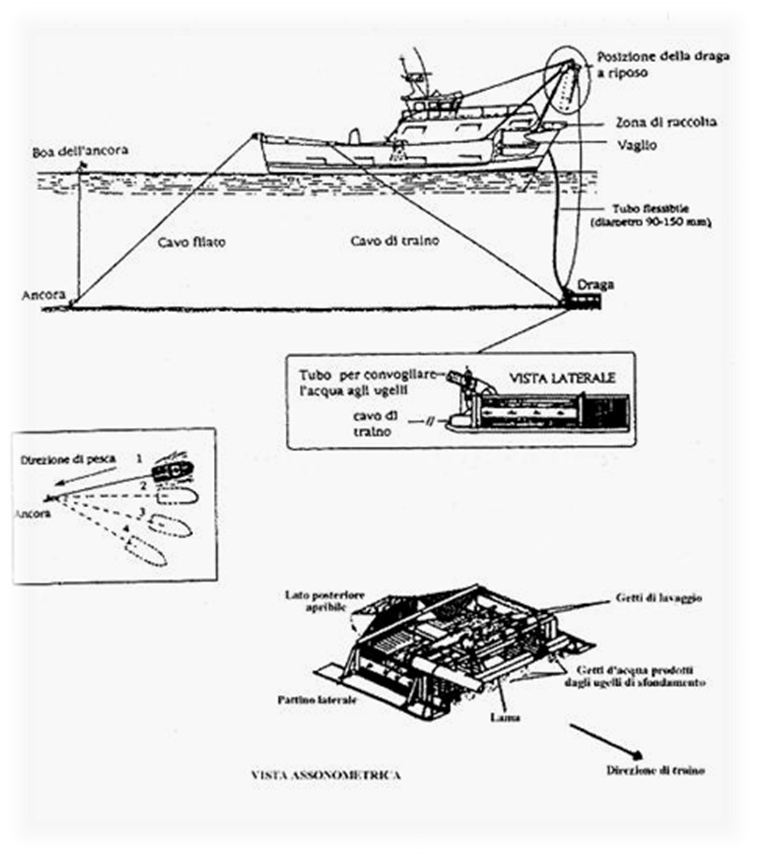
Sistema draga idraulica
La pompa dell'acqua a pressione è posta quasi sempre a bordo dell’unità da pesca, e l'acqua viene convogliata nella gabbia tramite un tubo di gomma.
Il grigliato della gabbia (che seleziona i bivalvi per taglia già in fase di pesca) è costituito da “tondini di ferro” la cui distanza varia a seconda dell'organismo da catturare.
Nella parte anteriore in contatto con il fondo, viene bullonata una draga metallica che, sporgendo sotto i pattini laterali di qualche cm (4-6 cm per le vongole e i fasolari e 10-15 cm per i cannolicchi), consente alla gabbia di scavare fuori dal sedimento gli organismi presenti.
Davanti alla lama e sul grigliato scorrono i tubi metallici con gli ugelli di sfondamento e smaltimento.
Il traino può essere effettuato normalmente tramite il recupero del cavo dell'ancora, o con l'elica a marcia indietro (la draga è sempre posta sulla prua dell'unità), con la tecnica illustrata nella figura che segue.
Il traino avviene con il recupero dell’ancora oppure con l’elica a marcia indietro poiché la gabbia è sempre posta a prua
Al termine del traino la gabbia viene issata a prora tramite il cavo di recupero ed il materiale raccolto viene convogliato in un setaccio, per la selezione delle taglie commerciabili.
A seconda dei molluschi che si vogliono catturare, la draga idraulica si differenzia, in base alle caratteristiche costruttive, in:
-
Vongolara
-
Cannellara
-
Fasolara
- Sistema draga idraulica (peculiarità):
-
Comprende: le draghe idrauliche (ha sostituito il sistema denominato “Turbosoffiante”)
-
Sono usate per la cattura dei molluschi bivalvi, in particolare vongole, cannolicchi e fasolari
-
La draga vera e propria è costituita da una gabbia metallica (a forma di paralleloepipedo) ai lati della quale sono presenti due slitte per agevolare lo scivolamento sul fondo.
-
Le draghe meccanizzate sono “a lama”, cioè presentano nella parte inferiore una barra affilata che penetra nel substrrato per qualche centimetro (4-6 cm. per le vongole, 15 cm. per i cannolicchi) convogliando all’interno dell’attrezzo tutto il sedimento e i molluschi in esso annidati.
-
Nella parte anteriore sono posizionati degli ugelli che pompano verso il basso un getto d’acqua a pressione che facilita la penetrazione dell’attrezzo nel sedimento.
- Altri ugelli, posizionati più inditero, puliscono la draga dal fango e dalla sabbia che altrimenti la intaserebbero, mentre i molluschi sono trattenuti dal grigliato.
Draga idraulica: tipologia
La «Vongolara» è l’attrezzo usato per la cattura delle vongole. In passato si usava la vongolara a mano che consisteva in un grosso rastrello con un lunghissimo manico. La vongolara era tirata lentamente recuperando l’ancora e con il manico si cercava di agitare il rastrello in modo che si scaricasse la maggior quantità possibile di sabbia. Ora si usa la vongolara con getto d’acqua all’interno dell’attrezzo.
Le dimensioni dell’attrezzo sono aumentate, il manico è scomparso, il salpamento è meccanico: in generale le catture sono molto più alte e con minor fatica.
- L’attrezzo è soggetto alle seguenti limitazioni (D.M. 22/12/2000):
- la distanza tra i tondini metallici della parte inferiore della gabbia non deve essere inferiore ai 12 mm. (con tolleranza di 1 mm);
- sono ammesse, in sostituzione dei tondini, reti metalliche (=setacci) a maglia quadrata aventi il lato non inferiore a 17 mm. oppure a maglia rettangolare con i lati rispettivamente di 12 e 25 mm. oppure a lamiera perforata aventi fori di diametro non inferiore a 21 mm ed il rapporto pieni/vuoti inferiore a 1/2;
- il prodotto raccolto dalla vongolara deve essere separato con setacci aventi grigliati con le stesse caratteristiche della gabbia di cui sopra. Nella misura della distanza tra i tondini (12 mm.) è consentita una tolleranza di 1 mm.
A seconda del tipo di pesca, sia la draga (parte inferiore) che i setacci (se ammessi) possono essere di tipo A, B o C (come rappresentato in figura).
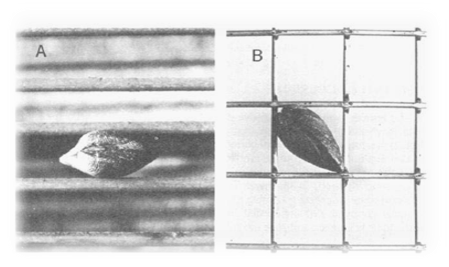
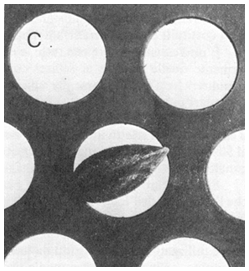
Griglia a maglia quadra con lato di 17 mm. Setaccio (Griglia del tipo C)
La «Cannellara» è molto simile alla vongolara, ha però un potere di penetrazione nel fondo marino superiore.
Ciò è necessario per catturare convenientemente i “cannelli”.
Non è ammesso l’uso di vibrovagli (=setacci): il pescato deve essere selezionato a mano.
Tutto il resto va ributtato in mare ad eccezione dei vermi marini (BIBI).
- L’attrezzo è soggetto alle seguenti limitazioni (D.M. 22/12/2000):
-
la distanza tra i tondini metallici della parte inferiore della gabbia non deve essere inferiore ai 7 mm.
-
non sono ammessi grigliati in sostituzione dei tondini;
- non è consentito l’uso e la detenzione del setaccio, per cui la cernita viene effettuata manualmente.
La «Fasolara» è usata infine per la cattura dei fasolari (Callista chione). E’ ammesso l’uso del vibrovaglio.
- L’attrezzo è soggetto alle seguenti limitazioni (D.M. 22/12/2000):
- la distanza tra i tondini metallici della parte inferiore della gabbia non deve essere inferiore ai 25 mm.
- non sono ammessi grigliati in sostituzione dei tondini;
- è consentito l’uso e la detenzione del setaccio, per la cernita del pescato.
La flotta italiana conta all’incirca 835 unità equipaggiate con “draga idraulica”, che rimane l'attrezzo più usato per la pesca dei molluschi in Italia, in particolar modo in Alto e Medio Adriatico, dove si contano 784 unità operative, per la pesca di vongole, longoni e fasolari e nel litorale campano e laziale, dove operano non più di 60 turbosoffianti per la cattura dei cannolicchi.


Sistema draga idraulica
Sistema attrezzi da posta
In questa categoria sono inseriti tutti gli attrezzi confezionati con rete che vengono lasciati in mare in una postazione fissa o in balia delle correnti. Generalmente questi attrezzi vengono definiti "passivi" perchè sono gli organismi marini che nei loro spostamenti vi incappano rimanendo intrappolati per imbrocco (gilled), per impigliamento (entangling) o per insaccamento (bagging) che è tipico del tremaglio.
- Il sistema comprende i seguenti attrezzi:
-
reti da posta (fisse e derivanti)
-
trappole fisse (tonnara fissa, lavoriero, rete circuitante)
- trappole mobili (nassa, cogollo, bertovello)
La pesca è stagionale e legata alla tipologia delle specie da catturare. Le unità che attuano tale tipo di pesca fanno parte in genere della “Piccola pesca” (DM 14/09/1999, pesca costiera locale) e quindi le dimensioni devono essere LFT < 12 m e TSL < 10.
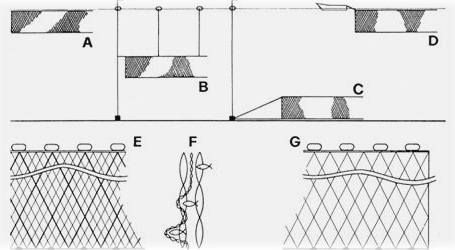
Reti da posta fisse (A: superficie, B: mezz’acqua, C: da fondo) e derivanti (D)
Tremaglio con relativo sistema di cattura (E, F); imbrocco (G).
- Approfondimenti:
Le reti da posta sono reti “passive", destinate a recingere o sbarrare spazi acquei allo scopo di ammagliare: pesci, molluschi e crostacei che vi incappano. Una prima suddivisione di questa si ha quando sono nude o tramagliate: nel primo caso il pesce penetra con la testa e vi rimane impigliato, come ad esempio nella sardellara; nel secondo caso invece oltre la rete nuda vi sono altre due pareti a maglie più larghe così da consentire, sotto la spinta del pesce il formarsi di un sacco. Da qui un’altra versione per il riconoscimento di queste reti da posta, quella della sua destinazione: da imbrocco o da insacco. A loro volta si suddividono ulteriormente in reti fisse e reti derivanti: le prime sono ancorate al fondo marino e le seconde invece sono lasciate all’azione dei venti e delle correnti. Le reti da posta sono le reti da pesca più note, più ingegnose e di più antico uso. Sono reti formate da fili moto sottili e flessibili in quanto debbono essere il meno visibili al pesce perché non si spaventi e scappi. Questo tipo di pesca è effettuata da motopescherecci da 20-30 tsl. Si possono individuare alcuni tipi di rete usate dai pescatori.
Le reti da posta sono quelle destinate a recingere o sbarrare spazi acquei allo scopo di imbroccare od ammagliare gli organismi marini che vi incappano.
Esse si dividono in fisse e derivanti; le prime sono ancorate sul fondale marino, mentre le seconde sono lasciate all'azione delle correnti e dei venti.
Questi attrezzi sono confezionati con lunghi pannelli (pezze) di rete rettangolari che vanno armate con due lime: sulla superiore vengono montati i galleggianti e su quella inferiore i piombi in modo da farle assumere in acqua una posizione verticale (l'effetto combinato assicura l'apertura verticale della rete).
Le reti da posta possono essere calate in mare vicino alla superficie, a mezz'acqua o sul fondo, a seconda delle specie da catturare. Possono essere confezionate in tre modi diversi: con un solo pannello di rete (imbrocco), con tre pannelli (tremaglio) o come “incastellata o combinata”, che viene armata a tremaglio nella parte inferiore (per la cattura del pesce di fondo) e ad imbrocco nella parte superiore (per la cattura dei pelagici).
È consentito l'impiego di tutti i tipi di reti da posta, sia fisse che derivanti, senza limitazioni di lunghezza purché le dimensioni delle maglie “non siano inferiori a mm. 20“ e le reti siano dotate dei prescritti segnali.
Attualmente, tali reti vengono prodotte in nylon che, per la sua grande tenacità, consente la realizzazione di reti a fili sottilissimi ma comunque sufficientemente robusti. In alcuni casi, si sta inoltre diffondendo l’uso del monofilo che presenta, tra gli altri vantaggi, anche quello della quasi completa trasparenza in acqua.
Sono attrezzi usati praticamente in tutte le marinerie, anche in quelle più piccole. Infatti spesso vengono usate piccole unità a remi o con un piccolo motore fuoribordo che possono partire addirittura dalla spiaggia. Spesso sono utilizzate con buoni risultati in quei fondali dove la pesca a strascico non è possibile.
In genere, tali reti sono salpate e calate a mano ma in alcuni casi, per ridurre la fatica o per fare uso di reti di maggiore lunghezza vengono utilizzati particolari ausiliari di coperta detti salpatramagli.
A seconda che siano ancorate o meno al fondo e a seconda della loro disposizione in acqua possono essere suddivise in: fisse, derivanti e circuitanti.
Reti da posta
Le «reti da posta» sono quelle destinate a recingere o sbarrare spazi acquei allo scopo di imbroccare o ammagliare gli organismi marini che vi incappano.
- Esse si dividono in: “fisse” e “derivanti”
Le prime sono ancorate sul fondale mentre le seconde sono lasciate all’azione delle correnti e dei venti. Questi attrezzi si compongono di lunghi pannelli rettangolari di rete con nodo (singolo o doppio) armati nella parte superiore alla lima dei galleggianti e nella parte inferiore alla lima dei piombi (l’effetto combinato assicura l’apertura verticale della rete).
In particolare, per “reti da posta fisse” si intendono tutte quelle reti che, benché possano trovarsi in superficie (A), a mezz’acqua (B) oppure sul fondo marino (C) vengono tuttavia ancorate ad intervalli in modo fisso al fondo marino con ancore o pesi. I pesi o le ancore vengono segnalate in superficie da galleggianti munite di bandierine gialle di giorno e luci gialle di notte per renderne possibile l’individuazione al momento del recupero.
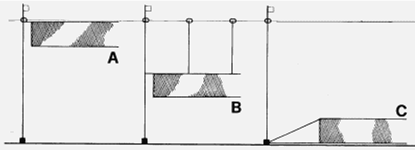
Reti da posta fisse (A: superficie, B: mezz’acqua, C: da fondo)
Le reti, una volta calate, vengono lasciate in posizione per un certo periodo di tempo, in genere una notte, in modo tale da renderle ancora più invisibili al pesce e poi recuperate. Normalmente, nell’intervallo fra l’operazione di cala e quella di salpata la barca rientra in porto.
- Possono essere confezionate in tre modi diversi:
-
con un solo pannello di rete (imbrocco)
-
con tre pannelli (tremaglio)
-
armata a tremaglio nella parte inferiore e ad imbrocco nella parte superiore (incastellata o combinata)
- Sistema reti da posta (peculiarità):
-
Le reti da posta sono reti “passive", destinate a recingere o sbarrare spazi acquei allo scopo di ammagliare: pesci, molluschi e crostacei che vi incappano.
-
Possono essere: “fisse” e “derivanti”; le prime sono ancorate sul fondale mentre le seconde sono lasciate all’azione delle correnti e dei venti.
-
Sono attrezzi composti di lunghi pannelli rettangolari di rete con nodo (singolo o doppio) armati nella parte superiore alla lima dei galleggianti e nella parte inferiore alla lima dei piombi (l’effetto combinato assicura l’apertura verticale della rete).
- Possono essere confezionate in tre modi diversi:
-
con un solo pannello di rete (imbrocco)
-
con tre pannelli (tremaglio)
-
armata a tremaglio nella parte inferiore e ad imbrocco nella parte superiore (incastellata o combinata)
► Tremaglio: 3 pezze di rete sovrapposte, delle quali la mediana è più estesa e presenta maglie più piccole. Specie bersaglio tipiche di fondale (scorfani, aragoste, seppie, ecc.).
-
Reti un uso nella marineria italiana:
-
semitramaglio: due pannelli, una a maglie strette e una a maglie larghe;
-
tramaglio incastellato: tramaglio nella parte inferiore, rete ad imbrocco nella parte superiore.
► Incastellata o combinata: questa rete combina i vantaggi delle due reti descritte precedentemente essendo formata nella parte superiore da una rete ad “imbrocco” (per la cattura dei pelagici) e nella parte inferiore da un “tremaglio” (per la cattura del pesce di fondo).
-
È abbastanza diffusa nel Tirreno, dalla Liguria al Lazio, rara o assente nelle altre regioni d’Italia.
►Rete circuitante: è una normale rete ad imbrocco di altezza pari a 10 metri che invece di essere calata in mare in modo rettilineo, è calata in cerchio o semicerchio in prossimità della costa: l’unità si pone all'interno dello stesso ed inizia a produrre rumori per spaventare il pesce e indirizzarlo verso le pareti della rete.
-
Nel mix di cattura spicca per valore economico il pesce bianco.
Rete da imbrocco
La «rete ad imbrocco» è costituita da un’unica pezza fissata ad una linea dei sugheri e ad una dei piombi. Costituita da fili in monofilamento, la rete ha in sostanza una cattura monospecifica e monotaglia. Ciò dipende dalla misura della maglia con cui è armata. I pesce penetra con la testa nella maglia e vi rimane impigliato.
La rete ad imbrocco è un attrezzo molto selettivo perché cattura solo pesci più o meno della stessa taglia che rimangono incastrati in una data maglia (i più piccoli l’attraversano e i più grandi non vi entrano); per questo motivo la rete ad imbrocco è confezionata con una gamma di apertura di maglia molto vasta (40-500 mm.) in funzione della specie e della taglia che si vuole catturare.
Il pesce non resta prigioniero in una sacca come nel tremaglio, ma generalmente penetra con la testa nella maglia e vi resta imprigionato, senza poter andare avanti e indietro.
.png)
Sistema da posta (Imbrocco)
Approfondimenti:
L’imbrocco è una rete selettiva la cui dimensione di maglia varia in funzione delle specie bersaglio, con target variabili da zona a zona e nei diversi periodi dell’anno: è comunque il merluzzo la specie che più contribuisce ai ricavi provenienti da questo attrezzo, seguita a notevole distanza da altre specie tra cui mendole, triglie, sogliole, pannocchie, orate, saraghi e boghe. A livello nazionale la rete ad imbrocco ha una frequenza del 28%, con picchi alti nel Lazio, dove è impiegata con la stessa frequenza del tramaglio (67%).
Sono reti formate da un’unica pezza. La cattura del pesce avviene per imbrocco ossia il pesce, una volta entrato nella maglia della rete, non riesce più ad andare né avanti né indietro.
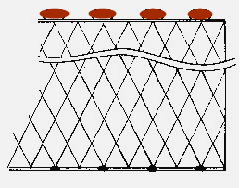
Schema della rete
Le dimensioni delle maglie di queste sono variabili a seconda della specie e della taglia del pesce che si intende catturare reti (≥ 16 – Reg. CE 1967/2006). Infatti se le maglie sono troppo grandi il pesce può passare oltre senza danni mentre se troppo piccole il pesce non resta ammagliato e quindi sfugge alla cattura.
Le reti a maglia piccola sono usate prevalentemente per la cattura specie pelagiche e necto-bentoniche (sogliole, canocchie, palombi, naselli, salpe, occhiate).
Le reti a maglia media (50-130 mm circa) catturano diverse specie commerciali di taglia maggiore.
Le reti a maglia medio-grande (160-200 mm) sono specifiche per alcune specie di tonnetti e alalunghe. Infine, le reti a maglia grande (> 350 mm) e filato molto spesso, sono specifiche per la cattura dei pesci spada (=spadare).
Nel caso della rete da posta per tonni la cattura non avviene tanto per imbrocco quanto per intrappolamento del pesce nella rete.
Questo tipo di rete, lunga alcuni chilometri, può essere sia di tipo fisso che derivante. Per lo svolgimento della pesca con reti ad imbrocco vengono messe in atto tecnologie piuttosto semplici: 1 o 2 persone di equipaggio e imbarcazioni di modeste dimensioni.
Rete tramaglio
E’ la più nota tra le reti da posta, ed è formata da tre pezze (pannelli) di rete sovrapposte ed armate con diverso rapporto di armamento sulle stesse due lime da sughero e da piombi.
Le due pezze esternamente identiche e formate da maglie molto grandi sono armate sulle lime con un rapporto di armamento abbastanza alto (0,6-0,7), mentre la pezza intermedia ha maglie piccole e rapporto di armamento basso (0,4-0,5). I filamenti sono generalmente multifilamento o multimonofilamento.
.bmp)
Sistema da posta (Tramaglio)
Ciò permette una sovrabbondanza di rete nella pezza a maglia piccola. Il pesce quindi incontra nel suo cammino la rete e cerca di superarla; da qualunque parte provenga, supera abbastanza agevolmente la maglia grande della pezza esterna (il maglione) e preme sulla pezza a maglia piccola che essendo sovrabbondante fa una sacca delimitata dalla maglia grande della terza parte di rete. In questa sacca il pesce resta imprigionato senza nessuna possibilità di fuga; da qui verrà prelevato dal pescatore quando salpa la rete.
Il tremaglio è generalmente calato sul fondo per la cattura di specie pregiate. Le dimensioni delle maglie e dei maglioni variano da zona a zona.
Il tremaglio è confezionato con filato molto sottile e questo agevola l’ammagliamento del pesce al solo contatto con le pinne; per questo motivo tale attrezzo è considerato poco selettivo.
- Sono in uso nelle marinerie italiane vari tipi di tramaglio:
-
semitramaglio: due pannelli, una a maglie strette e una a maglie larghe;
- tramaglio incastellato: tramaglio nella parte inferiore, rete ad imbrocco nella parte superiore.

Strutture dei vari tipi di Tramaglio
Approfondimenti:
Di tutte le reti da posta, il tremaglio è quello meno selettivo. Impiegata nella pesca costiera, è una grande parete di rete che può essere sistemata appena al di sopra del fondo marino quando si vogliano pescare tipi di pesce demersale o comunque quando si vogliano pescare pesci pelagici ad una certa profondità dalla superficie.
Il tremaglio è confezionato con filato molto sottile e questo agevola l'ammagliamento del pesce al solo contatto con le pinne; per questo motivo tale attrezzo è considerato poco selettivo; generalmente viene ancorato in vicinanza del fondo.
Il tremaglio è una rete a maglia stretta formata da tre pezze (pannelli), delle quali le due esterne sono a maglie grandi (maglioni), mentre quella interna è a maglie più piccole. Il pesce viene catturato per ammagliamento dal pannello interno, dopo avere attraversato il primo pannello. Anche l’altezza delle tre pezze è diversa: quelle esterne sono uguali mentre quella centrale è notevolmente più alta e libera di muoversi tra le altre due. Ad ogni modo essa oscilla tra 1.5 m e 2 m. Il pesce, da qualunque parte esso provenga, può agevolmente superare la prima pezza ma, entrato a contatto con la seconda, trova in questa una specie di sacca e, nel tentativo di sfuggire, si impiglia sempre di più.
La parte superiore della rete è collegata a una lima da galleggianti mentre quella inferiore è connessa a una lima da piombi. L’azione combinata dei galleggianti e dei piombi mantiene lo stiramento verticale della rete.
I galleggianti sono in genere di forma ovoidale, lunghi 10 cm con 5 cm di diametro. I piombi, di norma situati in corrispondenza dei galleggianti, hanno forma cilindrica cava, lunghezza di 10 cm circa e peso di circa 170g.
Con tremagli da fondo viene usato un peso sufficiente a tenere la lima da piombi aderente sul fondo del mare mentre la galleggiabilità fornita dai galleggianti è sufficiente solo a mantenere la tensione verticale.
.bmp)
Sistema Tramaglio (pannello)
Nel caso di tremaglio a mezz’acqua, vengono usati galleggianti sufficienti per controbilanciare il peso della lima da piombi che viene usata per assicurare la verticalità della rete. I cavi connessi alle due lime, a ciascuna estremità della rete sono collegati a quelli che collegano le ancore in fondo al mare ai galleggiamenti in superficie che mostrano la posizione e l’estensione della rete e successivamente vengono utilizzati per il recupero della rete. Le reti vengono calate spesso in estate. Quando si raggiungono le zone di pesca si preparano un’ancora e un galleggiante. Si cala l’ancora e, mentre si posiziona il galleggiante, la nave si muove in avanti a una velocità di circa 3-5 nodi. Il tremaglio viene generalmente ancorato al fondo e viene impiegato per la cattura di pesce ad alto valore commerciale (sparidi, crostacei, pesci piatti, ecc.).
Più produttiva sui fondali rocciosi o misti, è per questo meno utilizzata nell’Adriatico, mentre mostra frequenze notevoli nel Tirreno, nello Ionio e nelle isole. Tra le specie più importanti nei mix di cattura del tramaglio si segnalano, in ordine di importanza economica: triglie, scorfani, seppie, merluzzi e aragoste, quest’ultime pescate con reti a maglia larga spesso denominate “tramaglioni”. Tra le catture accessorie hanno una certa rilevanza anche polpi, mormore, orate e spigole. I pesci più piccoli rimangono impigliati nello strato mediano mentre i pesci più grossi urtano contro lo strato mediano e lo fanno rientrare nelle maglie più larghe degli strati esterni rimanendo imprigionati in una specie di sacco.
Nessuna limitazione è stabilita per le dimensioni delle maglie delle reti adibite alla pesca di sardine o di acciughe.
Rete incastellata
Esiste infine una terza tipologia di rete da posta, spesso denominata come “rete incastellata”.
Questa rete combina i vantaggi delle due reti descritte precedentemente essendo formata nella parte superiore da una rete ad “imbrocco” (per la cattura dei pelagici) e nella parte inferiore da un “tremaglio” (per la cattura del pesce di fondo).
È abbastanza diffusa nel Tirreno, dalla Liguria al Lazio, rara o assente nelle altre regioni d’Italia: ciò potrebbe forse suggerirne una sperimentazione in aree di pesca con caratteristiche analoghe.
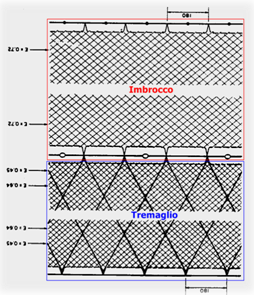
Sistema da posta (Incastellata)
Rete da posta derivante
Questi attrezzi operano in genere in superficie. Prevalentemente sono reti da imbrocco, costituite da uno o più pannelli, armate in alto ad una linea dei sugheri che permette il galleggiamento, ed in basso ad una linea dei piombi.
Il peso dei piombi neutralizza l’azione dei galleggianti facendo rimanere la rete in posizione verticale.
La rete viene tenuta ancorata al fondo mediante dei pesi o delle ancore.
I filamenti possono essere: monofilamento (filamenti singoli), multifilamento (elevato numero di fibre finissime) e multimonofilamento (unione di alcuni monofilamenti leggermente ritorti).
La posizione della rete viene segnalata in superficie, permettendone il recupero, mediante delle boe e delle bandierine.
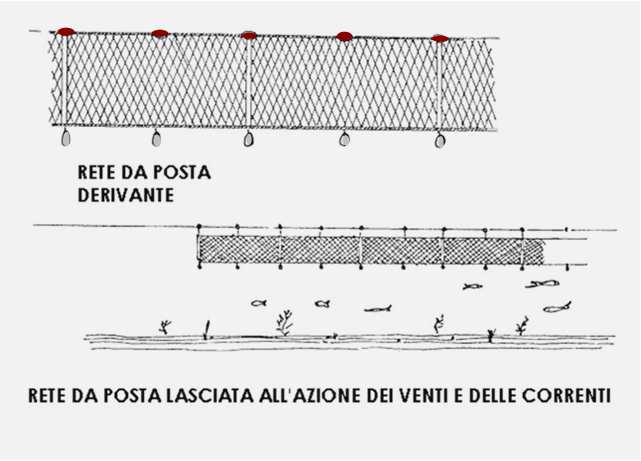
La rete viene lasciata in “pesca” per un periodo di tempo variabile, in genere nelle ore notturne, e poi recuperate. L’unità da pesca rimane comunque sempre collegata alla rete.
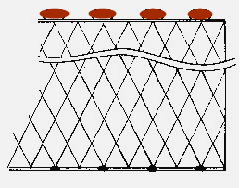 Rete da imbrocco
Rete da imbrocco
Rete circuitante
La «rete circuitante» è una normale rete da posta fissa (ad imbrocco) che invece di essere calata in mare in modo rettilineo, è calata in cerchio, o a semicerchio se in prossimità della costa.
Questo sistema di pesca, generalmente si usa in vicinanza della costa, con unità da pesca di piccole dimensioni, per catturare pesci che si trovano addensati in una spazio abbastanza ristretto.
Una volta che il cerchio è chiuso, l’unità si pone all'interno dello stesso ed inizia a produrre rumori per spaventare il pesce e indirizzarlo verso le pareti della rete.
Poco usata (2% a livello Italia), non deve confondersi con le “reti a circuizione”. Mantiene una certa diffusione solo in alcune marinerie della Liguria, della Calabria e del Medio Adriatico, mentre tende a scomparire nelle altre regioni d’Italia dove il numero di equipaggi che la impiegano non supera le 15 unità. Nel mix di cattura spicca per valore economico il pesce bianco.
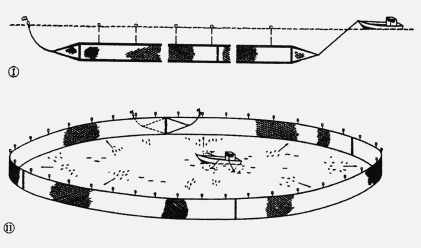
Schema sistema da posta (circuitante)
Sono da posta (imbrocco) a tutti gli effetti, calate in modo che le lime si dispongano circolarmente, così da imprigionare, all’interno del cilindro che si forma, i pesci che vengono poi spaventati in modo che indirizzarli verso le pareti della rete, nelle quali restino imbroccati o impigliati.
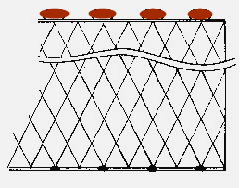 Rete da imbrocco
Rete da imbrocco
Disciplina del sistema reti da posta
E' consentito l’impiego di tutti i tipi di rete da posta (imbrocco, tramaglio o incastellata) sia fisse che derivanti (D.P.R. 1639/68 – Reg. CE 1967/06).
- Imbrocco (Reg. CE 1967/06):
-
la lunghezza massima per le reti ad imbrocco è fissata a 4 Km. (se 1 pescatore), a 5 Km. (se 2 pescatori), a 6 Km. (se 3 pescatori) per unità e l’altezza non superiore a 10 metri ovvero a 30 metri se la lunghezza della rete non supera i 0,5 Km.
- l’apertura della maglia non deve essere inferiore ai 16 mm. e il diametro del filo non inferiore ai 0,5 mm.
- Tramaglio:
-
la lunghezza massima per le reti tramaglio è fissata a 4 Km. (se 1 pescatore), a 5 Km. (se 2 pescatori), a 6 Km. (se 3 pescatori) per unità e l’altezza non superiore a 4 metri (Reg. CE 1967/06):
- l’apertura della maglia non deve essere inferiore ai 20 mm (D.P.R. 1639/68).
- Rete incastellata o combinata:
-
la lunghezza massima per le reti incastellate è fissata a 2,5 Km. per unità e l’altezza non superiore a 10 metri ovvero a 30 metri se la lunghezza della rete non supera i 0,5 Km. (Reg. CE 1967/06):
-
l’apertura della maglia del pannello imbrocco non deve essere inferiore ai 16 mm. (Reg. CE 1967/06) mentre quella del pannello a tramaglio non deve essere inferiore ai 20 mm. (D.P.R.. 1639/68).
- il diametro del filo per il pannello dell’imbrocco non deve essere inferiore ai 0,5 mm. (Reg. CE 1967/06).
► E’ vietato l’uso di tutte le reti da fondo per la cattura delle seguenti specie (Reg. CE 1967/06):
-
tonno rosso (Thunnus thynnus);
-
tonno bianco (Thunnus alalunga);
-
pesce spada (Xiphias gladius);
-
pesce castagna (Brama brama);
- squali (Hexanchus griseus; Chetorhinus maximus; Alopiidae; Carcharhinidae; Sphirnidae; Isuridae e Lamnidae)
A titolo di deroga, le catture accessorie accidentali di non più di 3 esemplari delle specie di squali suddette possono esere detenute a bordo o sbarcate purché non si tratti di specie protette ai sensi del diritto comunitario.
- Rete circuitante:
La rete circuitante deve avere altezza pari a 10 metri (Reg. CE 1967/2006). pertanto non deve essere confusa con una rete a circuizione (sistema di pesca diverso indicato in licenza) perché quest’ultima, per ragioni puramente geometriche, deve avere necessariamente altezza superiore a 10 metri.
Segnalazioni delle reti da posta: D.P.R. 1639/68
Le reti da posta devono essere muniti di “segnali” costituiti da «galleggianti di colore giallo», distanziati fra, loro non più di 200 metri. Le estremità dell'attrezzo debbono essere munite di «galleggianti di colore giallo» con bandiere di giorno, e fanali di notte, dello stesso colore; tali segnali debbono essere visibili a distanza non inferiori a mezzo miglio.
Le reti da posta sono contrassegnate, “di giorno”,
con corpi galleggianti gialli in numero sufficiente ad indicarne la posizione
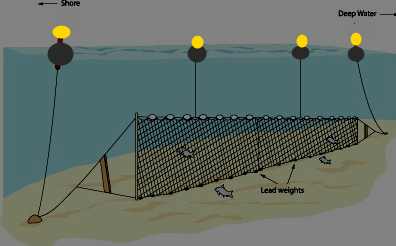
Le reti da posta sono contrassegnate, “di notte”, con luci ordinarie gialle
in numero sufficiente ad indicarne la posizione
È vietato collocare reti da posta ad una distanza inferiore a 200 metri dalla congiungente i punti più foranei, naturali o artificiali, delimitanti le foci e gli altri sbocchi in mare dei fiumi o di altri corsi di acqua o bacini.
Segnalazioni reti da posta: Reg. (CE) n. 356/2005
Per le reti calate "oltre le 12 miglia" nautiche misurate dalle linee di base dello Stato costiero, il Regolamento (CE) n. 356/2005, (che stabilisce le modalità d’applicazione per la marcatura e l’identificazione di attrezzi da pesca fissi e sfogliare) modificato dal Reg. (CE) n. 1805/2005, prevede ai fini del controllo e la sorveglianza delle attività di pesca, le modalità d’applicazione per la “marcatura” e la “identificazione” degli attrezzi da pesca detenuti a bordo o utilizzati nelle acque comunitarie.
- Ogni attrezzo fisso utilizzato per la pesca ha l’obbligo di esporre, in forma permanente, le “lettere” e i “numeri di registrazione” esterni riportati sullo scafo del pescherecio cui appartiene:
- su una «Targhetta» fissata sulla prima fila superiore a entrambe le estremità di ciascun attrezzo fisso;
Posizionamento delle “targhette” sulla lima da sughero alle estremità dell’attrezzo.
Il cavo è di materiale sommergibile o provvisto di pesi
- per gli attrezzi fissi di estensione «superiore a un 1 miglio» nautico, su targhette fissate sulla prima fila dell’attrezzo fisso ad intervalli regolari non superiori a un 1 nautico, in modo da non lasciare senza contrassegno nessuna parte dell’attrezzo di estensione superiore ad 1 miglio nautico.
.png)
Posizionamento delle “targhette” fissate sulla lima da sughero ad intervalli regolari
non superiore a 1 miglio nautico per gli attrezzi di estensione superiore a 1 miglio nautico.
I «cavi» che collegano le boe all’attrezzo fisso sono di materiale sommergibile oppure debbono essere provvisti di pesi
- Agli attrezzi fissi di estensione«superiore a 5 miglia» nautiche sono fissate “boe segnaletiche intermedie”:
-
a distanze non superiori a 5 miglia nautiche, in modo da non lasciare senza contrassegno nessuna parte dell’attrezzo di estensione pari o superiore a 5 miglia nautiche;
- di caratteristiche identiche a quelle della boa segnaletica situata all’estremità nel settore orientale, tranne per il fatto che la bandierina è di colore “bianco”.
Agli attrezzi fissi di estensione superiore a 5 miglia nautiche sono fissate “boe segnaletiche intermedie”
ad intervalli regolari non superiore a 5 miglia nautiche.
- Le «boe segnaletiche intermedie» hanno caratteristiche identiche a quelle della boa segnaletica situata all’estremità nel settore orientale, tranne per quanto in appresso specificato:
-
la bandierina è di colore bianco;
- una boa segnaletica intermedia ogni cinque è dotata di un riflettore radar con una portata di almeno 2 miglia nautiche.
-
Le «boe segnaletiche situate alle estremità» sono usate in modo tale da permettere di individuare in qualsiasi momento ciascuna estremità dell’attrezzo.
L’asta di ogni boa segnaletica situata all’estremità ha un’altezza di almeno 1,5 metri dal livello del mare, misurata dal punto più alto del galleggiante.
Le boe segnaletiche situate all’estremità sono colorate, ma non di color rosso o verde.
Ogni boa segnaletica situata all’estremità è composta da:
-
una o due bandierine rettangolari, i cui lati misurano almeno 40 cm; qualora siano necessarie due bandierine sulla stessa boa, la distanza fra queste è di almeno 20 cm.; la distanza tra il pelo dell’acqua e la prima bandierina è di almeno 80 cm.; le bandierine che indicano le estremità della stessa rete sono dello stesso colore, che non può essere bianco, e delle stesse dimensioni;
-
una delle due luci, di colore giallo, che lampeggiano ogni 5 secondi (F1 Y5s) e sono visibili da una distanza di almeno 2 miglia nautiche;
-
un segnale all’estremità superiore della boa, costituito da una sfera avente un diamtero di almeno 25 centimetri sulla quale sono poste una o due bande luminose che non possono essere di colore rosso o verde e devono avere una larghezza di almeno 6 centimetri. Un riflettore radar sferico può essere utilizzato quale segnale dell’estremità superiore della boa;
- riflettori radar con una potenza di almeno 2 miglia nautiche.
Le boe segnaletiche situate alle estremità sono fissate agli attrezzi fissi nel seguente modo:
-
la boa nel settore occidentale (ossia la zona delimitata sulla bussola dal semicerchio che va da sud a ovest, compreso il nord) è attrezzata con due bandierine, due bande luminose a strisce, due luci e una targhetta conforme;
- la boa nel settore orientale (ossia la zona delimitata sulla bussola dal semicerchio che va da nord a est, compreso il sud) è attrezzata con una bandierina, una banda luminosa a striscie, una luce e una traghetta conforme.
Boe segnaletiche: peculiarità
- Le «boe segnaletiche intermedie» hanno caratteristiche identiche a quelle della boa segnaletica situata all’estremità nel settore orientale, tranne per quanto in appresso specificato:
-
la bandierina è di colore bianco;
- una boa segnaletica intermedia ogni cinque è dotata di un riflettore radar con una portata di almeno 2 miglia nautiche.
- Le «boe segnaletiche situate alle estremità» sono usate in modo tale da permettere di individuare in qualsiasi momento ciascuna estremità dell’attrezzo.
L’asta di ogni boa segnaletica situata all’estremità ha un’altezza di almeno 1,5 metri dal livello del mare, misurata dal punto più alto del galleggiante.
Le boe segnaletiche situate all’estremità sono colorate, ma non di color rosso o verde.
Ogni boa segnaletica situata all’estremità è composta da:
-
una o due bandierine rettangolari, i cui lati misurano almeno 40 cm; qualora siano necessarie due bandierine sulla stessa boa, la distanza fra queste è di almeno 20 cm.; la distanza tra il pelo dell’acqua e la prima bandierina è di almeno 80 cm.; le bandierine che indicano le estremità della stessa rete sono dello stesso colore, che non può essere bianco, e delle stesse dimensioni;
-
una delle due luci, di colore giallo, che lampeggiano ogni 5 secondi (F1 Y5s) e sono visibili da una distanza di almeno 2 miglia nautiche;
-
un segnale all’estremità superiore della boa, costituito da una sfera avente un diamtero di almeno 25 centimetri sulla quale sono poste una o due bande luminose che non possono essere di colore rosso o verde e devono avere una larghezza di almeno 6 centimetri. Un riflettore radar sferico può essere utilizzato quale segnale dell’estremità superiore della boa;
- riflettori radar con una potenza di almeno 2 miglia nautiche.
Le boe segnaletiche situate alle estremità sono fissate agli attrezzi fissi nel seguente modo:
-
la boa nel settore occidentale (ossia la zona delimitata sulla bussola dal semicerchio che va da sud a ovest, compreso il nord) è attrezzata con due bandierine, due bande luminose a strisce, due luci e una targhetta conforme;
- la boa nel settore orientale (ossia la zona delimitata sulla bussola dal semicerchio che va da nord a est, compreso il sud) è attrezzata con una bandierina, una banda luminosa a striscie, una luce e una traghetta conforme.
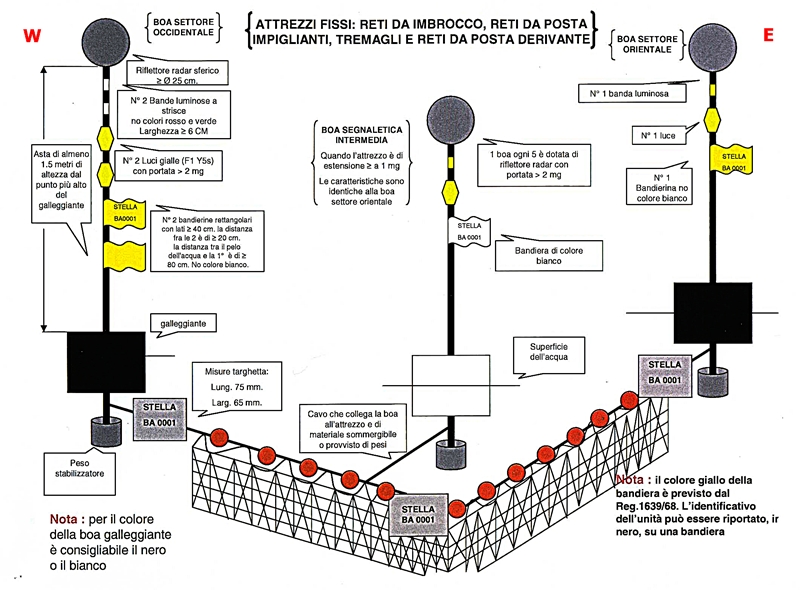
Caratteristiche delle boe segnaletiche situate alle estremità e delle boe segnaletiche intermedie
Sistema Trappole
L’uomo nella sua storia ha inventato innumerevoli tipi di “trappole” per catturare le prede di cui aveva bisogno per nutrirsi. Le trappole per la cattura del pesce sono quanto di più ingegnoso si può trovare, sia come concezione della trappola, di metodi cioè adottati per invogliare l’ingresso ed impedire l’uscita, sia come materiali utilizzati nella costruzione della trappola, sia infine come esche per attirare il pesce. In ogni zona vi sono tipi particolari di trappole diverse sia in funzione della specie e dei fondali in cui si opera sia in funzione dei materiali.
- Possiamo fare una distinzione di trappole:
-
Trappole (reti a postazione fissa)
- Trappole mobili
Le «trappole a postazione fissa» sono calate in un punto scelto sulla base della esperienza ed ivi lasciate per tutta la stagione di pesca. Il calo in ogni modo è un’operazione piuttosto delicata e laboriosa. E’ necessario un sistema di ancoraggio sicuro cui fissare le varie parti dell’attrezzo; è necessario conoscere le correnti prevalenti nella zona in cui si opera; è necessario conoscere la normale direzione dei pesci che si vogliono catturare in modo da disporre il braccio di incanalamento nella giusta posizione cioè in posizione che convogli il pesce verso l’attrezzo e non viceversa.
Nelle reti a postazione fissa, l’ingresso deve essere facile ed invitante, l’uscita in pratica impossibile. Per questo molto spesso si hanno vari ingressi consecutivi sempre più sicuri da cui è impossibile e difficile uscire. L’ultima camera dell’attrezzo è la camera della morte, dove il pesce resta fino che il pescatore salpi la rete e lo prelevi.
Le reti a postazione fissa normalmente non sono innescate, sfruttano solo le abitudini o le migrazioni dei pesci, note per la lunga esperienza ai pescatori.
Le trappole fisse di cui le più note sono la “tonnara” per la cattura del tonno rosso e il “lavoriero” per la cattura delle anguille, cefali, spigole e orate, sono caratterizzate da avere una postazione fissa, e di essere mantenute per una stagione di pesca o per un tempo più lungo quando si tratta di strutture complesse.
Sono collocate i specifiche aree di pesca dove sfruttano determinati comportamenti della specie bersaglio.
Sia nel caso della tonnara che del lavoriero è l’istinto delle specie a riprodursi che la porta ad incontrare questi attrezzi sul suo cammino.
Nel caso del tonno, avvicinandosi alla costa dalle acque al largo, nel caso dell’anguilla nel tentativo di raggiungere il mare dalle acque dolci o salmastre dove vive.
Le «trappole mobili», sono attrezzi passivi che a differenza di quelle fisse, vengono salpate e controllate ogni 1 o 2 giorni ed eventualmente spostate in un’altra area di pesca (Nasse, cogolli e bertovelli). L’impiego di tali attrezzi richiede un’approfondita conoscenza delle zone e del comportamento delle specie bersaglio perché la pesca risulti redditizia.
- Sistema attrezzi da posta: Trappole (peculiarità):
-
Sono attrezzi passivi poiché vengono lasciati nell’area di pesca e attendono che la preda vada ad incappare nell’attrezzo.
-
Possiamo fare una distinzione di Trappole a postazione fissa (Tonnara fissa, Lavoriero, Saltarello e Mugginara) e Trappole mobili (Nasse, Cogolli e Bertovelli).
-
Le “trappole a postazione fissa” sono calate in un punto scelto sulla base della esperienza ed ivi lasciate per tutta la stagione di pesca.
-
La Tonnara è la maggiore fra tutte le reti da posta fissa. E’ un impianto di sbarramento, un labirinto composto di reti ancorate sul fondo del mare che obbligano i tonni a finire in una trappola costituita da diversi corridoi e camere, la cui disposizione viene segnalata in superficie da boe.
-
Le “trappole mobili” sono attrezzi salpati e controllati ogni 1 o 2 giorni ed eventualmente spostate in un’altra area di pesca.
-
L’impiego di tali attrezzi richiede un’approfondita conoscenza delle zone e del comportamento delle specie bersaglio perché la pesca risulti redditizia.
- Attrezzo tipico della pesca artigianale, è la Nassa, costruito con materiali diversi (vimini, giunco, legno, ferro e plastica). Sono in pratica delle gabbie nelle quali le prede potenziali vengono incoraggiate con esche ad entrare e dalle quali non sono più in grado di uscire.
Trappole fisse: tonnara
Non è certo possibile confondere la «tonnara» con un altro attrezzo da pesca. Le stesse dimensioni sono tali da non lasciare dubbi. Gli impianti fissi per la cattura del tonno sono chiamati “tonnare per mattanza”.
E’ la maggiore fra tutte le reti da posta fissa. Le zone poi dove sono calate le tonnare sono molto note da lungo tempo ormai. La cosa più difficile oggi è trovare la tonnara. Questo attrezzo da pesca ormai è ridotto a poche unità. La cattura si svolge in diversi momenti tutti collegati fra loro ma distinti. I tonni oggi si catturano con la tonnara volante.
La tonnara è un impianto di sbarramento, un labirinto composto di reti ancorate sul fondo del mare che obbligano i tonni a finire in una trappola costituita da diversi corridoi e camere, la cui disposizione viene segnalata in superficie da boe.
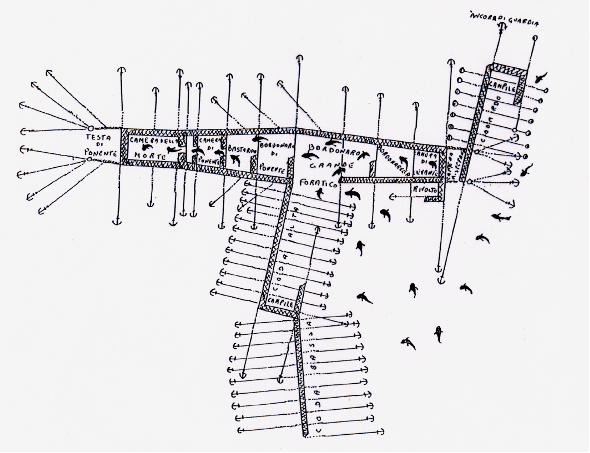
Schema Tonnara per tonno rosso
La tonnara è costituita da una rete verticale detta “pedale”, che partendo dalla costa si dirige verso il largo con una direzione quasi perpendicolare al litorale; al largo si trova un insieme di reti verticali che costituiscono un complesso chiamato “isola”, formata da numerose camere da 4 a 9, tutte, tranne l'ultima, non hanno fondo e sono divise tra loro da apposite porte.
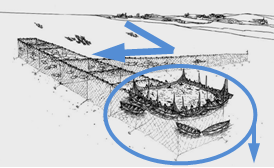
Tonnara (Camera della morte)
Il tonno avvicinandosi alla costa trova uno sbarramento costituito da reti che formano
un vero e proprio muro che lo costringe ad entrare in un labirinto di camera fino a quella finale (della morte)
Disciplina del sistema tonnara
- Distanze per l'impianto
L'impianto di una tonnara, non può essere consentito se non a distanza di 3 miglia marine sopra vento e di 1 miglio marino sottovento da altre preesistenti, salvo che i proprietari o i concessionari abbiano diritto a maggiori distanze in forza di titoli particolari. Tali distanze debbono essere osservate negli eventuali spostamenti di tonnare.
- Segnalazione delle tonnare
La tonnara deve essere segnalata con unità o galleggianti ancorati al largo della sua parte centrale foranea.
Su tali barche devono essere collegati i seguenti segnali:
-
di notte: due fanali disposti verticalmente e visibili per tutto il giro dell'orizzonte (rosso il superiore a non meno di 5 metri sul livello del mare, bianco l'inferiore, a non meno di 2 metri dal superiore, con portata luminosa, per entrambi, non inferiore alle 2 miglia);
- di giorno: due palloni, il superiore rosso e l'inferiore bianco, alzati al posto dei fanali predetti e visibili alla distanza non inferiore a 2 miglia.
- Limitazioni per altre attività di pesca
Durante il periodo di funzionamento della tonnara, sia di corsa che di ritorno, è vietato l'esercizio di ogni altra forma di pesca a distanza minore di 3 miglia sopravento e di un miglio sottovento dalla tonnara stessa, salvo che i proprietari o i concessionari abbiano diritto a maggiori distanze in forza di titoli particolari.
È altresì vietato l'esercizio di qualsiasi altra forma di pesca nella zona di tre miglia verso l'alto mare dal punto più foraneo di ciascuna tonnara.
- Tonnarelle
Durante il periodo di funzionamento della tonnarella è vietato l'esercizio di ogni altra forma di pesca a distanza minore di 500 metri sopravento e di 200 metri sottovento dalla tonnarella stessa, salvo le maggiori distanze cui i proprietari o i concessionari abbiano diritto in forza di titoli particolari.
È altresì vietato l'esercizio di ogni altra forma di pesca nella zona di 500 metri verso l'alto mare, misurata dal punto più foraneo di ciascuna tonnarella.
Le distanze suindicate raddoppiate per la pesca esercitata con fonti luminose.
(1).png)
Un momento della mattanza
Trappole mobili: cogollo
Il cogollo è un attrezzo da pesca ormai in disuso. Si utilizza per la pesca in laguna e nelle acque basse costiere.
Viene ancorato a tre pali infissi sul fondo, due dal lato della bocca ed uno in fondo all'attrezzo. Nei pressi della bocca, legati ai due pali anteriori, vi sono due braccia di incanalamento formate da due pezzi di rete rettangolare, la bocca è rigida e ha di forma circolare.
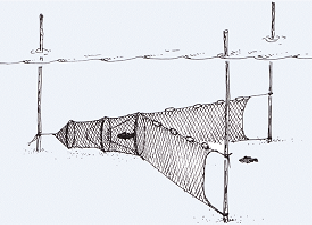
Cogollo
A partire dalla bocca si susseguono diverse camere a forma di imbuto con l'ingresso che si stringe sempre di più fino all'ultima camera, dove il pesce rimane prigioniero.
In mare il cogollo è generalmente calato in prossimità della riva; a volte la parte superiore dell’attrezzo è ben visibile a pelo d’acqua.
In ogni caso la sagoma permette di evidenziare il braccio (o i bracci) di incanalamento, la prima bocca d’ingresso e il corpo dell’attrezzo. Il sacco è segnalato da un galleggiante per permettere il periodico prelievo del pescato.
.bmp)
Schema: Il cogollo (da: FAO-Catalogue Small Scale Fishing gear, 1987, modificato)
Trappole fisse: lavoriero
Il «Lavoriero» è un impianto fisso destinato alla cattura dei pesci maturi che dalla laguna o dalle foci dei fiumi tornano al mare per riprodursi.
E’una costruzione complessa e delicata a forma di doppio cuneo e può essere considerato una grande trappola.
E' costituito da diverse camere che guidano il pesce in comparti sempre più stretti, dove è più facile la cattura; è costruito in modo tale da permettere sempre la risalita del novellame dal mare verso la laguna. Principalmente viene usato per la cattura delle anguille (quando attratte dall’acqua salata che entra dai canali nelle valli, cercano di guadagnare il mare per la riproduzione dopo il periodo di crescita ed ingrasso in valle) anche se in camere separate vi restano imprigionati altre specie di pesce quali i cefali e spigole.
Questo metodo di pesca sfrutta i movimenti migratori di massa delle specie che si riproducono in mare e maturano nelle acque interne: in primavera anguille, cefali, spigole e orate entrano in valle allo stadio di novellame, mentre in autunno gli adulti sessualmente maturi sono richiamati al mare dove si riprodurranno. La pesca avviene, quindi, in autunno durante la migrazione riproduttiva. A febbraio, si aprono le chiaviche per effettuare il ricambio dell’acqua salata delle valli e viene fatta la semina del pesce, in quanto l’entrata naturale del novellame dal mare è scarsa. In marzo vengono seminati gli individui giovani di anguille (Anguilla anguilla), delle diverse specie di cefali (Mugil cephalus, Chelon labrosus, Liza sp.), di orate (Sparus aurata) e di spigole (Dicentrarchus labrax). Nel lavoriero particolari incannicciate (grisole), infisse nel fondo lagunare e sostenute da un’intelaiatura di pali e pertiche, delimitano un perimetro cuneiforme nel quale una serie di bacini triangolari, come punte di freccia, comunicanti fra loro, consentono la cattura differenziata del pesce.
Nel corso del tempo, dal lavoriero primitivo di canna si è passati a quello moderno in cemento e metallo, più facile e rapido da costruir.
(1).png)
Lavoriero
Trappole fisse: mugginara e saltarello
La «mugginara» è una rete a trappola con cui si pratica una pesca a vista: si tratta di una sorta di tonnarella dove una rete viene calata tra la costa e due barche ancorate a formare una camera, regolata di giorno in giorno, a seconda dell’intensità della corrente da cavi che partono da terra e dai natanti.
La mugginara porta sulla parte superiore, al di sopra dei sugheri, una pezza supplementare di rete disposta parallelamente al pelo dell'acqua.
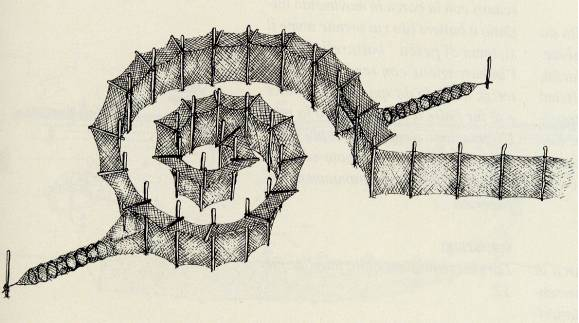
Schema di Mugginara
Questa rete viene utilizzata per la cattura di cefali in acque lagunari e viene utilizzata spaventando i pesci colpendo l'acqua con bastoni, i cefali, molto agili, saltano fuor d'acqua per scavalcare la rete e restano ammagliati nella pezza orizzontale. Viene chiamata per questo motivo anche rete a battere. Durante il periodo di funzionamento della mugginara, è vietato l'esercizio di ogni altra forma di pesca a distanza minore di 100 metri dalla mugginara stessa.
- Saltarello
E' una trappola particolare destinata soprattutto alla cattura dei cefali. È costituita da pezzi di rete chiamate “braccia”, assemblate su pali infissi nel fondale, sistemati in modo da fare assumere al saltarello una forma a spirale detta “corte”, che impedisce al pesce di retrocedere una volta entrato.
Lungo tutto il perimetro, in superficie, è posto un tremaglio in senso orizzontale detto “incannata” e sul fondo vengono posizionati alcuni cogolli.
L'incannata serve per catturare i pesci che tentano la fuga saltando, mentre i cogolli per catturarne altri che preferiscono tentare la via di fuga dal basso.
Trappole mobili: bertovello
Il bertovello è una nassa fatta di rete fissata a cerchi di plastica.
E' costituito da camere a forma di “cono” l'uno dentro l'altro, che consentono al pesce di muoversi solo verso l'interno intrappolandolo. Quando non è in pesca può essere chiusa a fisarmonica occupando pochissimo spazio a bordo.
In genere i bertovelli vengono immersi in serie.
(1).png)
Bertovello
Trappole mobili: nasse
Attrezzo tipico della pesca artigianale, costruito con materiali diversi (vimini, giunco, legno, ferro e plastica). Sono in pratica delle gabbie nelle quali le prede potenziali vengono incoraggiate con esche ad entrare e dalle quali non sono più in grado di uscire.
Le Nasse sono attrezzi “passivi” dove la cattura avviene per intrappolamento del pesce in una parte dell’attrezzo da cui gli è praticamente impossibile sfuggire. L’incanalamento del pesce verso questo punto si ottiene in genere per mezzo di esche poste al suo interno. Vengono usate per la cattura di una varietà enorme di specie che vanno dai pesci ai crostacei e ai molluschi. Normalmente vengono ancorate al fondo marino per mezzo di pesi e segnalate in superficie con corpi galleggianti per facilitarne l’avvistamento ed il successivo recupero.
Le dimensioni non sono elevate e a volte vengono calate in mare non ad una ad una, ma legate insieme a distanza fissa, ad una corda chiamata “madre” o “trave”.
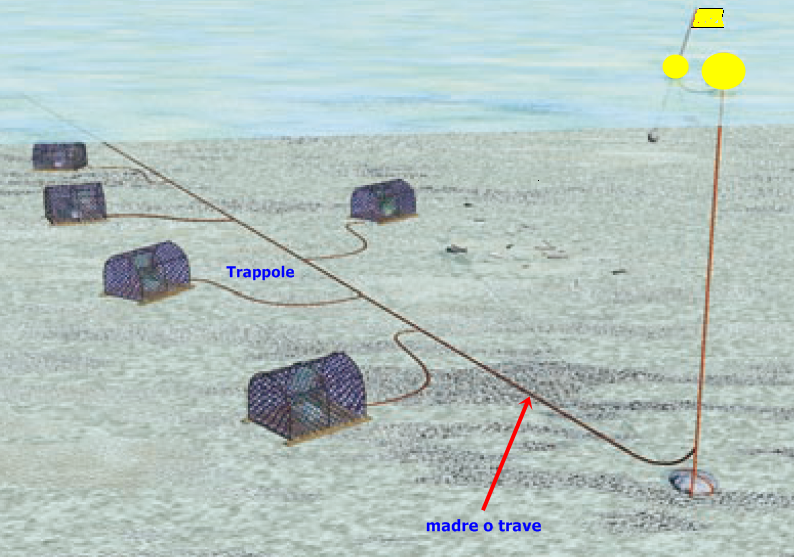
Sistema da posta (nasse)
Approfondimenti:
Questo attrezzo è utilizzato soprattutto dalla piccola pesca, ne esistono tipi diversi con diverse forme legate alla costruzione che fino a qualche tempo fà era di tipo artigianale. A seconda delle diverse marinerie e delle regioni italiane potevano essere di legno armate con una rete di metallo o di vimini intrecciato. Fino a pochi anni fa soprattutto in Adriatico, venivano utilizzate nasse a forma di parallelepipedo, all'interno delle quali venivano posti dei rametti di alloro per la cattura delle seppie. Questo tipo di pesca viene effettuata quando le seppie si avvicinano alla costa durante il periodo riproduttivo; i ramoscelli di alloro, servono per attirare la seppia che li utilizza come substrato per deporre le uova. Oggi queste nasse sono state sostituite ormai del tutto dai “bertovelli”. Altre specie catturabili sono saraghi, anguille, gronchi, cefalopodi (seppie, polpi), crostacei (granchi, aragoste e gamberi).
Un altro tipo di nassa è il “cestino”. Il cestino è una piccola nassa a forma di tronco di cono che serve per la cattura dei lumachini ed altri gasteropodi; il cestino è rivestito da una rete a maglie piccole con l'apertura nella parte superiore. Come esca in genere viene usato del pesce morto poco pregiato. I lumachini attratti dall'esca salgono facilmente lungo le pareti esterne, ma una volta entrati, non sono più in grado di risalire in senso inverso.
La nassa è una sorta di cesta usata per la pesca. Può essere a rete (nassa a rete) (a), a grata (nassa metallica) (b) o a intreccio (nassa a canestro) (c). L’apertura si stringe verso l’interno a forma d’imbuto (d) e fa sì che l’organismo oggetto di pesca, una volta entrato, non possa più uscirne. Viene calata sui fondi più diversi e segnalata in superficie con galleggianti.
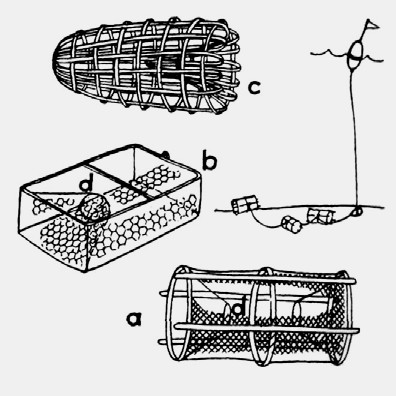
Nasse (tipologie)
Le nasse sono utilizzate per la cattura delle seppie durante il periodo riproduttivo, i cogolli, o bertovelli, vengono impiegati per la pesca delle anguille, dei crostacei, delle seppie e di piccoli pesci.
Tra gli altri attrezzi da posta, si assiste ad un recupero del mestiere delle nasse, che alcuni autori indicano come un’arte caduta progressivamente in disuso dalla fine dell’ultima guerra, ma comunque praticata da medie e piccole imbarcazioni.
Tra le specie catturate con le nasse, quelle che più pesano sul ricavo totale sono polpi, seppie, pannocchie e gamberi rossi.
Una realtà produttiva importante nell’Alto e Medio Adriatico, con una particolare diffusione in Emilia Romagna, è infine la pesca con i cestelli per lumachini, questi ultimi considerati a ragione una importante risorsa locale. Praticata da piccole imbarcazioni dotate di motore fuoribordo, questa tecnica è utilizzata da alcune migliaia di operatori soprattutto nei mesi invernali.
Nelle stagioni primaverile ed estiva è invece più frequente la pesca con i cogolli, essenzialmente mirata alla cattura di seppie.
Disciplina sistema trappole
La normativa relativa alle Trappole in generale si basa, a livello Compartimentale, sul DM 14/9/99 della “Piccola pesca” che prevede piani di gestione degli specchi acquei e delle risorse, ma anche sulle “Ordinanze” locali emesse dalle singole Capitanerie di Porto relative ad attrezzi specifici e a determinate specie.
Le unità da pesca che attuano tale tipo di pesca fanno parte in genere della piccola pesca o pesca artigianale e quindi le dimensioni devono essere LFT inferiore a 12 e comunque di TSL inferiore a 10.
La distanza minima dalla costa non è soggetto a normativa (come per la piccola pesca) ma viene stabilita con Ordinanze delle locali Capitanerie di Porto.
- La pesca dell’aragosta e dell’astice, con qualunque sistema, è vietata da gennaio ad aprile, mentre per le seppie la pesca con attrezzi fissi è disciplinata dal Capo del compartimento marittimo.
- Anche la pesca della “lumachina” di mare è disciplinata a livello locale come periodo e quantitativi massimi pescabili al giorno.
- Trappole per la pesca dei crostacei di profondità: è vietato detenere a bordo o calare più di 250 trappole per peschereccio.
(1).png)
Sistema reti da posta derivanti
Per «reti da posta derivanti» si intendono tutte quelle reti che non vengono ancorate al fondo ma sono lasciate libere di muoversi in balìa delle correnti: grazie a dei galleggianti vengono tenute sopra o appena sotto la superficie dell'acqua.
La loro altezza varia a seconda del tipo di pesca, ma per le grandi reti è generalmente compresa fra i 20 e i 30 metri. Alla parte inferiore della rete sono attaccati dei pesi che la mantengono in verticale neutralizzando la spinta dei galleggianti.
Le reti possono andare alla deriva da sole oppure, più comunemente, sono trainate da unità in movimento a cui è fissata una loro estremità.
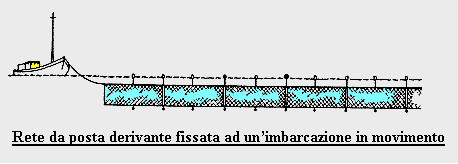
In genere vengono calate di notte, almeno per la cattura delle specie di grandi dimensioni, e sono destinate di norma alla pesca di specie pelagiche: pesci che nuotano vicino alla superficie, come le sardine, le aringhe, il tonno, il pesce spada e il salmone.
Un’estremità della rete è collegata ad un galleggiante mentre l’altra è collegata alla unità stessa.
Dato che questo sistema di pesca si effettua in vicinanza della superficie è necessaria un’ottima segnalazione e un’accurata sorveglianza al fine di evitare incidenti con la navigazione marittima.
- Fanno parte di questo sistema di pesca due particolari tipi di rete ad imbrocco:
-
spadara
- alalungara
Generalmente le reti derivanti sono ad “imbrocco” non a tramaglio. Questi attrezzi sono abbastanza simili fra loro e si differenziano dalle altre reti ad imbrocco per la grandezza delle maglie e lo spessore del filato, molto più grosso.
Approfondimenti:
L'Unione europea vieta le reti da posta derivanti. Nella riunione dell'8 giugno 1998 il Consiglio dei Ministri ha preso una decisione difficile, ma necessaria: quella di vietare l'uso di reti da posta derivanti per la cattura del tonno nell'Atlantico e nel Mediterraneo a decorrere dal 1° gennaio 2002. La decisione è stata presa tenendo conto di una serie di fattori di natura biologica, economica e sociale. Viene vietata una tecnica di pesca, quella delle reti da posta derivanti, e non la pesca del tonno, che potrà continuare ad essere praticata con tecniche più sicure, più selettive ed interessanti dal punto di vista economico. A breve termine, questo divieto potrà avere ripercussioni economiche e sociali negative per le collettività interessate, ma lo status quo avrebbe avuto conseguenze ancora più gravi. Per aiutare queste collettività nel loro processo di transizione verso tecniche più sicure l'Unione europea, in cooperazione con gli Stati membri, adotterà le misure necessarie affinché queste ripercussioni siano ridotte al minimo.
Che cosa sono le reti da posta derivanti ?
Le reti da posta derivanti sono reti che grazie a dei galleggianti vengono tenute sopra o appena sotto la superficie dell'acqua. La loro altezza varia a seconda del tipo di pesca, ma per le grandi reti è generalmente compresa fra i 20 e i 30 metri. Alla parte inferiore della rete sono attaccati dei pesi che la mantengono in verticale neutralizzando la spinta dei galleggianti. Le reti possono andare alla deriva da sole oppure, più comunemente, sono trainate dall'imbarcazione in movimento a cui è fissata una loro estremità. In genere vengono calate di notte, almeno per la cattura delle specie di grandi dimensioni, e sono destinate di norma alla pesca di specie pelagiche: pesci che nuotano vicino alla superficie, come le sardine, le aringhe, il tonno, il pesce spada e il salmone.
Quali sono i principali problemi connessi a questo tipo di pesca ?
L'accusa che viene mossa alle reti da posta derivanti è quella di non essere sufficientemente selettive e di intrappolare un numero inaccettabile di cetacei, mammiferi marini, uccelli e rettili.
All'origine le reti da posta derivanti venivano utilizzate per catturare specie di piccole dimensioni e non davano luogo a preoccupazioni. Nel Mediterraneo, ad esempio, questa tecnica è stata a lungo impiegata per pescare diverse specie di tonnidi con reti di lunghezza limitata. I problemi sono sorti quando le reti derivanti sono state modificate allargandone le maglie in modo da permettere la cattura di specie più grandi ed aumentandone le dimensioni globali al fine di massimizzare le catture. L'uso di queste grandi reti si è prima affermato nel Pacifico, per poi estendersi alla pesca del tonno dell'Atlantico. Anche se la natura e il volume delle catture di specie che non sono specie bersaglio - e cioè le catture accessorie (specie catturate accidentalmente) - variano a seconda del modello delle reti, del tipo di pesca e delle zone in cui si utilizzano, le reti con maglie più larghe e di maggiori dimensioni sono risultate fatali per moltissime specie.
Per venire incontro alle preoccupazioni espresse dall'opinione pubblica, le Nazioni Unite (NU) all'inizio degli anni '90 approvarono una risoluzione che chiedeva una moratoria dell'impiego delle grandi reti da posta derivanti. Da parte sua il Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, con l'appoggio del Parlamento europeo, decise di imporre un limite massimo di 2,5 km per le reti da posta derivanti utilizzate dalle imbarcazioni dell'UE. (Questa misura, così come la moratoria delle NU, non si applicava al Mar Baltico).
I problemi però non sono cessati perché, nonostante i sensibili miglioramenti registrati nell'Atlantico, hanno continuato a prodursi una miriade di casi di inosservanza delle norme sulla lunghezza massima. Un controllo effettivo dell'applicazione di questa norma in mare presenta molti problemi pratici e richiede altresì ingenti risorse finanziarie e disponibilità di personale, con un livello di spesa difficile da sostenere sul lungo periodo sia per l'UE che per i singoli Stati membri. Così, nonostante la normativa esistente, la pesca con le reti da posta derivanti ha continuato ad espandersi. Preoccupata per gli effetti di questa pressione crescente sulle risorse ittiche e per il conseguente aumento del volume delle catture accessorie, la Commissione propose nel 1994 di vietare le reti da posta derivanti, divieto che sarebbe diventato effettivo di lì a qualche anno, ma gli Stati membri non si ritennero in condizione di adottare tali proposte.
Dopo qualche difficoltà di adattamento al limite dei 2,5 km, le tonniere dell'Atlantico sono riuscite ad aumentare la loro efficienza e dopo un certo tempo questa tecnica è risultata la più produttiva. Tuttavia nel giugno 1998 la maggioranza degli Stati membri ha deciso che, tutto considerato, era venuto il momento di vietare l'uso delle reti da posta derivanti per la pesca del tonno.
Dove si usano attualmente le reti da posta derivanti ?
Le grandi reti da posta derivanti vengono attualmente utilizzate da diversi paesi. Nell'Unione europea, questa tecnica è impiegata nella pesca del tonno da circa 670 pescherecci italiani che pescano pesce spada nel Mediterraneo e da circa 70 pescherecci francesi e 30 pescherecci irlandesi e britannici che pescano tonno bianco nell'Atlantico settentrionale tra giugno e ottobre/novembre. Come abbiamo visto prima, ci sono anche alcune zone di pesca nel Mediterraneo in cui questa tecnica viene utilizzata da pescherecci spagnoli e italiani per la cattura di tonni. Le reti da posta derivanti vengono utilizzate anche per la pesca di piccole specie, come le sardine e le aringhe, il che non pone però alcun problema.
Spadare
Le «spadare» sono particolari reti derivanti (ad imbrocco) che hanno la particolarità di avere un’altezza superiore ai 30 metri., lunghezza superiore a 5 miglia e con maglia in genere superiore a 350 mm. di apertura e filato molto spesso. Le spadare vengono calate in modo da formare delle campanate: viste dall’alto, le spadare formano una sinusoide e devono quindi essere molto lunghe .
Mantenute in superficie tramite dei galleggianti, vanno a formare dei veri e propri sbarramenti in mezzo al mare con inevitabili conseguenze per le specie pelagiche o per le imbarcazioni che si trovano sulla stessa rotta.
La pesca al pesce spada veniva effettuata con delle unità particolari, denominate “passerelle” perché dotate di un lungo pulpito a prua, dal quale veniva lanciato l’arpione, e di un altissimo albero per l’avvistamento da lontano.
Attualmente sono oggetto di polemiche perché oltre ad essere distruttive per la pesca catturano delfini e tartarughe marine che sono specie protette.

Spadara
Approfondimenti:
Si tratta di reti da posta derivanti, quindi non fisse, che vengono calate in mare e lasciate alla deriva, usate per la cattura di grossi pesci pelagici, come diverse specie di tonni, ma soprattutto per il pesce spada, da cui prendono appunto il nome. Sono reti lunghissime, anche fino a venti chilometri, e larghe fino a trenta metri, fatte di nailon molto resistente.
Rispetto ai tradizionali metodi di pesca la differenza è sostanziale: non vengono più usate reti di poche centinaia di metri, bensì autentiche barriere lunghe diversi chilometri, che provocano il cosiddetto “effetto muro”; le moderne spadare di fibre sintetiche inoltre non vengono calate vicino alla costa da piccole imbarcazioni a remi o a vela, bensì da pescherecci con potenti motori che si spostano in mare aperto.
Il loro livello di selettività è molto basso, cosicché, oltre alle cosiddette specie bersaglio, può incapparci di tutto, come ad esempio Tartarughe, piccoli delfini come le Stenelle, ma anche Cetacei molto più grandi come i Capodogli e le Balenottere presenti nel Mediterraneo. Da un’indagine condotta nel 1993 è risultato che solo il 18% circa di pesci catturati, in termini numerici, era costituito da specie bersaglio. Uno studio promosso dall’allora Ministero della Marina Mercantile, accertò nel 1990 e nel 1991 che almeno 30 specie diverse erano incappate nelle reti calate nel Mar Ligure e nel Mar Tirreno. La Commissione Baleniera Internazionale (IWC) calcolò nel 1990 in almeno 8000 all’anno i cetacei vittime delle spadare, esprimendo preoccupazioni sia per il livello “insostenibile” di mortalità delle popolazioni mediterranee di Stenella, che per l’incidenza delle spadare sulla popolazione di Capodogli. In quest’ultimo caso, se tali popolazioni dovessero risultare distinte da quelle atlantiche, il livello di mortalità artificiale sarebbe allora altissimo.
Ma le spadare sono state accusate di arrecare un danno non solo alle cosiddette specie accessorie, ma alle stesse specie di interesse commerciale, sia in termini di aumento dello sforzo di pesca, sia per la cattura sempre più frequente di pesci spada immaturi o sotto misura: in parole povere si pescano pesci di taglia sempre più piccola. Nel Tirreno centrale e meridionale la media dei pesci spada catturati con il sistema del palamito o palàngaro, che fa uso di ami, è compresa tra 12 e 17,5 kg.
Si consideri che la flotta italiana, comprese le piccole barche per i pesci pelagici di dimensioni medie e piccole, era arrivata a circa un migliaio di unità e che la lunghezza media delle spadare era di 12, 5 chilometri, per cui 700 imbarcazioni potevano calare in mare qualcosa come 8500 km di rete, una lunghezza superiore al profilo costiero dell’Italia, Isole comprese.
Contro questo tipo di pesca vi fu dapprima la risoluzione 44/225 del dicembre 1989 delle Nazioni Unite, cui fece seguito a livello comunitario (Regolamento CEE n.345/92 del 28/10/1991) il divieto di usare reti più lunghe di due chilometri e mezzo a partire dal 1° giugno 1992 (divieto praticamente non rispettato a causa della scarsissima redditività di reti così corte) e, successivamente, il regolamento 894 del 29 aprile 1997, che disponeva la messa al bando totale delle spadare a partire dal 1 gennaio 2002 “ per assicurare la protezione delle risorse biologiche marine nonché uno sfruttamento equilibrato delle risorse della pesca conforme all’interesse sia dei pescatori che dei consumatori” (punto 2 del Regolamento (CE) 894/97.
A partire dal 1998 furono varati dei piani per la dismissione e la riconversione delle spadare, con dei contributi economici a sostegno sia degli armatori che degli equipaggi e a questi piani aderirono, non senza polemiche, tutti gli armatori che usavano le spadare, tranne un novantina.
Un recente Decreto del Ministero delle politiche Agricole e Forestali del 27 marzo scorso e una circolare della Direzione Generale Pesca del 10 aprile, hanno riaperto la questione, perché autorizzano anche coloro che avevano beneficiato del cosiddetto “piano spadare” ad aggiungere, al sistema di pesca noto come “ferrettara”, anche le reti da posta fisse, purché lunghe fino a cinque chilometri.
La cosiddetta ferrettara è già una rete da posta di maglia non superiore a 100 mm di apertura, ma non dovrebbe superare i due chilometri di lunghezza e non potrebbe essere usata oltre le tre miglia dalla costa, per catturare specie come le ricciole, gli sgombri, le sardine o le acciughe. Il problema è che, in mancanza di controlli, la circolare potrebbe essere utilizzata per il riutilizzo delle spadare, di lunghezza ben superiore ai cinque chilometri, vanificando di fatto il regolamento comunitario, proprio quando invece sarebbe opportuno intraprendere delle iniziative a livello internazionale per estendere il divieto anche ai numerosi pescherecci nordafricani ( circa 600 tra libici, tunisini, marocchini), che continuano ad usare le spadare. Va sottolineato che è assolutamente indispensabile applicare anche alle risorse del mare, che non sono affatto inesauribili, i principi dell’ecologia e della dinamica delle popolazioni al fine di ottenere uno sforzo di pesca sostenibile dall’ecosistema e quindi una pesca responsabile. Quindi occorre definire quanto di una risorsa può essere prelevato senza arrecare danno alla popolazione animale e quali sono le condizioni che consentono un razionale utilizzo del risorsa stessa, senza intaccarne la capacità di sopravvivenza. Una necessità che dovrebbe essere sostenuta prima di tutto dagli stessi pescatori, perché se si pesca troppo oggi, domani non ci sarà più niente da pescare.
Alalungara
Una certa importanza su scala locale hanno anche le reti da posta derivanti «Alalungara», oggi utilizzate in alcune marinerie della Puglia, della Sicilia e del basso Tirreno da unità da pesca di stazza medio-alta.
Attualmente la regolamentazione prevede dei limiti sulle aree di pesca e sulle dimensioni delle reti; a partire dal 1° gennaio 2002 il loro uso sarà comunque proibito.
E’ una rete da superficie derivante usata raramente al largo per la cattura delle alalunghe. E’ la principale delle reti derivanti, se si esclude la spadara ormai vietata, con una lunghezza massima di duemila metri e con una maglia che non supera i 18 centimetri. L’altezza è compresa tra i 20 e i 30 metri. Nella parte superiore è fornita di galleggianti mentre nella parte inferiore vengono attaccate delle mazzare (pesi) che servono a mantenere la rete verticalmente. Le reti derivanti rivestono una certa importanza in poche marinerie.
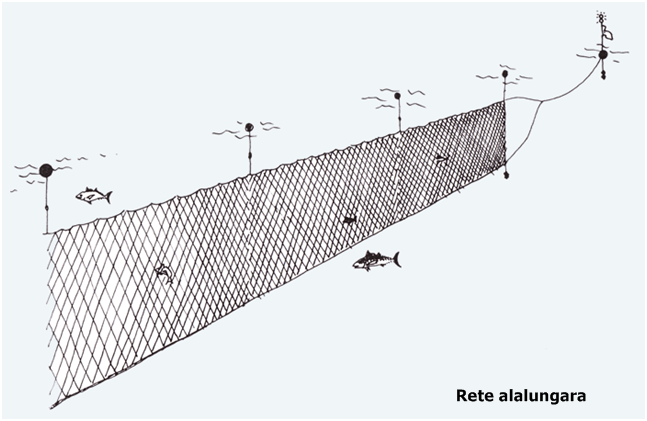
Sistema reti derivanti
Disciplina del sistema reti derivanti
E’ vietato tenere a bordo o effettuare pesca con reti derivanti destinate alla cattura di alcune specie (elencate nell’Allegato VIII dei Regolamenti: tonni, palamite, tonnetti, tombarelli, aguglie, pesci spada, costardelle, corifene, squali, (alcune specie), cefalopodi. Vietato anche lo sbarco delle specie elencate (Reg. CE 1239/98 e Reg. CE 894/97)
E’ vietata la detenzione a bordo di reti o attrezzi di cui sia in modo assoluto proibito l’uso con l’impiego dell’unità. Non è più necessario l’accertamento della condotta vietata esclusivamente durante l’effettivo esercizio dell’attività di pesca, ma sarà sufficiente che venga accertata la presenza a bordo delle reti spadare per contestare la violazione e procedere al sequestro (art. 15 lettere a e b Legge 963/65, come modificata dall’art. 8 del Dlgs. n. 101/2008).
(2).png)
Sistema ferrettare
Una particolare rete derivante è la ferrettara, caratterizzata da dimensioni più piccole rispetto alle derivanti canoniche (la lunghezza massima consentita è di 2,5 km) e da una maglia non superiore ai 100 mm d’apertura, (art. 2, n. 2 del D.M. 21 settembre 2011 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, pubblicato in G.U.n.223 del 24 settembre 2011 che abroga il Decreto 24 maggio 2006).
Sono reti ad imbrocco (una sola pezza) di fibra poliammidica con nodo e possono essere calate a mezz’acqua o con la lima da sugheri in superficie.
Si tratta di un attrezzo relativamente diffuso in Sicilia e nel Basso Tirreno il cui uso è consentito, a decorrere dal 1° gennaio 2012 solo entro le 3 miglia dalla costa (art. 1 del D.M. 21 settembre 2011) Con l’entrata in vigore delle nuove restrizioni, le unità da pesca che impiegano reti derivanti e/o la ferrettara potranno comunque avvalersi degli altri sistemi di pesca previsti in Licenza, limitando il danno economico derivante dalla riconversione obbligatoria. I dati mostrano che già oggi il 95% delle unità che operano con le reti derivanti e il 99% di quelle che operano con la ferrettara utilizzano parallelamente altri sistemi di pesca.
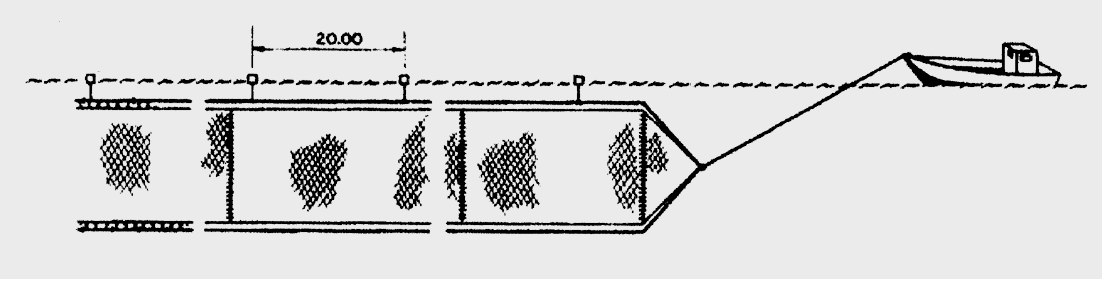
Sistema Ferrettara
- A seconda delle specie bersaglio fanno parte di questo sistema di pesca:
-
menaide
-
piccola derivante
-
sangusara
-
bisantonara
-
alacciara
-
bisara
-
bogara
-
sgomberara
-
occhiatara
-
palamitara
In particolare, la «Menaide» (o Tratta): è una rete da posta derivante molto antica che generalmente viene utilizzata per la pesca del pesce azzurro ed il meccanismo di cattura è quello delle reti ad imbrocco. È formata da diversi segmenti quadrati riuniti in modo da formare un lungo rettangolo, alto da 12 a 20 metri, che si cala verticalmente, grazie ai piombi fissati nella sua parte inferiore e ai galleggianti situati in quella superiore. Può funzionare in modo vagante (o alla deriva, perché in balia della corrente) o manovrata dalle unità per circondare un banco di pesci. Con essa si catturano i soliti pesci azzurri, nonché Palamite e Tonnetti.
Nella zona del Catanese è abbastanza diffusa e viene utilizzata una piccola menaide per la cattura delle acciughe (masculini) che vengono commercializzate freschissime.
La «Palamitara»: è una rete usata raramente al largo per la cattura dei Palamiti, Tombarelli e Allitterati.Questo tipo di pesca è in disuso, e la rete viene soprattutto calata sotto costa per la cattura dei Palamiti.
- E’ vietata, ai sensi della normativa comunitaria vigente, la cattura con l’attrezzo “ferrettara” delle seguenti specie:
Tonno bianco: Thunnus alalunga; Tonno rosso: Thunnus thynnus; Tonno obeso: Thunnus obesus; Tonnetto striato: Katsuwonus pelamis; Palamita: Sarda sarda; Tonno pinna gialla: Thunnus albacore; Tonno pinna nera: Thunnus atlanticus; Tonnetti: Euthynnus spp.; Tonno del Sud: Thunnus maccoyii; Tombarelli: Auxis spp.; Pesce castagna: Brama rayi; Aguglie imperiali: Tetrapturus spp.; Makaira spp.; Pesci vela: Istiophorus spp.; Pesce spada: Xiphias gladius; Costardelle: Scomberesox spp.; Cololabis spp.; Corifene: Coryphoena spp.; Squali: Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae; Carcharhinidae; Sphymidae; Isuridae; Lamnidae; Cefalopodi: tutte le specie.
- Sistema Ferrettara (peculiarità):
-
Sono particolari reti derivanti ad imbrocco (una sola pezza), di fibra poliammidica con nodo;
-
Possono essere calate a mezz’acqua o con la lima da sugheri in superficie.
-
Ha dimensioni più piccole rispetto alle derivanti canoniche (la lunghezza massima consentita è di 2,5 km) e da una maglia non superiore ai 100 mm d’apertura.
- Sistema diffuso in Sicilia e nel Basso Tirreno il cui uso è consentito, a decorrere dal 1° gennaio 2012, solo entro le 3 miglia dalla costa per la cattura di ricciole, occhiate, sgombri, salpe, boghe, alaccie, sardine ed acciughe.
Disciplina del sistema ferrettara
A decorrere dal 1° gennaio 2012, l'impiego dell'attrezzo ferrettara è consentito esclusivamente entro le 3 miglia dalla costa (per la cattura di ricciole, occhiate, sgombri, salpe, boghe, alaccie, sardine ed acciughe) non può essere di lunghezza superiore a 2,5 Km. e deve avere una maglia non superiore a 100 mm. di apertura (D.M. 21/09/2011).
(1).png)
D.M. 21 settembre 2011 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, pubblicato in G.U.n.223 del 24 settembre 2011 che abroga il Decreto 24 maggio 2006).
Sistema palangari
La pesca con gli ami è uno dei sistemi più diffusi ed antichi del mondo, sia per la facilità di costruzione dell’attrezzo (un pezzo di ferro opportunamente piegato e appeso ad un filo), sia per la semplice manovrabilità ed adattabilità a tutte le condizioni ambientali.
Il «palangaro» è l’attrezzo ad ami più usato a livello professionale: nelle sue linee essenziali esso è composto da una serie di lenze (braccioli) di cui una estremità termina con un amo e l’altra è collegata ad un cavo (trave) lungo anche diversi chilometri. I braccioli vengono legati al trave ad intervalli regolari, pari a circa 2 volte la loro lunghezza.
Generalmente, la pesca del palangaro viene effettuata di notte: si cala verso il tramonto e si salpa all’alba. Durante il giorno si allestiscono le ceste e si innescano gli ami. Gli ami hanno diverse forme e dimensioni in relazione alla specie da catturare.
I palangari possono essere calati in prossimità del fondo e qui ancorati (palangari fissi) per la cattura di specie demersali (naselli, gronchi, corvine, rombi, palombi, saraghi) oppure possono essere calati a mezz’acqua o in superficie per la cattura dei grossi pesci pelagici (tonnidi e pesce spada).
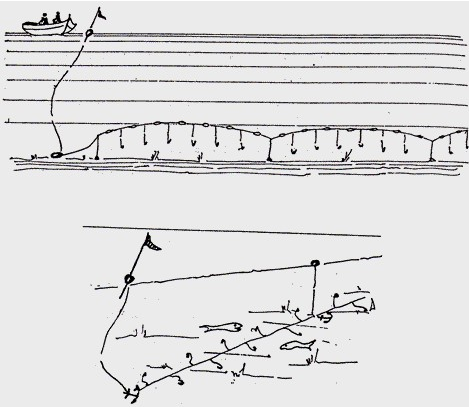
.png)
Palangari fissi Palangari derivanti
In quest’ultimo caso sono lasciati alla deriva in balia delle correnti e dei venti (palangari derivanti).
I due tipi si differenziano tra loro, oltre che per il metodo di pesca, anche per la lunghezza dei braccioli e la grandezza degli ami: piccoli per i parangali fissi, grandi per quelli derivanti.
Nella pesca professionale per ottenere una cattura che ricompensi del lavoro sono necessari moltissimi ami; si calano quindi varie “ceste di ami”.
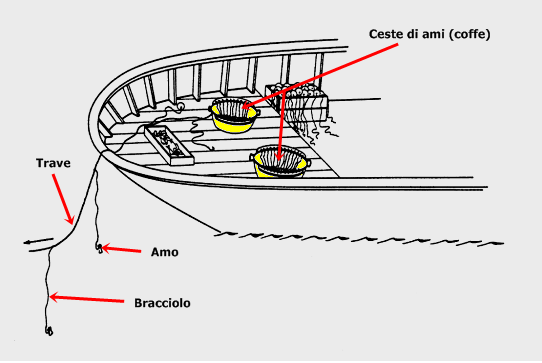
.bmp)
Schema sistema palangari (coffe)este di ami (Coffe)
La cesta è in pratica la "unità di palangaro". Il recupero è manuale, quindi lungo, faticoso e pericoloso. Oggi sono stati introdotti strumenti atti a ridurre la fatica e i tempi di lavoro in modo che si possano calare più ami e quindi si possa avere un rendimento superiore.
Si hanno infatti, strumenti per l’innescamento automatico mentre si cala con continuità e strumenti che permettono il recupero più o meno automatico (salpapalangari).
In generale la pesca con il palangaro, è una pesca che si effettua con limitati consumi energetici ed è molto rispettosa delle risorse che si stanno sfruttando. E’ infatti, un metodo di pesca fortemente selettivo.
Approfondimenti:
Il successo di questo tipo di pesca è legato in modo particolare al numero degli ami che ogni barca riesce a calare in mare: lo sviluppo di questi attrezzi, che richiedono un basso consumo energetico, è legato essenzialmente all’automazione di tutte le fasi operative di escamento, cala e recupero.
Attualmente, in quasi tutte le marinerie italiane, queste operazioni, tranne il recupero del cavo principale vengono svolte manualmente anche se, da diversi anni, sui mercati internazionali sono comparse macchine salpalangari completamente automatizzate che assolvono, in particolare per il palangaro da fondo, a tutte e tre le suddette operazioni.
L’attività ha carattere prettamente stagionale (Maggio-Giugno) in quanto legata al passaggio dei tonni nel Canale di Sicilia. Ciò comporta l’effettuazione di bordate di pesca assai lunghe e di durata variabile.
Un tipico palangaro derivante da superficie per la cattura di pesci spada, tonnidi ecc. è costituito da un trave pressoché simile a quello da fondo. I braccioli invece sono molto più lunghi, da 5 a 10metri, e sono formati in due parti: quella unita al trave è, come questo, in nylon o poliestere anche se di diametro un pò’ inferiore mentre la seconda parte, quella unita all’amo, è quasi sempre in acciaio.
Le due porzioni sono unite tra loro tramite un “tornichetto” che ne impedisce l’attorcigliamento al dimenarsi della preda (V. figura a lato).
Se tale tipo di pesca è finalizzato alla pesca del tonno, l’attrezzatura usata consta di ami, opportunamente escati e l’imbarcazione ha un equipaggio formato dal comandante e da nove marinai. Un tipico palangaro fisso da fondo è costituito da un trave generalmente in nylon o poliestere del tipo ritorto o treccia. I braccioli, quasi sempre in nylon del tipo monofilo, hanno una lunghezza che va da 50 a 150 cm.
La pesca del tonno è caratterizzata da un’elevata aleatorietà del quantitativo di pesce catturato e pertanto, al fine di elevare il rendimento dell’attrezzatura, è necessario calare un elevato numero di ami con un conseguente forte aumento del tempo di controllo.
Dato l’elevato valore economico del pescato, molte volte, alcune unità, che operano nella stessa zona di pesca si alternano nel rientro in porto lasciando la propria attrezzatura in acqua; il peschereccio che resta continua a pescare, controllando contemporaneamente a distanza l’attrezzatura abbandonata, mentre quello che rientra porta in banchina sia le sue catture che quelle dell’altro.
Una tipica bordata ha la durata di quattro giorni ed ha inizio verso la mezzanotte della domenica per terminare all’alba del giovedì; si scarica il proprio pesce e quello dell’eventuale nave restata in zona per il controllo, si fa rifornimento di viveri e la sera stessa si riparte.
- Palangari (peculiarità):
-
Il palangaro è un attrezzo che impiega simultaneamente più ami.
-
È costituito da un cavo principale, chiamato “trave”, lungo anche diverse centinaia di metri. I braccioli con gli ami sono fissati al trave a distanza regolare.
-
gli ami hanno diversa forma e dimensione ed esche varie in relazione alle specie da catturare.
-
sono calati in prossimità del fondo e qui ancorati (palangari fissi).
-
gli ami vengono calati a mezz’acqua o in superficie per la cattura dei grossi pelagici (tonni e pesce spada). (palangari derivanti).
-
E’ un metodo di pesca fortemente selettivo che può creare però problemi per quanto riguarda:
-
la cattura accessoria di specie protette (mammiferi, tartarughe, squali, uccelli marini);
-
la cattura di individui di specie commerciali al di sotto della taglia minima
Segnalazione dei palangari
I palangali debbono essere muniti di “segnali” costituiti da galleggianti di colore giallo, distanziati tra loro non più di 500 metri. Le estremità dell'attrezzo debbono essere munite di galleggianti di colore giallo, con bandiera di giorno, e fanale di notte, dello stesso colore; tali segnali debbono essere visibili a distanza non inferiore a mezzo miglio (D.P.R. 1639/68).
Estremità dell’attrezzo segnalate di "giorno" con boe gialle e bandiere
visibili ad una distanza non inferiore a mezzo miglio
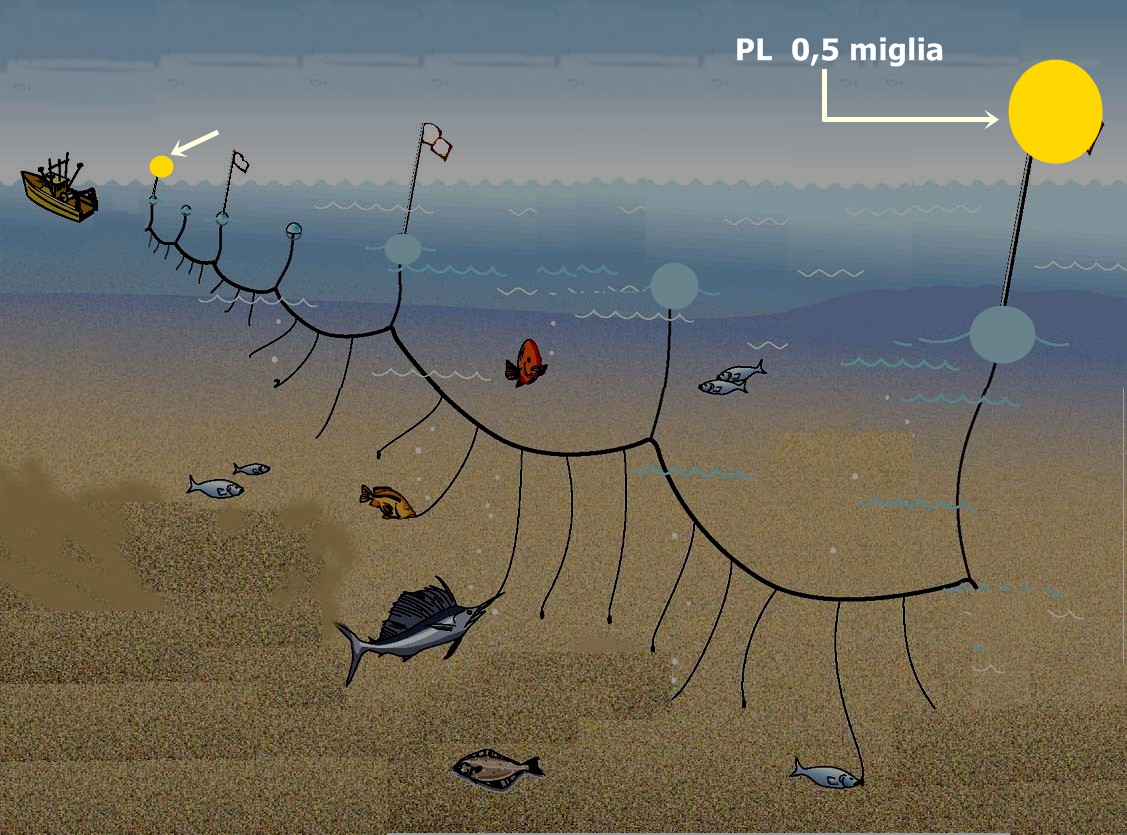
Estremità’ dell’attrezzo segnalate di "notte" con fanali gialli
visibili ad una distanza non inferiore a mezzo miglio.
- Reg.(CE) 356/2005, modif. dal Reg. (CE) 1805/2005: posizionamento targhette e boe palangari.
► Attrezzi calati oltre le 12 miglia:
-
targhette fissate a entrambe le estremità di ciascun attrezzo fisso;
-
per gli attrezzi di estensione superiore a un miglio nautico targhette fissate a intervalli regolari non superiori a un miglio nautico;
- boe segnaletiche intermedie collocate a distanze non superiori a 5 miglia nautiche (per gli attrezzi di estensione superiore a 5 miglia).
Segnalazione dei palangari di lunghezza superiore a 5 miglia nautiche
calati oltre le 12 miglia dalla costa: posizionamento delle targhette
- Come valutare la lunghezza di un palangaro: si conta il numero degli ami di un contenitore, si misura la distanza fra due braccioli contigui e si moltiplicano le due grandezze. Oppure si valuta la distanza fra segnali direttamente in mare.
Disciplina del sistema palangari
- Reg. (CE) 1967/2006
Palangaro di fondo:
-
È vietato detenere a bordo o calare più di 1.000 ami per persona a bordo, entro il limite complessivo di 5.000 ami per peschereccio.
- In deroga, se le bordate di pesca superano i 3 giorni si può detenere a bordo un massimo di 7.000 ami per peschereccio.
Palangaro di superficie (derivante):
- È vietato detenere a bordo o calare più di:
-
2.000 ami per nave per i pescherecci dediti alla pesca di tonno rosso (Thunnus thynnus), quando questa specie rappresenta almeno il 70% delle catture in peso vivo misurate dopo la cernita;
-
3.500 ami per nave per i pescherecci dediti alla pesca di pesce spada (Xyphias gladius), quando questa specie rappresenta almeno il 70% delle catture in peso vivo misurate dopo la cernita;
- 5.000 ami per nave per i pescherecci dediti alla pesca di tonno bianco (Thunnus alalunga), quando questa specie rappresenta almeno il 70% delle catture in peso vivo misurate dopo la cernita.
Nel caso di bordate di pesca superiori ai 2 giorni si può detenere a bordo un ugual numero di ami di riserva.
- Reg. (CE) 1559/2007
La pesca del tonno rosso con palangari derivanti effettuata da pescherecci di lunghezza superiore a 24 metri è vietata nel periodo dal 1 giugno al 31 dicembre.
E’ vietato l’uso di aeroplani o elicotteri per la ricerca del tonno rosso.
- Reg. (CE) 40/2008
La pesca del pesce spada in Mediterraneo è vietata dal 15 ottobre al 15 novembre 2008.
- Problemi principali dei palangari:
- cattura accessoria di specie protette (mammiferi, tartarughe, squali, uccelli marini);
- cattura di individui di specie commerciali al di sotto della taglia minima commerciale
Gli ami dei palangari non sono selettivi anche gli individui di pesce spada o tonno rosso di piccole dimensioni riescono ad abboccare agli ami più grandi.
Studi recenti hanno cercato di limitare la cattura di giovanili modificando la forma degli ami (di forma circolare); più recentemente sono stati impiegati i “pingers” (strumenti acustici) come deterrente per i delfini (i risultati non sono così’ soddisfacenti poiché’ i delfini apprendono per cui il segnale emesso dai pingers dopo le prime volte risultava essere addirittura un attrattiva per i delfini).

Pingers
I palamiti si usano oltre che al limite fra i fondi coralligeni e fangosi, anche in acque più profonde come sulla scarpata continentale fra i 200 e i 500 metri o più. Caratteristica principale: questi attrezzi rientrano nell’elenco di quelli della “Piccola pesca”.
Sistema lenze
Meno usate professionalmente rispetto ai palangari le «lenze», che costituiscono una tecnica accessoria usata prevalentemente nel Meridione (isole comprese) in alternanza con attrezzi da posta o palangari. La caratteristica particolare di questo sistema di cattura sta nella presenza continua dell'uomo, nella fase operativa. Le lenze, a differenza dei palangari, sono infatti calate e tenute sotto controllo continuo da parte del pescatore. Appena un pesce abbocca si inizia il recupero, agendo in modo da garantire che il pesce non possa liberarsi.
Le lenze sono caratterizzate da un cavetto su cui sono legati uno o più ami, o ancorette. La preda viene attirata dall'esca che può essere naturale, artificiale, ad attrazione olfattiva o luminosa. Le esche naturali impiegate sono costituite in genere da pezzi di sardine, di calamari o di altri molluschi freschi e da anellidi. L'esca artificiale invece può essere ad attrazione olfattiva o luminosa, cioè può attirare la prede grazie ad un richiamo odoroso oppure visivo. Le lenze si distinguono fra loro per le modalità con le quali vengono impiegate. Possono essere trainate a velocità appropriata per la pesca di lampughe, calamari o altri pesci da zuppa, ovvero controllate manualmente o tramite una canna da pesca; in quest’ultimo caso i target prevalenti sono polpi e totani. In relazione al loro impiego si dividono in:
-
lenze fisse (a mano e a canna)
-
lenze a traino
-
totanara
.bmp)
- Disciplina del sistema a lenze
Decreto 27/1/1995:
E’ consentito l’uso di canne a lenze fisse o da lancio da terraferma a coloro che utilizzano la pesca da unità con canna a mulinello e con bolentino da fondo armato con max 3 ami.
D.M. 27/7/98:
Può essere utilizzata da chi ha in licenza: sistema lenze o attrezzi da posta:
-
max 1 per pescatore;
-
fonte luminosa ammessa
- Sistema Lenze (peculiarità):
-
La caratteristica particolare di questo sistema di cattura sta nella presenza continua dell'uomo, nella fase operativa.
-
Le lenze sono caratterizzate da un cavetto su cui sono legati uno o più ami, o ancorette. La preda viene attirata dall'esca che può essere naturale, artificiale, ad attrazione olfattiva o luminosa.
-
Possono essere trainate a velocità appropriata per la pesca di lampughe, calamari o altri pesci da zuppa, ovvero controllate manualmente o tramite una canna da pesca; in quest’ultimo caso i target prevalenti sono polpi e totani.
- In relazione al loro impiego si dividono in: lenze fisse (a mano e a canna), lenze a traino e totanara
Lenze: tipologia
- A mano
Essendo tenuta a mano dal pescatore, questa lenza è sempre sotto il controllo diretto dell'operatore. Può essere utilizzata con o senza canna ed è costituita da una cavetto robusto, di lunghezza variabile e dotato di un piombo di zavorra. Per la pesca in acque profonde le lenze vengono normalmente accoppiate ad un “mulinello”.
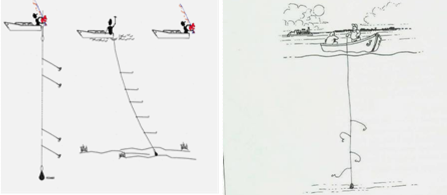
Sistema lenze a mano
- Ancorate
In genere sono lenze ancorate sul fondo provviste di più ami e di un galleggiante di segnalazione. Vengono lasciate in mare per un certo periodo, poi il pescatore torna sul posto e recupera la lenza a partire dal galleggiante.
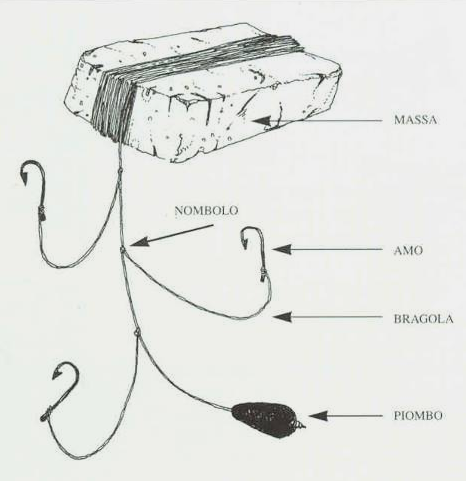
Togna
- Trainate
Le lenze trainate sono quelle, composte da uno o più ami, rimorchiate da imbarcazioni. L'esca, per effetto del traino, imita il movimento di un pesce ed inganna i pesci predatori che abboccano.
Possono essere tenute direttamente a mano o, meglio, utilizzando dei buttafuori. I buttafuori permettono di calare più lenze contemporaneamente e sono in grado di evidenziare la cattura del pesce.
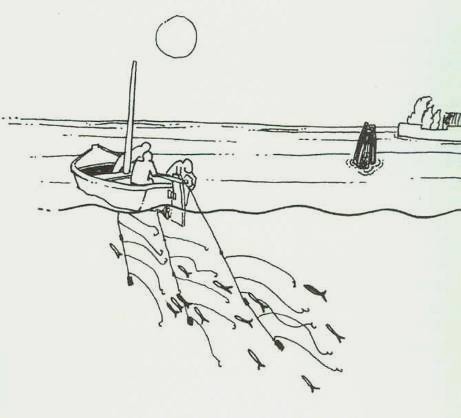
Correntina
- Totanara
Attrezzo da pesca destinato alla cattura di molluschi cefalopodi (totani, seppie, calamari). La pesca al totano è praticata nelle ore notturne, preferibilmente quando non c’ è la luna, su un fondale variabile dai 20 ai 200 metri di profondità.
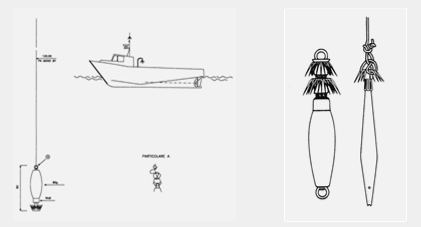
Sistema totanara
La lenza è costituita da un filo alla cui estremità è fissata la «totanara», un cilindro metallico o di piombo con una corona di ami appuntiti, dotato di una luce intermittente alimentata da piccole pile: nelle profondità marine il totano, animale che di notte va a caccia di piccoli pesci, scambia la luce artificiale per la scia di una preda in fuga, e afferrandosi all’ attrezzo viene catturato dagli ami.
Sistema arpione
Tale sistema comprende gli attrezzi attualmente denominati come “arpione”, “fiocina”, “asta e specchio per ricci” e “rastrello per ricci”.
La pesca con arpioni e fiocine, strumenti che feriscono od uccidono il pesce che si vuole catturare, molto nota in passato oggi è fortemente ridimensionata e limitata alla cattura di poche specie.
- Per quanto riguarda l’ «arpione», che ha un terminale appuntito, è utilizzato per la cattura di organismi grandi: la specie che più frequentemente viene catturata nei nostri mari con tali strumenti, è il pesce spada.
.png)
Arpione
La cattura del pesce spada infatti, avviene con il palangaro derivante (o le reti da posta derivanti calata principalmente per la cattura di tonnidi, alalonghe) o con l’arpione con le tradizionali barche caratteristiche per la presenza di un altissimo albero con “coffa” e di un lungo "ponte prodiero" (prolungamento della prua). Il pesce è avvistato da un marinaio (che esplora il mare in cima all’albero e guida poi l’inseguimento) e viene arpionato da un altro pescatore che lancia l’arpione dalla estremità del ponte. Con tale metodo di pesca si catturano solo pesci spada adulti, a differenza del palangaro che cattura anche i giovani.
Approfondimenti:
La pesca con l'arpione per la cattura del pesce spada è ancora praticata nello stretto di Messina. Questa pesca avviene nel periodo della riproduzione che nello Stretto di Messina va da maggio ad agosto, quando gli esemplari si avvicinano alla costa. La pesca con l'arpione si pratica con mare molto calmo, per facilitare l'avvistamento dei pesci.
Si tratta di un sistema conosciuto fin dall'antichità, quando le imbarcazioni erano provviste di un albero di avvistamento molto alto, detto "coffa" e di una lunga passerella prodiera. Il "pisci spata" viene infatti individuato a vista, da un “marinaio” esperto del tratto di mare in cui si naviga e del comportamento del pesce. Dopo l'avvistamento la barca deve iniziare l'inseguimento per portarsi a una distanza utile per il lancio dell'arpione: compito di un altro “marinaio” appostato sulla passerella di prua. Questo sistema di pesca si caratterizza soprattutto per la selettività, dato che è possibile scegliere di catturare solo animali adulti che possono raggiungere, considerando anche la spada, i 4-5 m di lunghezza e un peso di 300-350 kg. Il periodo di pesca è quello a cavallo della riproduzione, da maggio ad agosto nel Mediterraneo, quando i pesci spada si avvicinano alla costa
(1).png)
Barca tradizionale per la cattura del pesce spada
- La «fiocina» invece è uno strumento armato di denti usato da un singolo pescatore per la cattura di pesci piccoli quali anguille, molluschi, cefalopodi, spugne. La cattura avviene con un colpo rapido della fiocina che si infilza con i suoi denti nell’animale che si vuole catturare. I denti della fiocina sono tali che trattengono il pesce catturato e ne permettono il recupero. E’ consentita l’uso di una “lampada (o lampara)”.
(1).png)
Barca tradizionale per la pesca con lampara e fiocina
- La cattura del riccio di mare può avvenire mediante “asta e specchio” o “rastrello”.
Disciplina del sistema asta e/o rastrello per ricci (D.M. 20/01/1995)
E' consentita la pesca professionale del riccio di mare con la sola utilizzazione dei seguenti attrezzi da raccolta:
- asta a specchio e rastrello.
I pescatori subacquei professionali possono effettuare la pesca del riccio di mare in immersione e solo manualmente.
Il pescatore professionale non può catturare giornalmente più di 1.000 esemplari: la taglia minima di cattura del riccio di mare non può essere inferiore a 7 centimetri di diametro totale compresi gli aculei. Tale pesca è vietata nei mesi di maggio e giugno.
(1).png)
Approfondimenti:
Nella “Regione Sardegna”, la raccolta dei ricci di mare può essere esercitata:
-
dall’unità, anche con l’ausilio dello “specchio” o batiscopio mediante asta tradizionale (“cannuga”) e/o coppo;
- mediante immersione, a mano o con l’ausilio di qualsiasi strumento corto atto a staccare il riccio dal substrato.
E’ vietata la raccolta del riccio di mare mediante attrezzi trainati con unità o anche a mano mediante mezzi meccanici (strumenti in ferro), compresi i rastrelli.
La taglia minima di cattura è di 50 mm esclusi gli aculei; ogni esemplare di taglia inferiore prelevato in qualsiasi circostanza, da qualunque tipologia di imbarcazione e da qualsiasi categoria autorizzata alla pesca, anche non appartenente a quella dei pescatori professionali di echinodermi, dovrà essere immediatamente restituito al mare.
Il pescatore professionista, accompagnato da assistente a bordo dell’unità, può raccoglierne giornalmente 6 ceste (dimensioni: altezza 35 cm, lunghezza 60 cm, larghezza 50 cm), equivalenti, per due unità lavorative, a circa 3000 esemplari; se il professionista non è accompagnato da un assistente può raccogliere giornalmente 3 ceste pari a circa 1500 ricci.
Il pescatore sportivo, per uso personale, può raccogliere esclusivamente durante il periodo consentito dal calendario, un numero massimo di 50 ricci al giorno.
La stagione di pesca del riccio di mare per l'anno 2008-2009 è consentita dal 1 novembre 2008 al 13 aprile 2009.
Per l'esercizio della pesca dei ricci è necessario richiedere l'autorizzazione all'Assessorato regionale dell'Agricoltura. Il servizio pesca rilascerà le autorizzazioni in base alla disponibilità del numero di licenze non assegnate per ciascuna capitaneria di porto.
E' necessario richiedere il rinnovo prima della scadenza.
Altri attrezzi da pesca
Innumerevoli sono i metodi di pesca che non rientrano tra quelli fino ora descritti e che i pescatori hanno usato ed usano ancora. Basti pensare alla pesca senza strumenti, direttamente a mano, alla pesca con l’ausilio di animali. Tra gli strumenti più noti troviamo:
- Reti da lancio
Le reti da lancio sono quelle costituite da un telo di rete, destinate con moto dalla superficie al fondo a catturare i pesci. Sono reti poco usate professionalmente per lo scarso reddito che possono dare e per la fatica che richiedono.
La rete era lanciata su un branco di pesci individuato ad occhio. Per azione idrodinamica la rete si apriva mentre scendeva sul fondo trascinatavi dalla gravità. Lentamente poi iniziava il recupero facendo in modo che il pesce trattenuto sotto la rete restasse impigliato nei risvolti che la rete stessa determinava quando era salpata.

Rete da lancio (Rezzaglio)
- Reti da raccolta
Le reti da raccolta sono quelle costituite da un telo di rete di varia grandezza e forma, con o senza intelaiatura di sostegno, destinate, col moto dal fondo alla superficie, a catturare animali marini. Sono reti poco usate perché poco redditizie. Sono reti usate soprattutto sotto costa. Hanno maglie di dimensioni diverse a secondo la specie che si vuole pescare.
Tra le reti da raccolta troviamo la “Quadra”, che è la più grande delle reti da raccolta. Si tratta di un impianto fisso in cui la rete, l’attrezzo da pesca, è la parte minore. Generalmente consiste di una capanna (sulla terra ferma) da cui si manovra la rete.
La rete è calata e salpata con argani manuali o meccanici che tramite rinvii agendo sui quattro pali che ne assicurano l’apertura, permettono di alzarla a di abbassarla. Il pesce catturato è generalmente prelevato con il coppo o con altri attrezzi.
(1).png)
Rete da raccolta (Quadra)
La “Bilancia” è più piccola della quadra ed è la versione portatile di questa. L’apertura sul piano orizzontale, è assicurata da due pertiche (in legno o acciaio) a croce che vanno ai quattro angoli della rete che è quadrata. Per calarla e salparla si agisce sull’incrocio tra le due pertiche. In qualche caso la bilancia può essere tenuta aperta anziché dalle pertiche da un’intelaiatura rigida (e smontabile) armata sui bordi della pezza quadrata. La bilancia può essere usata a terra o da bordo di natanti. In pratica è usata solo a livello sportivo.
.png)
Bilancia
Il “Coppo” può essere considerato anch’esso una rete da raccolta anche se le sue dimensioni sono molto piccole. Come attrezzo da pesca è poco usato, mentre il suo uso è frequente come ausilio per il recupero del pesce catturato con altri attrezzi da pesca (rete a circuizione). Il coppo ha svariate forme. La più nota è quella formata da un cerchio, da una rete che forma un sacco e da un manico che serve per manovrarlo.
- Pesca con piconi e martelli
Spesso si hanno organismi marini che o vivono all’interno di massi sul fondo marino o che sono a questi ultimi ben fissati da rendere necessario per staccarli, l’uso di picconi e martelli. Si tratta naturalmente di pesche effettuate da palombari su specie che hanno un alto valore economico se si tratta di professionisti. I martelli e i picconi sono usati ad esempio per il prelievo del corallo, quando si adopera con il palombaro; la Pesca del Corallo viene effettuata soprattutto nei mari caldi del basso Mediterraneo e del Mar Rosso. Questa pesca distrugge e cambia il fondo marino.
- Ingegno
Per la cattura industriale del “corallo” è spesso usato l’ingegno. Si tratta di un attrezzo da traino che, tirato a velocità opportuna, rompe il corallo e i rami staccati, almeno in parte restano impigliati sugli sfilacci o nei pezzi di rete che sono trascinati sul fondo appesi alla parte rigida dell’ingegno stesso. L’ingegno può essere formato da due sbarre di legno duro e zavorrato unite tra loro a “croce di S.Andrea” a cui sono attaccati i vari pezzi di materiale tessile su cui si impigliano i rami di corallo staccati dai bracci della croce.
(1).png)
- Pesca con fonti luminose
La luce è stata ed è utilizzata frequentemente per la cattura di organismi marini. Basti pensare alla rete a circuizione chiamata anche “lampara” . Come principio è sfruttato il potere di attrazione che la luce ha su alcune specie. La luce è prodotta da lampade che attingono energia da generatori elettrici azionati da motori Diesel o da lampade a gas liquido o a petrolio. Generalmente le lampade vengono tenute fuori dall’acqua, ma non mancano casi di lampade immerse per poter attirare pesce da profondità superiori. Questa pesca è effettuata solo di notte, soprattutto nelle notti senza luna quando è più facile la raccolta sotto le lampade. Si cattura principalmente pesce azzurro e celopodi.
- Pesca con l'elettricità
E’ un metodo di cattura del pesce che sfrutta il particolare comportamento degli organismi acquatici alla presenza di un campo elettrico.
In Italia la legge ne vieta l’uso per la tutela delle risorse biologiche e dell’attività di pesca. La pesca con fonti elettriche si effettua mediante l’impiego “diretto” e quello “indiretto”.
Il primo metodo è quando l’organismo è attratto e paralizzato dall’anodo, un fenomeno conosciuto col nome di galvanonarcosi e con una pompa immersa nel mare è trasportato a bordo.
Il secondo invece è quando si immette la corrente elettrica in uno degli attrezzi già conosciuti ed appositamnete modificato. Così si può avere dal campo elettrico l'attrazione verso l'amo del palangare; oppure da una barca generare la corrente verso i due poli immersi a prua e a poppa in mare, mentre una rete circuisce il branco di pesci; infine si può provocare agli elettrodi un campo energetico davanti alla bocca della rete a strascico, così da convogliare i pesci all’interno ed impedire la eventuale fuga agli altri.
I “sistemi” di cattura nei mari italiani e nel Mediterraneo hanno subito una costante evoluzione, specialmente in questi ultimi decenni; altri invece professionalmente e commercialmente non rappresentano più che un fatto puramente storico e folcloristico, privo di una reale applicazione in mare.
Selettività degli attrezzi
La conoscenza delle caratteristiche di selezione degli attrezzi da pesca sulle diverse specie ittiche riveste un ruolo importante in merito alle scelte necessarie per evitare uno sfruttamento eccessivo delle risorse biologiche marine.
In particolare. la selettività delle reti al “traino” rappresenta un aspetto di notevole importanza nella gestione delle risorse demersali. Infatti, soprattutto nella pesca al traino vengono catturati grandi quantitativi di individui di piccola taglia, anche se di scarso valore commerciale. Ciò è dovuto alla ridotta dimensione delle maglie dell'attrezzo utilizzato.
La regolamentazione della maglia è quindi una misura indispensabile per salvaguardare le forme giovanili.
Una buona gestione della pesca richiede che gli attrezzi catturino gli individui adulti (grandi) e permettano ai giovani (piccoli) di fuggire. L'attrezzo, quindi, dovrebbe essere in grado di selezionare la cattura in funzione della taglia (lunghezza o circonferenza) ottimale del pesce.
E' infatti la taglia del pesce che determina la possibilità di fuga attraverso le maglie della rete, o nuotando fuori dell' attrezzo.
La selettività degli attrezzi al traino viene controllata fissando la dimensione minima della maglia della rete, in particolare di quella del sacco.
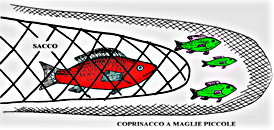
Teoricamente, per ogni specie, dovrebbe essere garantita la possibilità di fuga agli individui di dimensioni inferiori alla taglia di prima maturità. L'obiettivo principale è ridurre la mortalità dei pesci sotto questa taglia, nelle operazioni di pesca.
La pesca demersale nel Mediterraneo è caratterizzata dalla multispecificità delle catture e dell'ampio intervallo di taglie della maggior parte delle specie catturate, per cui la determinazione della maglia ottimale, spesso è il frutto di un compromesso che tiene conto di questa pluripresenza.
Le ricerche sulla selettività degli attrezzi da pesca permettono di conoscere, per ogni specie, le taglie effettivamente catturate dall'attrezzo considerato, in funzione della dimensione di maglia usata.
In seguito a tali studi il legislatore è in grado di fissare la dimensione minima della maglia sulla base delle taglie minime catturabili, che risultano dagli studi biologici sulle diverse specie commerciali.
Più in generale, gli studi sulla selettività degli attrezzi puntano a migliorare le conoscenze anche su altri parametri dell'attrezzo che hanno effetti trascurabili sulla selettività.